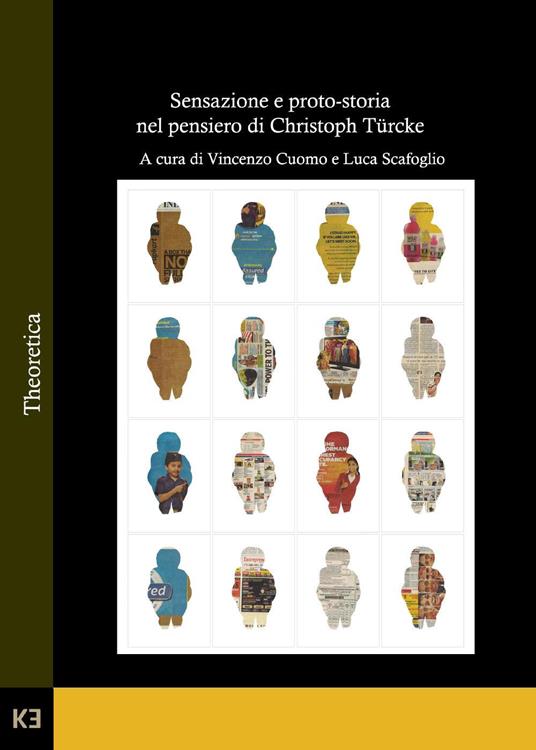I quindici contributi di Sensazione e protostoria inaugurano lo stato dell’arte sulla filosofia di Christoph Türcke. Il volume da un lato permette di fare il punto su un autore atipico, la cui voce è spesso stata controcanto rispetto alle tendenze più recenti della filosofia; dall’altro questo fare il punto significa anche intessere dialoghi che non intendono limitarsi al mondo accademico, ma che cercano di dare una descrizione dei problemi della contemporaneità; in ultimo, e proprio dati i due precedenti, è anche il testo perfetto per essere introdotti al pensiero di questo autore.
Il libro è diviso in due sezioni, alla quale se ne aggiunge una terza che include contributi di Türcke stesso. La prima parte (contributi di V. Cuomo, T. Cavallo, H. Giessler Furlan, A. Pirolozzi, V. Hösle – alle cui critiche Türcke risponde in questo stesso volume –, K. Wiedermann, E. Guerreiro B. Losso, L. Scafoglio) è intitolata “Trauma, coazione a ripetere, sacrificio”. In essa vengono presentate le linee guida del pensiero di Türcke, introducendo alle basi della sua originale antropologia filosofica, influenzata da Theodor Adorno e Sigmund Freud, e offrendo numerosi spunti per nuovi dialoghi possibili, come quelli con René Girard, Villem Flusser, Friedrich Nietzsche o Arnold Gehlen, tutti a vario titolo presenti. Nella seconda parte, “Sensazione, educazione, genere” (contributi di G. Schweppenhäuser, A. A. S. Zuin, W. Bock, S. Dierks, L. Azavedo Rodrigues & M. Norberto Farias, R. Duarte, L. Nacif) si trova invece la dimensione più direttamente politica di Türcke, vale a dire le sue proposte per una riforma dell’educazione e le sue critiche a tendenze attuali della società tardocapitalista, inclusi interventi su come il suo apparato concettuale possa essere impiegato produttivamente in questioni da lui non direttamente affrontate.
C’è una considerazione di Cuomo nelle prime pagine del testo che offre uno spunto importante: uno dei problemi di affrontare filosoficamente la contemporaneità è il nostro essere ancora legati a strumenti concettuali novecenteschi. Possiamo aggiungere che un volume su un autore vivente porti il lettore a interrogarsi su cosa significhi, oggi, essere un “filosofo contemporaneo”. Nel caso specifico, la risposta di Türcke è duplice, e implica un inserirsi all’interno di un’eredità filosofica, nel momento stesso in cui la si revitalizza nel confronto con una realtà storica successiva. Türcke riprende infatti da “tre campi dati per morti: teologia, psicoanalisi e teoria critica” (p. 423), modelli di pensiero che prevedono una dimensione di profondità storica: il loro impiego viene infatti declinato in senso archeologico, seguendo un “reciproco rinvio di preistoria e modernità” che è anche portatore di una loro nuova configurazione (Scafoglio, p. 201). Questo è reso possibile da una particolare impostazione fisiologica e materialista a forte carattere ontologico volta, tramite una sorta di psicoanalisi dell’origine dell’umano, a individuarne strutture fondamentali.
Come si può trovare anche nell’antropologia di Hans Blumenberg (con cui Türcke ha moltissimo in comune, apparentemente senza saperlo, nonché principale dialogo ancora da formulare), il tentativo di una paleoantropologia psicanalitica è reperire, attraverso i pochi spiragli disponibili, la radice originaria di costanti umane che vi sono prefigurate. Attraverso la sua “filosofia del sogno” (Philosophie des Traums, 2008), Türcke rintraccia nella storia della Menschwerdung l’importanza capitale della coazione a ripetere: davanti a una natura ingestibile e terrorizzante, la risposta fisiologica dell’umano diventa l’identificazione con l’aggressore, un farsi carico della violenza esogena, attraverso la sua ripetizione. È attraverso la pratica rituale e sacrificale che la collettività focalizza la propria attenzione, diventando causa attiva della violenza che prima era limitata a subire, ed è questo processo, che lentamente diventa capacità di produzione simbolica, che dà forma alla cultura umana. Tale meccanismo psico-sociale, che lega strettamente la capacità di simbolizzazione e di astrazione alla dimensione rituale-sacrificale, è stato costante e reiterato nella storia umana, tanto che Türcke lo rintraccia, ad esempio, anche nel trauma della morte di Cristo trasfigurato a sacrificio universale (Pirolozzi, p. 117) o anche nel sistema di funzionamento del denaro come sostituto simbolico del sacrificio.
L’ordine simbolico-culturale, nato per far fronte a una crisi permanente, si trova a sua volta in pericolo a partire dall’interazione patologica tra la struttura fisiologica dell’umano e l’inquietante dominio di ciò che Türcke chiama “sensazione assoluta”. Questa tendenza era già trattata in Erregte Gesellschaft (2002; tr. it. La società eccitata, Bollati Boringhieri 2012), uscito prima della diffusione virale dei social network che hanno sostanzialmente confermato la sua diagnosi: il “capitalismo estetico” cui siamo soggetti oggi opera tramite una saturazione e un continuo bombardamento di stimoli sensoriali. Se la possibilità della distrazione è vista in positivo come un’assenza di pericolo immediato, la sistematizzazione della distrazione si tramuta nell’impossibilità dell’attenzione, di cui è sintomo anche dal diffondersi dell’ADHD vista come una vera e propria “tendenza sociale” (Furlan, p. 88, Zuin p. 258). Come chiosa Hösle, l’economia dell’attenzione finisce con il trasformare la realtà in una rilevanza momentanea (p. 143), la cui tendenza è desedimentare ciò che è stato guadagnato evolutivamente in un “ritorno ai fondamenti” che minaccia un’involuzione e una regressione dell’essere umano. In questa riflessione ritroviamo in effetti la base materialistica e ontologica di Türcke che include anche la gender theory come manifestazione “primato della sensazione” nelle vesti di un “volontarismo radicale” (Bock, p. 292) di un sentio ergo sum (Dierks, p. 317), il che è, per usare un eufemismo, abbastanza problematico.
Per far fronte a questa situazione, Türcke arriva a proporre una nuova pedagogia, soprannominata “studio rituale”, che rifiuti l’insegnamento “per competenze” che inserisce nella formazione degli individui una distorsione già orientata al produttivismo (Schweppenhäuser, p. 250). Se il primato della sensazione va nel senso di un soggettivismo e di una graduale perdita di senso del sé, questo porta anche a un indebolimento dei legami sociali. Lo “studio rituale” viene proposto come pedagogia dell’attenzione in comune, che ripristini sia un senso del collettivo che del personale.
Questo “assaggio” del volume non dà ragione, per ovvi motivi, della sua ricchezza ma, soprattutto, della sua apertura: Türcke è un autore che si può far dialogare (o anche litigare!) con molti altri. Del resto, lettori (e recensori) si trovano in fondo all’interno delle stesse dinamiche di cui Türcke ha proposto in maniera originale un’analisi inquieta, in cui, in fondo, ne va della stessa possibilità di continuare a restare umani. Nel volume si intravede una vera e propria etica dell’attenzione, che indica un modo in cui si può evitare di subire semplicemente il mondo contemporaneo nel tentativo filosofico di comprenderlo. Che forse è anche la strada, ancora tutta da percorrere, per ritrovare un senso sociale messo a rischio nel mondo neoliberista contemporaneo.
Piero Carreras
S&F_n. 30_2023