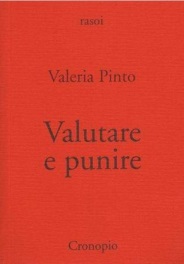Misurare è comandare. Imporre un criterio di valutazione è come imporre un linguaggio. Significa costringere altri a impegnare se stessi e il proprio agire su un territorio scelto da chi valuta, con parametri che sono tanto più di parte quanto più si presentano come oggettivi, con interpretazioni tanto più insidiose quanto più danno a intendere di essere invece dei semplici fatti. «In tutte le società organizzate gli strumenti di misura e selezione sono stati annoverati tra gli attributi del potere, spesso investiti di carattere sacro» (p. 151).
È al culto della “qualità” e della sua valutazione – che da settario è diventato ecumenico, da criptico si è fatto palese – che Valeria Pinto dedica un’analisi ricca di dati, riferimenti, numeri e sigle, ma soprattutto colma di pensiero. Pinto evidenzia una distinzione concettuale tanto semplice quanto spesso inavvertita, il fatto che qualità è parola duplice. Indica ciò di cui qualcosa è fatto e il giudizio che si enuncia sul suo valore comparandolo con quello di altre cose. Una qualità sostanziale e una qualità intesa come controllo formale. Nella valutazione della ricerca scientifica il secondo significato è sempre più in aperto conflitto con il primo. ANVUR, INVALSI, AVA, GEV, VQR, ASN sono gli acronimi italiani con i quali i decisori politici di ogni colore stanno da tempo operando per sottomettere il sapere e i suoi portatori a un giuramento interiore il cui slogan è “Credere Valutare Eseguire”.
Credere che la prospettiva di una valutazione eteronoma, formale e uniforme migliorerà automaticamente la ricerca; credere senza bisogno di argomentazioni; credere anche quando –
come nel caso della elefantiaca e bizzarra azione dispiegata in Italia dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – chi pretende tale atto di fede si mostra «variamente incapace di raggiungere gli obiettivi proposti» (p. 97), autogiustificandosi e autoassolvendosi – non valutandosi insomma – anche di fronte a «una massa di errori tecnici davvero impressionante e carica di conseguenze per i singoli (ma solo per i singoli?)» (p. 171).
Valutare non i contenuti che ogni singolo ricercatore crea, ma le sedi nelle quali espone i risultati della sua ricerca; valutare non il che cosa ma il dove, nella dogmatica certezza che il luogo nel quale si espongono i risultati renda magicamente efficace – nel senso antropologico- il loro contenuto; valutare non lo specifico contributo di uno studioso alla ricchezza della scienza -modalità ritenuta individualistica ed elitaria e quindi disprezzata nella sua “irrilevanza statistica” – ma la coerenza del suo lavoro con il livello medio di quello dei suoi pari.
Eseguire gli ordini di un’entità che non è né la scienza, né l’umanità, né l’istituzione nella quale si lavora e si vive ma “il mercato”; eseguire applicando anche al sapere criteri di produzione toyotistici; eseguire “attraendo finanziamenti”, trasformandosi quindi da ricercatori in venditori: «È un’idea di conoscenza concepita interamente sotto il segno della esecuzione, dell’ubbidienza senza sforzo e senza tentennamenti a un sistema di regole definito in anticipo, dall’esterno e dall’alto» (p. 77). Un sistema il cui massimo esempio è la zecca, l’insetto che nel suo operare semplicissimo, sempre uguale e mirato allo scopo «mai esita e mai sbaglia» (p. 135).
La parola chiave è mercato, il principio supremo al quale tutto sacrificare, il sistema produttivo verso cui far convergere l’attività di ogni laboratorio, accademia, biblioteca, lo scenario globale che unifica i saperi, le idee e i linguaggi sul fondamento di una standardizzazione universale dei metodi, dei contenuti e degli obiettivi. Un’economia della conoscenza (il genitivo è soggettivo e oggettivo) nella quale gli studenti e i cittadini diventano clienti ai quali offrire prodotti della ricerca caratterizzati dalla accountability, da una rendicontazione capillare e standardizzata del lavoro intellettuale dei singoli e dei gruppi. «Alla fine, l’abbattimento delle torri d’avorio, la rottura della vituperata autoreferenzialità della cultura accademica grazie al riferimento forzato a nuovi valori condivisi, avviene tramite una remissione senza mediazioni all’unica autoreferenzialità oggi ammessa: l’autoreferenzialità del mercato» (pp. 114-115).
Si delinea in questo modo un’inquietante e pericolosa scienza di regime; un sapere diventato espressione e forma della società dello spettacolo, nella quale «la legittimazione del controllore avviene – fatalmente – più in termini di accreditamento mediatico e affidamento politico che altro» (p. 38), «anche perché il valore che la valutazione deve valutare non è appunto il valore intrinseco, interno, dell’attività che viene svolta […] ma piuttosto la tangibile visibilità che queste acquisiscono (poco importa come e perché): la loro presenza in vari circuiti, la loro circolazione, l’impatto che dimostrano di avere, non altra “qualità” insomma se non quella legata al calcolo della diffusione, del tasso d’uso -quanto qualcosa sia citato, non importa neppure quanto effettivamente letto. In breve, il valore del sapere, identificato senza residuo con il sapere reso visibile, coincide con la visibilità dell’effetto che esso provoca» (p. 129). Un dispositivo chiaramente debordiano, il cui senso ultimo è lo sgomitare e l’imporsi – todo modo, che qui non può che essere il modo qualitativamente menoserio – «dei prodotti sul mercato intellettuale della ricerca», come recita un testo pubblicato in Evaluation in the Human Sciences: Towards a Common European Policy (qui citato a p. 128). Da una conoscenza che ha per contenuto e fine la ricerca della verità si transita a una conoscenza che ha per oggetto e mission l’utilità funzionalistica che serva da olio intellettuale nel motore della macchina ultraliberistica che procede ormai a pieni giri.
È quindi evidente che la valutazione non è un fatto tecnico e neutro ma è diventata una vera e propria visione del mondo e un’autentica «cifra del nostro tempo» (p. 16). Un regime di verità dalla struttura intimamente totalitaria – la scientometria fu un’invenzione sovietica – e monoteistica rispetto alla pluralità dei metodi, degli obiettivi e delle forme di conoscenza e di vita. «È così che il soggetto intellettualizzato del ventesimo secolo, il soggetto della professione che segue il proprio demone in una politeistica apertura ai valori, viene superato dal soggetto imprenditore, l’homo œconomicus disperso in una molteplicità di imprese, che in monoteistica devozione al valore ha compiutamente assunto se stesso a capitale umano e il modello della razionalità d’impresa a razionalità tout-court» (p. 148).Da un testo così documentato e rigoroso non potrà più prescindere chiunque si occupi delle tematiche della conoscenza, del suo utilizzo, dei suoi paradigmi, del tentativo di distruzione che sta subendo. Il bellissimo titolo foucaultiano ha un significato anche corporale e non soltanto politico. Dal libro si comprende infatti che “valutà è meglio che fottere”. La valutazione come ennesima metamorfosi del comando. È questo che dobbiamo cercare di capire per non tornare a «una condizione di minorità», all’«incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro», senza la guida di un algoritmo e del suo programmatore politico.
Alberto Giovanni Biuso
02_2013