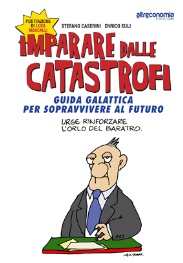Questo breve saggio si presenta come una sorta di vademecum sulla catastrofe, all’interno del quale con una punta di ironia, gli autori provano a sviscerare i fenomeni complessi nei quali l’homo sapiens sapiens e la sua immensa capacità tecnico-manipolativa sembra invischiato, e a formulare delle possibili vie d’uscita da una catastrofe sempre paventata ma affrontata senza una reale quanto efficace meditazione. Del resto la parola catastrofe racchiude al suo interno un’ambivalenza di fondo: è distruzione e fine ultima, ma anche «svolta, trasformazione radicale, possibilità di nuova evoluzione» (p. 10). Non a caso i pericoli di ordine economico, politico, climatico, che incombono sulla società globale, potrebbero costituire per gli autori, il volano di nuove possibilità, «la fine di un modello unico» e dare vita a modi alternativi di pensare e di abitare il mondo. Un sistema mediatico affamato di novità sembra non dar tregua allo spettatore spaesato con notizie sensazionalistiche circa una fine imminente, che di volta in volta inerisce catastrofi climatiche, mercati finanziari sull’orlo di una crisi di nervi, fine delle risorse e via discorrendo a seconda delle mode e delle stagioni. Lo spettatore assuefatto e allo stesso tempo allarmato ma non troppo, giusto il tempo della diretta televisiva, oscilla tendenzialmente tra due atteggiamenti all’apparenza antitetici: da un lato troviamo gli apologeti delle “buone pratiche”, eroi solitari impegnati nel risparmio energetico e in una donchisciottesca raccolta differenziata, consapevole della sua inutilità, dall’altro i rassegnati all’apocalisse, che ritengono il loro eventuale contributo attivo un inutile buco nell’acqua.
Tra utopisti e catastrofisti rassegnati gli autori sembrano abbracciare la posizione di Pierre Dupuy e il suo “catastrofismo illuminato”, che prevede «una valutazione realistica e radicalmente attuale dei pericoli di distruzione […] cioè tiene conto dell’aspetto sistemico del male e prova a salvarsene» (p. 19). Ma chi decide in merito a certe pratiche? In sostanza chi è che dovrebbe salvarci? Sembra impossibile «governare collettivamente e consensualmente la complessità» (p. 29), non è un caso il graduale ma inesorabile scollamento tra cittadini e politica. Conseguenza di ciò la diffusione di una depressione condivisa che tuttavia potrebbe costituire una risorsa, come vuole James Hillman, che intende la depressione come vero e proprio atto politico, che rifiuti l’accelerazione coatta cui il secolo hi-tech conduce, e che sia caratterizzata da una «riflessività pensosa, lenta introversa e silenziosa» (p. 35), da parte di una società che comincia a fare i conti con i propri limiti.
Si dovrebbe procedere dunque verso una vera e propria “ecologia della mente”, che potrebbe partire dall’educazione: «insegnare i contenuti solo e sempre all’interno di cornici più ampie; sviluppare conoscenze e approcci che permettano doppie descrizioni e salti tra contesti e apparenti opposizioni; far studiare e sperimentare epistemologie, logiche e procedure non lineari» (p. 39). Al di là del ruolo politico dei tecnici, che la contemporaneità sembra invocare come novelli salvatori, bisognerebbe recuperare «la fatica di un pensiero complesso e interdisciplinare» (p. 45). Pensare la catastrofe significa protendersi verso un “futuro anteriore”, fare come se, rimettendo in gioco la nozione di tempo: «da una concezione lineare e progressiva ad una circolare, che riallaccia futuro e presente, futuro e passato, in una sorta di futuro anteriore, un futuro che parla di sé, ed è pensato e vissuto come se fosse già anche avvenuto» (p. 57). Questo potrebbe forse dare vita a un’etica non antropocentrica, che consideri insieme il vivente e l’umano. Tuttavia l’atteggiamento che di solito assumiamo davanti a problemi di vasta portata, è al contrario quello dell’ignoranza consapevole, che è una vera e propria strategia di sopravvivenza attraverso la quale fingiamo di ignorare quanto non ci piace o quanto temiamo.Negli ultimi anni va tuttavia sviluppandosi una vera e propria “pedagogia della catastrofe”, per la quale lo stress a cui la nostra specie è sottoposta potrebbe determinare la ricerca di «nuovi apprendimenti […], una potente ristrutturazione cognitiva» (pp. 109-110); si tratterebbe dunque di una lacerazione che presenta un grande potenziale evolutivo, che consiste nell’elaborazione cognitiva del limite, cui l’homo oeconomicus è poco abituato. Del resto «fra la fede nel potere taumaturgico della scienza e della tecnologia, e la fiducia romantica (new age o trascendentale) in un mondo biologico incorrotto, in tutto quanto è natura […] c’è di mezzo il mondo, un mondo che si nutre di interdisciplinarietà, di precisione, di fatica e di fantasia» (p. 144).
Fabiana Gambardella
01_2013