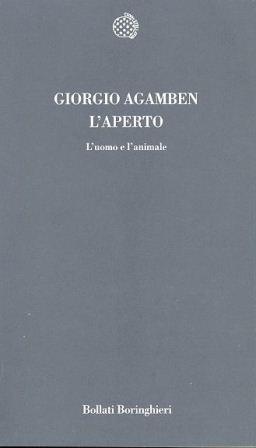Nel regno messianico il lupo dimorerà insieme all’agnello e la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Ciò che è stato diviso allora apparirà nuovamente pacificato, l’estroiezione da sé, che l’umano ha da sempre compiuto a scacciare l’animale in sé nell’ininterrotto processo di antropogenesi, tornerà infine a una serena ricomposizione. Siamo nel primo quadro di apertura del testo, la rappresentazione del banchetto messianico dei giusti nell’ultimo giorno, riprodotta in una Bibbia ebraica del XIII secolo. Il saggio di Agamben è accattivante nel suo svilupparsi a partire da una serie di immagini, di quadri, di suggestioni.
In gioco nel testo è il concetto di vita, in gioco nel testo è dunque la nuda vita animale, vita muta che sembra stagliarsi senza vergogna davanti all’imbarazzo dell’umana parola. Difficile concetto quello di vita: sembra che la nostra tradizione non riesca mai a definirlo. La difficoltà di imbrigliarla, la vita, determina una sorta di vendetta della parola, che comincia allora a vivisezionarla, ad articolarla attraverso una serie di cesure e opposizioni «Tutto avviene, cioè, come se, nella nostra cultura, la vita fosse ciò che non può essere definito, ma che, proprio per questo, deve essere incessantemente articolato e diviso» (p. 21). Tale dispositivo sarebbe in atto già presso Aristotele, che non definisce mai la vita, si limita piuttosto a «scomporla grazie all’isolamento della funzione nutritiva, per poi riarticolarla in una serie di potenze e facoltà distinte e correlate (nutrizione, sensazione, pensiero)» (p. 22). Se da Aristotele, attraverso i secoli, si giunge a Bichat, troviamo in atto la medesima strategia, seppure dai contorni mutati: in ogni organismo superiore è come se convivessero due animali, il primo l’animal existant au-dedans coincide con la vita organica, che si estrinseca nella ripetizione ricorsiva e cieca di una serie di funzioni prive di coscienza; il secondo l’animal vivent au-dehors, si definisce nella relazione col mondo esterno. Naturalmente «nell’uomo questi due animali coabitano ma non coincidono: la vita organica dell’animale-di-dentro comincia nel feto prima di quella animale e, nell’invecchiamento e nell’agonia, sopravvive alla morte dell’animale-di fuori» (p. 23). L’inaugurazione di questa frattura ha determinato conseguenze enormi nella storia della medicina moderna e in seguito della biopolitica, poiché il concetto di vita vegetativa comincia a coincidere con quello di patrimonio biologico della nazione, da tenere sotto controllo, da plasmare e modellare. Proprio perché forgiabile, nell’uomo, la divisione della vita «in vegetale e di relazione, organica e animale, animale e umana», si delinea come una frontiera mobile. È proprio grazie alla scissione determinata all’interno della categoria della vita, che si può costantemente decidere in merito a ciò che è umano e a ciò che non lo è: «Solo perché qualcosa come una vita animale è stata separata all’interno dell’uomo, solo perché la distanza e la prossimità con l’animale sono state misurate e riconosciute innanzi tutto nel più intimo e vicino, è possibile opporre l’uomo agli altri viventi» (p. 24). La questione è di immensa portata politica e mette in discussione l’intera cultura occidentale, la nostra tradizione umanistica: essa ha in effetti sempre pensato l’uomo metafisicamente come l’unione armoniosa di anima e corpo, bruta materia e sostanza nobile, quasi divina. Bisogna invece imparare, secondo Agamben «a pensare l’uomo come ciò che risulta dalla sconnessione di questi due elementi e investigare non il mistero metafisico della congiunzione,ma quello pratico e politico della separazione» (p. 24).
Dal canto suo Linneo amava molto le scimmie e biasimava Cartesio e il suo ardire di definire gli animali come automata mechanica: di sicuro l’inventore del Subjectum e delle sue concitate elucubrazioni non aveva mai visto una scimmia. È per questo che nel suo Systema naturae Linneo decide di porre l’uomo negli Anthropomorpha: il linguaggio non è ancora, al tempo di Linneo, il meraviglioso artefatto che consente all’humanitas di abitare nella comoda casa dell’essere, lontano da pericolosità ferine. L’uomo, in effetti per Linneo, si distingue dagli altri animali solo per il fatto di potersi riconoscere, tuttavia «definire l’umano non attraverso una nota characteristica, ma attraverso la conoscenza di sé, significa che è l’uomo colui che si riconoscerà come tale, che l’uomo è l’animale che deve riconoscersi umano per esserlo» (p. 33). L’humanitas allora, lungi dall’essere il dato originario, costituisce la scelta costante, continuamente reiterata, che l’uomo fa per se stesso, allontanando da sé l’altro in sé, l’animale che dunque è, riconoscendolo per poi misconoscerlo. Ecco perché ciò che chiamiamo Homo sapiens non è «né una sostanza né una specie chiaramente definita: è, piuttosto, una macchina o un artificio per produrre il riconoscimento dell’umano» (p. 34). Homo sapiens è dunque un artificio antropogenico che produce l’umano attraverso una dinamica di inclusione ed esclusione, l’essere umano infatti per essere tale deve prima riconoscersi nel non-uomo.
Nella macchina antropogenica, sia antica che moderna è dunque in gioco la produzione dell’uomo attraverso «l’opposizione uomo/animale, umano/inumano» (p. 42). La macchina moderna isola il non-umano nell’uomo: «entrambe le macchine possono funzionare soltanto istituendo al loro centro una zona d’indifferenza, in cui deve avvenire l’articolazione fra l’umano e l’animale» (p. 43).
Le amene passeggiate di Heidegger nella Foresta nera e quelle di Jacob von Uexküll tra mondi invisibili e sconosciuti, aiutano meglio a riflettere sulla differenza ontologica. Ogni animale costruisce il proprio Umwelt, sostiene lo zoologo prussiano, e cioè seleziona dall’intero Umgebung unicamente gli stimoli rilevanti per la propria sopravvivenza. Ciascun animale vive dunque chiuso all’interno del proprio specifico ambiente diverso e impermeabile da tutti gli altri. L’incomunicabilità tuttavia non è sinonimo di caos. Un piano naturale, un armonia presiede la vita di queste monadi cieche e sorde all’altro da sé. Secondo Agamben l’antiumanesimo nel moderno trova grande carica espressiva nella descrizione dell’epopea di una zecca ad opera di Uexküll: la zecca è cieca e sorda, ma risulta sensibile a soli tre stimoli, l’odore dell’acido butirrico presente nei mammiferi, il calore della pelle, la sensazione tattile del corpo del mammifero. Attende la zecca su un ramo l’avvento della preda, all’arrivo si lancia configge il rostro depone le uova e muore. L’Umwelt della zecca si riduce a questa relazione, è questa appassionata quanto fugace relazione. Eppure esperimenti di laboratorio hanno provato che una zecca può resistere sino a diciotto anni in attesa della preda. Attesa paziente, sonno profondo, letargo? Che ne è della zecca e dell’epopea del suo piccolo mondo? «Come è possibile che un essere vivente, che consiste interamente nella sua relazione con l’ambiente, possa sopravvivere in assoluta deprivazione di esso?» (p. 51). Il filosofo all’ascolto dell’essere dal canto suo, restò molto affascinato dalle passeggiate dell’eclettico barone prussiano, a partire dalle quali nel’29 elaborò per l’animale il concetto di “povertà di mondo”, per distinguerlo dall’uomo e dalla sua parola, che fa, che costruisce costantemente il mondo. L’animale al contrario ha e non ha mondo, nel senso che entra in relazione con esso soltanto nella forma di un disinibitore. Ecco perché per Heidegger l’animale non accede mai alla manifestatività dell’ente in quanto tale, ma rimane imprigionato nello stordimento del proprio cerchio ambientale che è come un tubo che non si allarga né si restringe, e che consiste nell’appagamento qui e ora del bisogno presente. L’allodola per Heidegger non vede l’aperto: le passeggiate di Rilke, (che pure amava lo zoologo prussiano, tanto da considerarlo il proprio consulente biologico) mostravano l’animale quasi più umano dell’uomo e presentavano, a detta di Heidegger una mostruosa antropomorfizzazione dell’animale e una corrispondente animalizzazione dell’uomo. Di nuovo confini e limiti diventano malleabili a seconda delle latitudini e dei punti di vista.
Anche Heidegger sembra sentire questa vertiginosa prossimità: le lezioni del ’29 analizzano uno stato d’animo fondamentale che è la noia: nell’essere lasciati vuoti, nell’essere lasciati in sospeso da un ente che si rifiuta nella sua totalità, sembra far capolino questa vicinanza estrema humanitas-animalitas; la noia sembra evocare allora la Benommenheit animale. E tuttavia è proprio a partire da questa vicinanza estrema che scatta la macchina antropogenica e dunque il riconoscimento che si trasforma in scelta per la distanza, per l’allontanamento, per l’estroiezione. La noia infatti riconsegna il Dasein alla sua possibilitazione originaria. Ecco perché quella che sembrava una prossimità si rivela invece come un abisso che non può essere colmato da nessuna mediazione. Ancora una volta la macchina antropogenica ha funzionato, Heidegger, secondo Agamben, è stato l’ultimo pensatore a «credere in buona fede che il luogo della polis […] fosse ancora praticabile, che – tenendosi in quel luogo rischioso – fosse ancora possibile per degli uomini – per un popolo – trovare il proprio destino storico» (p. 78). Da allora la macchina antropologica sembra girare a vuoto. Per Agamben, le soluzioni possibili sono due: l’uomo post-storico cerca di governare la propria animalitas attraverso la tecnica, oppure «l’uomo, il pastore dell’essere, si appropria della sua stessa latenza, della sua stessa animalità, che non resta nascosta né fatta oggetto di dominio, ma è pensata come tale, come puro abbandono» (p. 82).
Fabiana Gambardella
S&F_n. 7_2012