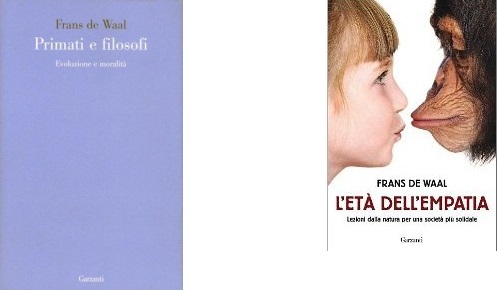The development of moral qualities is a more interesting and difficult problem. Their foundation lies in the social instincts, including in this term the family ties.
C. Darwin, The Descent of Man
«Per i risvegliati c’è un cosmo unico e comune, ma ciascuno dei dormienti si involge in un mondo proprio» (Eraclito, Dell’Origine, Feltrinelli, Milano 2009, p. 159). In questo celebre aforisma Eraclito sottolinea l’intima relazione tra tutte le cose, che sussiste proprio là dove i non “iniziati” alla conoscenza vedono separazione e individuazione. Leggendo i due testi di Frans de Waal, Primati e filosofi e L’età dell’empatia viene in mente quanto affermato dal filosofo greco. Due sono le principali domande affrontate dallo studioso: esiste un confine netto tra l’uomo e l’animale? Possiamo trovare un fondamento della morale umana all’interno della natura? Nelle soluzioni da lui proposte, lo scienziato si pone in linea con le recenti scoperte della biologia e delle neuroscienze, che tracciano una distanza sempre più ampia da alcuni principi cardine della modernità. Su questi ultimi e sui loro esiti vale la pena soffermarsi, per comprendere l’ordine di problemi entro cui si muove il nostro autore.
Segnando il primato dell’intelletto, per lungo tempo la scienza moderna ha smesso di cercare correlazioni, preoccupandosi piuttosto di isolare i fenomeni, al fine d’individuare, nel caotico divenire della natura, un preciso ordine di leggi, rassicurante nella sua eterna immutabilità (cfr. I. Prigogine – I. Stengers, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi, Torino 1999, p. 41). L’“ansia cartesiana”, per la quale, «o noi disponiamo di un fondamento fisso e stabile per la conoscenza (…), oppure non possiamo sfuggire a un certo grado di oscurità» (F. Varela – E. Thompson – E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova dell’esperienza, Feltrinelli, Milano 1992, p. 171), ha prodotto una duplice frattura: una tra la natura e l’uomo, l’altra, all’interno dell’uomo stesso, tra la sfera cognitiva e quella emotiva, quest’ultima svalutata in quanto fonte d’impulsi egoistici.
Il pregiudizio di una natura egoista dell’uomo non ha mancato, nel tempo, di cercare una conferma nella biologia, influenzandone, a sua volta, la lettura dei risultati. In particolare, l’evoluzione è stata spesso chiamata in causa per legittimare l’idea di una società fondata su principi individualistici.
Nel 1850 Herbert Spencer liquida, nella sua Statica sociale, l’idea di un’armonia originaria nel mondo. L’autore, il primo ad aver esteso il concetto di evoluzione anche alle scienze sociali, afferma: «il fine ultimo della creazione – la produzione della massima quantità di felicità – può essere conseguito solo a determinate condizioni. Per conseguire tale obiettivo, ogni membro della specie umana deve non solo essere dotato di facoltà che gli permettano di trarre il massimo piacere dall’atto di vivere, ma deve anche essere in grado di raggiungere la piena realizzazione dei suoi propri desideri senza impedire agli altri di fare lo stesso, anzi, per un effettivo conseguimento del fine ultimo, deve trarre piacere dal piacere altrui. Tuttavia, essendo creati per moltiplicarci in un mondo abitato da creature inferiori, creature che andrebbero spodestate per fare spazio, questo è chiaramente impossibile» (H. Spencer, Social statics, or the condition essential to human happiness, D. Appleton & Company, New York 1871, trad. mia). In quest’ottica, la società pacifica, più che un presupposto, costituisce un ideale verso cui tendere.
Il cammino verso l’armonia è inteso da Spencer come un percorso caratterizzato da un progressivo passaggio da uno stato iniziale di omogeneità verso uno stato di crescente organizzazione e differenziazione. Lungo questo cammino la divisione dei compiti si fa sempre più articolata, consentendo all’intero organismo sociale di adattarsi meglio all’ambiente circostante. Entrando in contraddizione con questa sua stessa analogia organica, tuttavia, Spencer si fa promotore di un pensiero individualista, riconoscendo nella selezione naturale la chiave per il perfezionamento progressivo della società. Lo studioso, dunque, auspica un ordine sociale improntato sul laissez faire (A. La Vergata, Guerra e Darwinismo sociale, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2005, p. 46), che agevoli e tuteli gli interessi individuali, lasciando che ciascuno intraprenda la lotta per la propria sopravvivenza e per la propria realizzazione personale. La comunità, al pari della natura, premierà il più adatto.
La linea di pensiero inaugurata da Spencer è stata ben presto indicata dai propri critici con l’espressione darwinismo sociale (ibid., p. 33), che si fonda su un’associazione tra le suddette riflessioni e i risultati raggiunti dal naturalista inglese. Gli stessi teorici dell’individualismo nel tempo hanno fatto riferimento alla teoria di Darwin per legittimare la propria posizione (ibid.), nonostante lo scienziato riconosca, nei suoi scritti, una naturale tendenza alla cooperazione nell’uomo. Nell’opera Descent of Man, infatti, si legge che, come tutti gli «animali sociali sono mossi da un generale desiderio di aiutare i membri della propria comunità, (…), l’uomo è spinto dallo stesso generale desiderio di aiutare i suoi compagni» (C. Darwin, Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, John Murray, London 1871, p. 392, trad. mia).
La diffusione della visione individualista promossa dal darwinismo socialeha fatto sentire i suoi effetti in molteplici ambiti, primo tra tutti quello economico. Qui ha dato luogo a un capitalismo che nelle sue forme più estreme ha innescato meccanismi di serrata competitività, portando avanti il mito di una felicità che possa essere raggiunta solo attraverso l’accumulo di denaro e di beni materiali. Secondo questo mito, spiega Zygmunt Bauman, «arrivare alla felicità significa ottenere cose che gli altri non sono in grado di ottenere, nemmeno in prospettiva. La felicità richiede sempre di essere un gradino sopra gli altri» (Z. Bauman, L’arte della vita, Laterza, Bari 2010, p. 31). Tale logica, a lungo perpetuata nella società occidentale, ha comportato un aumento esponenziale dei consumi individuali e un relativo abbassamento del risparmio, fenomeni che sono stati alla base del tracollo che il mondo sta affrontando negli ultimi anni.
Il superamento di questa crisi può avvenire solo attraverso un radicale cambiamento nell’approccio col mondo e con gli altri. Occorre che la competitività lasci il posto alla solidarietà. È quanto afferma l’economista Jeremy Rifkin. In un’intervista rilasciata al New Scientist, lo studioso sottolinea che «molte scoperte recenti in campo biologico, neurologico e antropologico ci offrono un’immagine dell’essere umano diversa rispetto a quella in voga durante l’illuminismo. Per esempio, la scoperta dei neuroni specchio dimostra che siamo una specie sociale fatta più per l’empatia che per l’autonomia» (J. Rifkin, Intervista, in http://www.nextme.it/societa/next-economy/298-come-evitare-lestinzione-rifkin-e-lempatia). Non solo le neuroscienze, ma anche la ricerca etologica avvalora tale tesi. Lo sa bene il primatologo Frans de Waal, che in virtù delle sue decennali osservazioni sui primati non umani e del drammatico momento che la società umana sta attraversando in questi anni, dà inizio al suo ultimo libro, L’età dell’empatia, con un’affermazione secca e incisiva: «L’avidità ha fatto il suo tempo. Ora è il momento dell’empatia» (F. de Waal, L’età dell’empatia, p. 9).
Contro un discorso teso a legittimare l’immagine di una natura malvagia, il primatologo olandese mette a disposizione del lettore i risultati dei suoi numerosi studi, che mostrano un’elevata frequenza di comportamenti prosociali nel regno animale. L’autore intende in tal modo dimostrare come l’evoluzione abbia «prodotto il collante che tiene insieme le comunità» (ibid., p. 10). È nella natura, dunque, che vanno ricercati i presupposti della moralità umana, in primis la capacità di immedesimarsi nell’altro, assumendone il punto di vista.
In questo suo ultimo testo l’autore torna su tesi costruite nel corso delle sue numerose ricerche sui primati. In passato de Waal si è interrogato sull’origine della moralità umana. Le sue riflessioni in proposito sono state esposte nel corso delle Tanner Lectures, che lo studioso ha tenuto all’università di Princeton nel 2004, e sono state pubblicate nel 2006 in Primati e filosofi. In quest’opera il primatologo avanza l’idea di una continuità della moralità umana coi sentimenti di socialità che condividiamo con gli altri animali. La tesi viene sottoposta al vaglio dei filosofi Christine Korsgaard, Philip Kitcher e Peter Singer e dello psicologo evolutivo Robert Wright. Il loro contributo si concretizza in una successione di saggi che assume la forma di un confronto dialettico, finalizzato alla chiarificazione di una posizione condivisa da tutti nei suoi principi fondamentali. Quanto esposto in Primati e filosofi costituisce la premessa teorica fondamentale di L’età dell’empatia. I due testi vengono, dunque, a costituire un corpo unico, che nel complesso dà compiutezza e attualità al messaggio dello studioso.
Nel contrastare la visione relativa alla discontinuità tra l’uomo e gli altri animali, in Primati e filosofi de Waal focalizza la propria attenzione sulla cosiddetta “teoria della patina” (F. de Waal, Primati e filosofi, p. 27). Con un esplicito riferimento a Thomas Huxley, lo studioso illustra la concezione, condivisa anche dalla psicoanalisi freudiana, secondo cui l’uomo è perennemente impegnato in una lotta per tenere a freno i propri impulsi egoistici. Tale visione riflette la scissione tipica della scienza moderna, secondo cui «per una parte siamo natura e per una parte siamo cultura, anziché un intero ben integrato» (ibid., p. 30). All’interno di tale impianto teorico, continua l’autore, «la moralità umana è presentata come una sorta di sottile crosta esterna sotto la quale ribollono passioni antisociali, amorali ed egoistiche» (ibid.).
De Waal ravvisa le radici di tale visione in un’impropria associazione con la durezza del processo di selezione naturale. «L’errore – afferma lo studioso – sta nel pensare che un processo sgradevole possa produrre solo risultati sgradevoli» (ibid., p. 210). Contro tale concezione, lo scienziato sottolinea come il processo di evoluzione abbia premiato comportamenti prosociali, assicurando maggiori opportunità di sopravvivenza a specie che mettono in atto strategie di cooperazione. Il primatologo ricorda che lo stesso «Darwin credeva fermamente che la sua teoria fosse in grado di dare spazio anche alle origini della moralità e non vedeva alcun conflitto tra la durezza del processo evolutivo e la mitezza di alcuni dei suoi prodotti» (ibid., p.35). La stessa massima homo homini lupus, tanto cara ai teorici del contratto sociale, secondo il primatologo sarebbe impropria, in quanto non rende giustizia alla connaturata socialità dei canidi (ibid., p. 23).
Prendendo le distanze dalla teoria della patina, de Waal sostiene che la moralità sia il frutto di una tendenza alla socialità che caratterizza l’intero regno animale. Per cui «quando agiamo in nome di un senso morale (…) prendiamo delle decisioni che derivano da istinti sociali che sono più antichi della nostra specie» (ibid., p. 80). Piuttosto che trovare fondamento nella ragione, elemento che segna lo scarto tra uomo e animale, così come vogliono gli illuministi, la morale affonda le sue radici nel corpo, intrecciandosi saldamente alle emozioni.
Il comportamento morale troverebbe, dunque, il suo presupposto nella capacità di cogliere lo stato d’animo altrui. È quanto ci è assicurato dall’empatia, mediante cui «noi entriamo involontariamente nei corpi di coloro che ci circondano, così che i loro movimenti e le loro emozioni si riverberano dentro di noi come fossero i nostri» (F. de Waal, L’età dell’empatia, p. 85). Questa capacità, fa notare de Waal, non è una neoformazione della ragione umana, ma un elemento che, sia pure in gradi di complessità diversa, condividiamo con le altre specie animali. «La capacità pienamente dispiegata – commenta lo scienziato – sembra essere assemblata come una matrioska. Un processo automatizzato, condiviso da una moltitudine di specie, ne rappresenta il nucleo, a sua volta circondato da strati esterni che ne perfezionano lo scopo e la portata» (ibid., p. 276). Alla base di tale facoltà troviamo l’imitazione e il contagio emotivo, fattori essenziali per coordinare le attività di gruppo (ibid., p. 71). Spostandoci, poi, verso specie via via più evolute, incontriamo la capacità di individuare gli effettivi bisogni dell’altro, distinguendoli dai propri, e di adottare comportamenti appropriati alla situazione. Il fatto che negli esseri umani questa capacità trovi il massimo sviluppo, non vuol dire che i livelli più bassi siano assenti (ibid., p. 277). Il carattere contagioso del riso e dello sbadiglio danno prova del richiamo istintivo che i membri della nostra specie esercitano su di noi (ibid., pp. 67-71).
La natura sociale dell’uomo non esclude, naturalmente, condizioni di conflittualità. A tal proposito de Waal dichiara che «gli esseri umani sono empatici con i propri compagni in contesti cooperativi, ma sono “antiempatici” con i potenziali competitori» (ibid., p. 158). L’empatia è un meccanismo che rafforza il gruppo impegnato nel raggiungimento di un obiettivo ma, come dimostrato anche da Muzafer Sherif nei suoi esperimenti su gruppi di adolescenti, effettuati in campi estivi nella prima metà degli anni cinquanta, la competizione con altri gruppi che lottano per uno stesso scopo produce forti ostilità e il mancato riconoscimento, da parte dei membri del gruppo, degli stati d’animo dei propri nemici (M. Sherif, O.J. Harvey et Al., Intergroup Cooperation and Conflict. The Robber’s cave Experiment, University of Oklahoma Press, Norman 1961).
La capacità di immedesimarsi nell’altro è, dunque, il presupposto fondamentale per la coesione di un corpo sociale, ma richiede, altresì, un filtro. A tal proposito, le considerazioni di de Waal sulla psicopatologia risultano illuminanti. Per lo studioso la malattia mentale «è caratterizzata da una disconnessione permanente tra l’assunzione di prospettiva e le aree profonde dell’empatia» (ibid., p. 279). La scollatura tra l’aspetto cognitivo e quello emotivo definisce i termini della psicosi. Ancora una volta, la scelta tra uno dei due aspetti sottrae qualcosa all’umano. Puntare solo all’aspetto cognitivo assicura l’assunzione della prospettiva altrui, ma può portare a gradi di crudeltà ineguagliabili. Lo dimostrano gli episodi di sadismo perpetuati dai serial killer o quelli di cui abbiamo avuto un’ampia testimonianza durante i regimi totalitari (ibid.). D’altro canto anche un eccessivo contagio emotivo crea problemi. Ne è un esempio la sindrome di Williams, che vede chi ne è affetto particolarmente sensibile e fiducioso verso gli stati d’animo di chiunque lo circondi, ma altrettanto incapace di un’elaborazione cognitiva della situazione. In altri termini, l’apertura indiscriminata nei confronti dell’altro impedisce di operare quella selezione necessaria per mettere in atto un comportamento adeguato (ibid., p.224-225).
Gli esempi sopra riportati mostrano che «l’empatia ha instradato la specie umana sulla via di una società ristretta dove si mette l’accento sull’uguaglianza e sulla solidarietà» (ibid., p. 292). D’altro canto, rileva il nostro autore, «oggi viviamo per la maggior parte in comunità molto più estese, in cui quest’accento è difficile da mantenere, ma abbiamo ancora una psicologia che si adatta meglio a questo genere di esiti» (ibid., p. 292) ed è su questa psicologia che bisogna puntare oggi. Un’osservazione senza preconcetti della nostra specie, che non tema di riconoscere ciò che abbiamo in comune con le altre specie animali, potrebbe dare maggiore consapevolezza della nostra natura, in particolare di alcuni suoi aspetti che potrebbero aiutarci ad affrontare le sfide che prospetta la situazione presente.
Su uno di tali aspetti de Waal si sofferma in modo particolare in L’età dell’empatia. Si tratta dell’apertura al futuro. Agevolando le strategie di cooperazione, la natura mostra di essere lungimirante nella selezione dei modelli comportamentali adottati dalle proprie creature. I comportamenti altruistici documentati in numerose specie animali dimostrano, infatti, la capacità di sospendere un interesse personale e immediato in vista di un bene maggiore, duraturo ed esteso all’intera comunità. Consapevoli dei risultati cui ha condotto l’individualismo, siamo oggi chiamati a scegliere se mantenere tale atteggiamento oppure orientarci verso fini d’interesse collettivo. «Due cacciatori devono decidere se andarsene ognuno per sé a caccia di lepri o rimanere uniti e portare a casa un cervo, una preda molto più grande, anche se da dividere in due» (ibid., p. 218). La crisi che stiamo affrontando ci spinge a lavorare insieme per ricostruire una fiducia reciproca, nel segno di un «interesse personale illuminato: la consapevolezza che siamo tutti più ricchi se lavoriamo insieme» (ibid., p. 295). Oggi la posta in gioco è molto più alta dei nostri scopi particolari. Oggi è necessario inaugurare l’età dell’empatia.
Anna Baldini
S&F_n. 7_2012