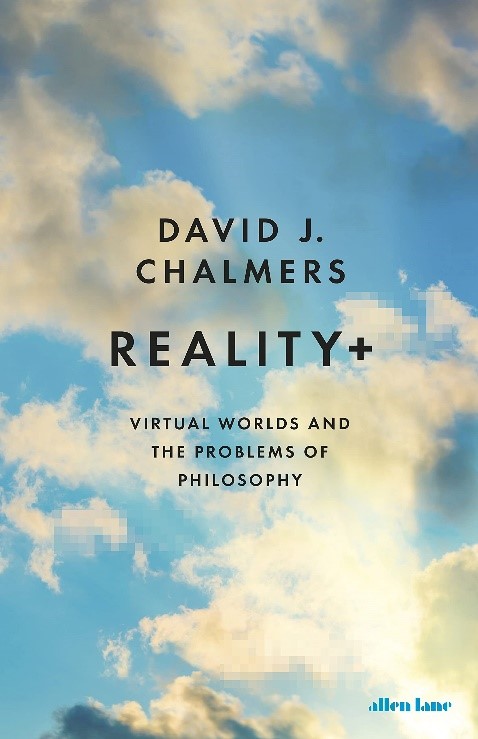Nell’inattualità di un mondo costantemente sfilato e ricucito in una maglia di dati, intinto di virtualità e steso ad asciugare nell’esposizione di uno schermo digitale, ha ancora senso chiedersi cosa sia reale? Esiste ancora la realtà? È ancora possibile afferrarla nel continuo mutarsi ed evolversi di una società scandita dallo sviluppo delle ICT e dalla diffusione di mondi virtuali?
Rivolgendo tali quesisti ad uno dei memi più diffusi sulle piattaforme social, quello di Mr. Robot (“non so nemmeno più cosa sia reale”), la risposta sembrerebbe scontata. I confessionali elettronici, riferendo l’opinione fantasma diffusa del mainstream, esclamerebbero: “La realtà non esiste più! E, soprattutto, non interessa a nessuno!”.
Ebbene, l’esorcismo di transizione ambientale veicolato dal meme di Mr. Robot, restituendo lo spaesamento dell’umano nel pendolare tra mondo reale e mondo virtuale, permette di richiamare la domanda chiave del lavoro di Chalmers: I mondi virtuali sono reali? O meglio, cosa distingue il mondo reale da quello virtuale?
A partire da questa domanda, il filosofo australiano sostiene la tesi secondo cui: «Each virtual world is a new reality: Reality+. Augmented reality involves additions to reality: Reality+. Some virtual worlds are as good or as better than ordinary reality: Reality+. If we’re in a simulation, there is more to reality than we thought: Reality+. There will be a smorgasbord of multiple realities: Reality+» (p. XVIII).
Lo spaesamento interpretato dal meme di Mr. Robot, quindi, risponderebbe ad un aumento di realtà, ad un’aggiunta di realtà, ad uno sviluppo di realtà, racchiuso da Chalmers nel plus del titolo dell’opera. Un’opera che, fin dalle prime pagine, ha di mira la decostruzione di una specifica narrazione secondo cui i mondi virtuali non sarebbero reali o, quanto meno, non avrebbero lo stesso valore ontologico del mondo reale: «I know that what i’m saying is counterintuitve to many people. Perhaps you think that VR is Reality-, or Reality Minus. Virtual worlds are fake realities, not genuine realities […] I’ll try to convince you that Reality+ is closer to the truth» (p. XVIII).
Il concetto di Reality+, pertanto, viene costruito dal filosofo australiano per aggiornare il concetto di realtà all’altezza dell’odierno tempo storico contrassegnato dall’utilizzo delle ICT e, parallelamente, investigare la simulation hypothesis, ovvero, l’ipotesi secondo cui l’universo fisico potrebbe esser generato da una simulazione informatica.
Gli argomenti a sostegno della tesi di Chalmers vengono dedotti da alcune questioni cardine: cosa distingue il mondo reale dal mondo virtuale? Come cambia il concetto di realtà con lo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione? Qual è il rapporto tra realtà e verità nelle contemporanee digital societies?
Su questo punto, la copertina dell’opera risulta quanto mai pregnante: un cielo annuvolato che mostra a occhio nudo (?) un effetto pixel, ovvero, l’inizio di una nuova comprensione del mondo in cui l’immagine manifesta del cosmo (surface) potrebbe esser interpretata e generata partire dalla scrittura di un codice di programmazione (subface).
Il reale, in tal senso, restituito alla malleabilità del proprio tempo storico, in quanto concetto storicizzabile, si consegnerebbe come transitoria, mutevole, istantanea di una temporanea condizione d’esistenza antropica che, riferendo dell’aggiornamento triadico tra physis, anthropos e techne, oggigiorno, permetterebbe di affermare la tesi secondo cui: «the virtual reality is genuine reality» (p. VII).
Non a caso, nell’introduzione, Chalmers definisce il proprio metodo di lavoro come technophilsophy, ovvero, il far interagire le domande classiche della filosofia con le contemporanee teorie scientifiche, scandagliando ipotesi suggerite dall’impatto delle tecnologie sulla quotidianità. Secondo il filosofo australiano, gli attuali sistemi di virtual reality e augmented reality rappresenterebbero lo stadio primitivo di dispostivi/ambienti che, prima o poi, renderanno impossibile la distinzione tra mondo virtuale e mondo non-virtuale (p. XIII).
Su questo fronte, la tesi centrale del lavoro di Chalmers, nel far emergere la centralità del plus, ovvero dell’annessione dei mondi virtuali e della realtà aumentata all’insieme del reale, affermerebbe l’autenticità della realtà del virtuale attraverso tre sub-tesi: la realtà potrebbe essere una simulazione (simulation hypothesis); ciò non significa che sia un’illusione o che sia una second-class reality; si può avere una vita appagante e felice nella virtual reality (p. XVII).
A partire da questo nucleo triadico, il testo risulta composto da due versanti intersecati e in costante riferimento. Il primo, ricostruendo le questioni filosofiche tradizionali e moderne, incrocia l’ipotesi di simulazione con la questione gnoseologica circa la realtà del mondo esterno: se l’universo fosse una simulazione, sarebbe ancora possibile conoscerlo? Il secondo versante, invece, verte sul problema etico-valoriale e sullo statuto morale degli agenti virtuali esaminando la possibilità di poter vivere una vita felice e appagante nella nuova era della Realtà+.
Le suddette sezioni, facendo collimare il versante epistemologico con quello etico, vengono accompagnate, nello scorrere del testo, attraverso due immaginari specifici: quello di Matrix e del Metaverso. I personaggi e le tematiche del film blockbuster del 1999 vengono adoperati per affrontare la simulation hypothesis integrandola con il dubbio cartesiano circa l’esistenza del mondo esterno: se non possiamo dimostrare di non essere in una simulazione, possiamo ancora credere che il mondo esterno sia reale o, meglio, conoscibile?
La cornice del Metaverso, invece, focalizzandosi su questioni aderenti alla praxis, all’utilizzo di programmi e dispositivi ascrivibili tanto all’ipotesi di simulazione quanto all’utilizzo di piattaforme social, tenta di rispondere alla domanda guida: è/sarà possibile avere una vita felice nelle virtual reality?
La successione tra questi due versanti permette a Chalmers di tratteggiare un’orbita di questioni in costante richiamo: come interagiscono mente e corpo in un mondo virtuale? (p. 255), cos’è la coscienza? (p. 277), la mente si estende oltre il corpo fisico-biologico? (p. 296), come ripensare il valore e l’etica nella Reality+? (p. 311), esiste un dio, è possibile che sia un hacker? (p. 124), di cosa è fatto l’universo? (p. 145), come può il linguaggio descrivere il reale? (p. 151).
Più specificatamente, nei primi tre capitoli, Virtual Worlds, Knowledge, Reality, Chalmers riconfigura la simulation hypothesis (p. 23) recuperando la teoria fisica dell’it-from-bit.
In quest’ottica, l’universo potrebbe esser interpretato come una rete di bit che interagiscono, una macrostruttura di processi computazionali. Tale versante, come già accennato, mira ad un’integrazione del dubbio iperbolico cartesiano circa la realtà del mondo esterno attraverso l’ipotesi di simulazione.
Il filosofo australiano, difatti, ripropone l’argomento formale del Cartesian skepticism+ in questi termini: non si può sapere di non essere in una simulazione, se non si può sapere di non essere in una simulazione non si può aver conoscenza certa del mondo esterno; perciò, non si può aver conoscenza certa circa il mondo esterno (p. 56). Tuttavia, ed è qui che ritorna la tesi centrale del lavoro, una volta dimostrato che il mondo virtuale, offerto da un programma di simulazione, sia autentico e materiale, ovvero, in piena continuità con la realtà fisica del mondo, questo dilemma si risolve da sé. La prosecuzione tra reality e plus, tra mondo fisico-reale e mondo informatico-virtuale, in conclusione, porta Chalmers a sostenere il virtual realism (p. 105).
Secondo questa interpretazione, la realtà virtuale sarebbe autentica realtà, gli oggetti virtuali sarebbero oggetti reali–digitali, costituiti da bit, cioè dall’unità base dell’informazione che, nell’intervallo scandito dal plus, risulterebbe il fondamento primo ed ultimo della realtà.
A sostegno della sua tesi, Chalmers propone cinque criteri per intendere cos’è reale: existence, ovvero, tutto ciò che può essere percepito-misurato; causal powers, tutto ciò che ha un effetto, un potere causale sugli altri enti; mind-indipendence, tutto ciò che è indipendente dalla mente e che esiste anche se non viene pensato-creduto; non-illusoriness, tutto ciò che non è illusorio e non inganni sistematicamente la percezione; genuiness, tutto ciò che è genuino-autentico, costante e verificabile.
Questi cinque criteri (p. 115) permettono a Chalmers di risolvere l’argomento formale del dubbio cartesiano+ dimostrando che gli oggetti virtuali, tanto nell’ipotesi di simulazione (virtual reality) tanto nel Metaverso (virtual worlds), soddisfano pienamente il concetto di realtà proposto (p. 116).
La tesi di Chalmers, pertanto, afferma che gli oggetti virtuali e i mondi virtuali esistono, risultano teletrasmessi, generati da un sistema informatico, hanno un effetto sul mondo circostante e continuano ad esserci indipendentemente dalla mente o dall’esistenza di chi li percepisce.
Ecco allora che Chalmers pone la simulation hypothesis, ovvero la possibilità che l’universo fisico sia generato da un computer, come variazione della it-from-bit hypothesis nella piena continuità tra realtà fisico-organica e realtà informatico-inorganica, ovvero nella continuità racchiusa nell’arco teorico che collega la reality al plus. La Realtà Virtuale, quindi, potrebbe costituire il fondamento primo e ultimo, circolarmente infondato (poiché in continua fondazione), della continuità tra mondo reale e mondo virtuale, facendo decadere tale apparente e dicotomica prospettiva.
A partire da questa concrescenza tra mondo reale e mondo virtuale affermata da Chalmers, l’ipotesi fisica dell’it-from bits incrocerebbe l’ipotesi metafisica (p. 119) della creation hypothesis. Il creatore della simulazione, secondo Chalmers, potrebbe essere un local god (p. 128), a natural god (p. 135), che genererebbe l’universo fisico come campo, rimanendo immanente alla natura cosmica (p.135) e non pre-programmando il divenire o gli sviluppi della simulazione.
Su questo fronte il filosofo australiano sostiene la posizione del simulation realism (p. 179) secondo cui l’ipotesi di simulazione non negherebbe la conoscenza dell’universo ma lo interpreterebbe come uno sviluppo di processi computazionali generati da un creatore/programmatore/computer.
Da questo punto in poi, in una sorta di epochè fenomenologica sulla simulation hypothesis (che rimarrebbe indimostrabile e al contempo non sconfessabile), Chalmers risolve il problema gnoseologico sostenendo la piena continuità tra mondo fisico e mondo virtuale, aprendo alla seconda sezione tematica, quella del Metaverso.
Tale sezione viene strutturata a partire definizione di virtual reality come uno spazio immersivo, interattivo e generato da un computer (p. 189). In questo specifico environment, i segnali recepiti dal sistema percettivo dello user, ampliato e integrato dai dispositivi informatici, sono generati da un computer.
Proseguendo nella sua argomentazione, il filosofo australiano pone una distinzione tra virtual reality e virtual world. Ad esempio, i videogiochi, rientrando nella seconda categoria, sarebbero immersivi solo a livello psicologico ma non percettivo poiché non raggiungerebbero la tridimensionalità.
I visori VR, invece, fermandosi ad un’interazione audiovisiva e non raggiungendo un’immersione corporea completa, risulterebbero ancora lontani dalla virtual reality.
Oltre il grado di interattività, ovvero il livello di reciproca alterazione e affezione tra user e ambiente virtuale in un computer-generated world, ciò che distingue un virtual world da una virtual reality consisterebbe nella totale corrispondenza tra corporeità e software, user e dispositivo, reality e plus.
Ed è attraverso questa cerniera bio-informatica che Chalmers pone la tesi dell’extended mind (p. 294) secondo cui la mente potrebbe estendersi oltre il sistema percettivo dello user (corpo-cervello) grazie ai dispositivi informatici. Tale questione scaturisce, per poi ritornarvi, dalle domande poste da Chalmers nel quindicesimo capitolo: «the problem of consciousness» (p. 277) e «can machine be conscious?» (p. 274).
Per rispondere alla tesi riduzionista secondo cui la mente potrebbe esser interpretata come un meccanismo di funzioni neuronali, Chalmers parte dalla distinzione tra coscienza e intelligenza. Quest’ultima, in quanto facoltà, verrebbe intesa come tale poiché derivata da comportamenti che rendano possibile individuare la corrispondenza di un’azione, miratamente eseguita e non casuale, a un risultato o task pre-impostato.
In effetti, secondo questa interpretazione, un comportamento per esser definito intelligente richiederebbe una previsione dell’obiettivo tanto dell’agente quanto dell’osservatore, seppur attraverso modalità di compimento non programmate.
In quest’ottica, secondo Chalmers, non vi saranno problemi allo sviluppo di computer sempre più intelligenti, ascrivibili alla cosiddetta narrow intelligence.
Tutt’altra questione invece riguarderebbe lo sviluppo di una general artificial intelligence, ovvero, nel realizzare l’ipotesi di un sistema di elaborazione dati, computer-robot, provvisto di coscienza fenomenica.
Il limite concreto di tale ipotesi, quale punto di transizione dal problema della coscienza alla macchina cosciente, starebbe nel fatto che la coscienza potrebbe esser riconosciuta oggettivamente esclusivamente tramite la correlazione tra processi neuronali, algoritmi informatici e modelli computazionali.
Tuttavia, la correlazione tra funzioni cognitive e comportamento, seppur trascritta nella computazione informatica, non dimostrerebbe la presenza né spiegherebbe in cosa consista una coscienza fenomenica, intesa come esperienza soggettiva.
Quest’ultima, rimane la questione cardine, il generative core della ricerca del filosofo australiano poiché, in ultima analisi, ancora irrisolta e, probabilmente, irrisolvibile.
Difatti, Chalmers tenta di bypassare il problema del definire cosa sia la coscienza proponendo un escamotage: simulare un cervello già cosciente tramite l’uploading (p. 288). Nella fattispecie, se fosse possibile simulare un cervello che per esperienza diretta risulta cosciente, allora la simulazione stessa dovrebbe esser cosciente (p. 291).
Ed è su questo punto che ritorna l’ipotesi della mente estesa (p. 294) secondo cui la mente potrebbe esser ampliata, ad esempio attraverso la realtà aumentata (p. 299), arrivando alla fase di uploading diretto su un dispositivo informatico (p. 301).
Secondo questa prospettiva, la mente raggiungerebbe (o forse dimostrerebbe?) lo stato di immortalità, abbandonando definitivamente l’interfaccia biologica-corpo per disseminarsi nell’interazione tra sistemi informatici di elaborazione dati.
Questo passaggio risulta quanto mai delicato per l’architettura del testo poiché andrebbe a colmare il salto, l’intervallo, la concrescenza tra la reality e il plus, tra lo user e il dispositivo, tra l’individuo e l’universo, tra l’organico e l’inorganico, realizzando la piena Virtual Reality.
Ciò, ovviamente, restituirebbe degli imponderabili e inediti scenari ontologici, portando alla trasfigurazione del concetto di self (p.307) e la conseguente riformulazione del rapporto tra identità e morale. Tuttavia, proprio perché verrebbe riallineata la sfasatura, il distacco anacronistico (illusorio o meno) tra corpo/dispositivo e mente/universo, probabilmente non vi sarebbe più bisogno di una coscienza indagante tali categorie.
Nella sesta parte del libro, in prosecuzione dell’intersezione tra identità e valore, Chalmers si occupa del problema dell’eguaglianza e della giustizia nei mondi virtuali (p.360).
Se da un lato l’immersione nei mondi virtuali permetterebbe di superare il problema della scarsità materiale ed economica, nel raggiungimento di un’illimitata virtual abundance (p. 361), ciò non implicherebbe un’equa ripartizione di diritti e obblighi tra gli users.
I mondi virtuali, difatti, in quanto utopie dell’abbondanza, potrebbero realizzare dei dislivelli di posizioni gerarchiche e di potere (p. 363) poiché, anche nel caso in cui beni e servizi siano ugualmente distribuiti, non vi sarebbero garanzie politiche, regolatrici dei rapporti sociali e del patto di mutua responsabilità a fondamento di una comunità legislativamente normalizzata.
Come tutte le utopie materializzabili, quindi, i mondi virtuali (presenti e futuri) potrebbero rovesciarsi nel loro opposto, aprendo uno spazio di anomia, generando forme di oppressione e violenza inedite, reiterando oppressioni basate su razza, gender, classe ed etnia (p. 363).
Nel capitolo 23, infine, siamo caduti dal Giardino dell’Eden? (p. 423), Chalmers restituisce la chiusura circolare del testo: il problema del rapporto tra l’immagine manifesta del mondo e l’immagine scientifica della realtà.
Nel suddetto capitolo, il filosofo australiano suggerisce che ogni fase storica, dal momento in cui la mela della conoscenza fu colta, ha dovuto rapportarsi a tale relazione: come interfacciare l’immagine immediata e comunemente riconosciuta del mondo, con l’episteme scientifica che smantellerebbe le certezze della percezione diretta?
All’interno di questo dilemma, che riavvolge l’arco teorico tra la reality e il plus, riflettendo la circolarità tra introduzione e conclusione del testo, Chalmers dichiara di porre in primo piano l’aspetto ricostruttivo (p. 427), ovvero, il ricostruire l’immagine manifesta del mondo compatibilmente all’immagine scientifica.
E questo, come detto fin dalle prime battute, risulta l’obiettivo primo ed ultimo del lavoro di Chalmers: riformulare l’immagine manifesta del mondo (la realtà) a partire da un’ipotesi di simulazione (+) potendo switchare i due poli trovando in essi piena continuità, investigando il rimando costitutivo tra mondo fisico-reale e mondo informatico-virtuale, offrendo una narrazione che possa colmare l’anacronismo tra user e Reality+.
Difatti, il filosofo austrialiano intravede nella sempre più prossima compatibilità, decodificazione e riconoscimento tra mondo fisico-reale e mondo informatico-virtuale il contraccolpo alla caduta dal giardino dell’Eden, ovvero, all’abbandono di un’interpretazione assoluta e intrinseca della qualità degli oggetti-fenomeni.
Gli enti, suggerisce Chalmers, sarebbero reali esclusivamente in funzione di una rete, di una struttura di relazioni, ma non avrebbero un’unita qualitativo-ontologica che li precederebbe, un originario a cui corrispondere, come nell’idealismo platonico (p. 438).
Tale interpretazione, sicuramente figlia del metodo fenomenologico, della relatività generale di Einstein, del principio d’indeterminazione di Heisenberg, sembrerebbe suggerire che tutto ciò che si manifesta nella realtà non sarebbe concluso in sé bensì apparirebbe tale solo poiché in rapporto ad altro.
L’unica via per attraversare tale alterità, paradossalmente, consisterebbe nel circuitare un processo d’unificazione, la coscienza. Quest’ultima, tuttavia, per quanto si sforzi, o venga forzata, a proiettarsi nella stabilizzazione del calcolo informatico, sembrerebbe costitutivamente destinata a non potersi concludere nel mondo manifesto, assecondando la tensione di un movimento infinito di ricerca (p. 462). Tale inconcludenza echeggerebbe l’esistenza di una realtà oggettiva altra (p. 458), di cui la coscienza si riconoscerebbe appendice.
Ed è proprio su questa impossibilità alla conclusione che il testo di Chalmers sembrerebbe ridefinire i contorni di una condizione d’esistenza che, nel suo anacronismo informatico, appare richiedere incessantemente la conferma di esser ancora reale.
Difatti, la realtà non può far altro che ritornare, confermando, parimenti alla propria gravità, un’oggettività ed estraneità irriducibile alla comprensione ultima della coscienza che, in fin dei conti, testimonia una sfasatura incolmabile, circuitabile esclusivamente nell’unica verità oggettiva: «Reality exists, independently of us. The truth matters» (p. XXIV).
Valerio Specchio
S&F_n. 30_2023