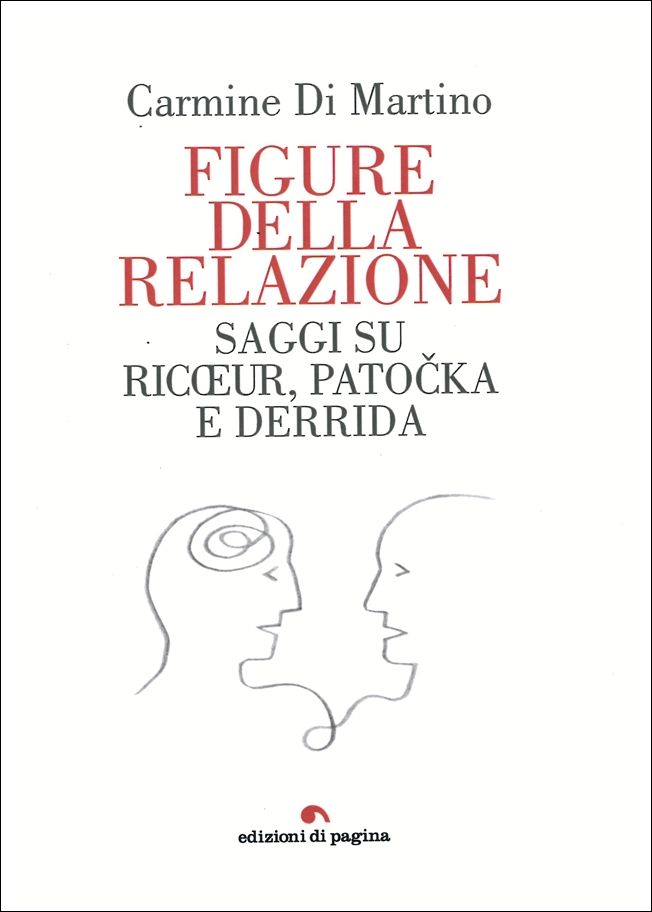È possibile «riscrivere un’autobiografia della soggettività nel lessico dell’ospitalità»? Più che possibile, parola che poco si addice all’“evento” di Altri, potremmo definire attuale e urgente lo sforzo che va profilandosi all’interno del testo: l’evento e l’avvento di Altri – che oggi bussa prepotentemente alla porta nella veste del profugo, dello straniero, del migrante, la cui sola presenza, che è già da sempre appello, mette in discussione il libero godimento del Medesimo a “casa propria”, per parafrasare Lévinas – sembra mettere alla prova la capacità umana di accogliere e lo stesso diritto di ogni vita umana ad avere diritti.
Il testo costituisce un tentativo di pensare e ripensare la relazione e dunque l’accoglienza facendo dialogare autori come Ricœur, Patočka e Derrida che a lungo si sono interrogati sulla questione dell’Altro. Heidegger è di fatto l’interlocutore, sebbene talvolta polemico, dei tre studiosi, per la sua messa in discussione del solipsismo del cogito che pone innanzi a sé altro e altri in prima istanza come oggetti della rappresentazione. L’esserci è infatti da sempre e originariamente in relazione, è essere-con.
Per Ricœur al cuore stesso dell’ipseità vi è altri. In accordo con Heidegger il Dasein più che autoporsi si riconosce nelle proprie realizzazioni, nella cura per Heidegger, che in Ricœur diventa agire. Il sé si riconosce dunque nelle sue esteriorizzazioni e prendendo le mosse dall’agire esso diventa un «mobile punto d’arrivo, non un punto di partenza che si auto-possiede in trasparenza: esso perviene a se stesso a partire dalle (proprie) esteriorizzazioni intenzionali» (p. 22). È l’azione che conduce al sé e non viceversa.
La parola Ipseità sporge rispetto alla Medesimezza perché è consustanzialmente legata al tempo, cangiante e mutevole e tuttavia in grado di acquisire una permanenza nel tempo diversa rispetto alla costanza del carattere. La permanenza costituisce un tipo di resistenza «che ha un’irriducibile stoffa etica, il senso di un’assunzione responsabile» (p. 27) e si manifesta nella capacità di mantenere una promessa. Esiste allora una implicazione originaria tra identità e alterità. Entrambe le istanze non sono fondative, poiché al contrario è di nuovo: «la facoltà di agire a trovarsi in posizione di fondamento». Ecco perché l’ipseità più che un dato costituisce un traguardo dell’umano che ha sempre da compiersi e che non è mai garantito una volta per tutte.
La prima tappa del riconoscimento di sé sta nell’essere riconosciuti, traguardo che non si ottiene attraverso la lotta di hegeliana memoria, bensì nell’amore, nell’accoglienza da parte di altri. La madre è figura prima dell’accoglienza e del riconoscimento, originario volano della costruzione del sé. Da Freud, a Spitz, a Winnicott, la cura diventa allora elemento pregnante per il raggiungimento di quel traguardo che è per l’appunto l’ipseità. L’originaria relazione che produce e può anche non produrre il riconoscimento, presenta una struttura quasi paradossale al contempo di dissimmetria e reciprocità: «Se interroghiamo genealogicamente il costituirsi dell’ipseità […] troviamo una “struttura dialogale asimmetrica” come sua condizione necessaria» (p. 39).
Anche Patočka in debito con Heidegger, intende l’esistenza come movimento di realizzazione di possibilità. Primo movimento è quello del radicamento. E tuttavia per Patočka l’esserci va guadagnandosi il mondo a partire dall’accoglienza da parte degli altri: «è negli altri che la terra diventa calda, amabile, benigna» (p. 44); potremmo dire che l’altro redime la nostra originaria condizione di gettatezza.
Nondimeno Heidegger si sofferma sulla dimensione deiettiva della relazione, che si concretizza nella chiacchiera, nella curiosità e nell’equivoco; la dimensione autentica cui il Dasein tende è risultato di una solitudine che va allontanandosi dalla immersione deiettiva nel e col mondo: «In Heidegger, l’autenticità si coniuga dunque con l’assoluta solitudine della decisione anticipatrice della morte» (p. 45). Al contrario per Patočka, l’io va riconoscendosi in prima istanza attraverso il rispecchiamento con un tu, nel suo volto, nello sguardo, nella cura. Ancora una volta ritorna la madre, volto originario, specchio ancestrale nel quale cogliamo la nostra immagine: «L’alterità si situa dunque al cuore del divenire di ciascuno di noi, non si aggiunge in un secondo momento a un’ identità che sarebbe già fatta prima del contatto» (p. 48). Anche in questo caso la relazione originaria col tu materno presenta il paradosso di una reciprocità asimmetrica e anche in tal caso, l’identificazione, sostituisce l’identità, la processualità dinamica abolisce la staticità delle essenze, dacché anche in questo caso il farsi umano dell’uomo è un cammino mai concluso e sempre da rinnovarsi e confermarsi.
Se il radicamento costituisce il movimento primo dell’esistenza, essa prosegue con quello che Patočka definisce “prolungamento di sé” che coincide con il lavoro, che ancora rimanda alla dimensione relazionale, tuttavia va esplicitandosi a partire da giochi di potere e dunque dalla lotta. Da questo sfondo si sviluppa il terzo movimento, quello dell’apertura, della “dedizione di sé”, nel quale «la vita pone invece il problema di se stessa, del suo senso e a partire da ciò diviene liberamente umana» (p. 51). Questo è lo spazio del mondo condiviso, della comunità, che per Patočka deve essere comunità di eguali, polis, dove va sviluppandosi il “reciproco riconoscimento nell’azione”. Ciò comporta l’affrancamento dalla nuda vita e tuttavia non sempre questa dimensione diviene storicamente fattiva, lo dimostrano le stesse vicissitudini politiche del pensatore ceco.
Malgrado le atrocità della Grande Guerra, che ha determinato l’asservimento alla nuda vita, non si è riusciti a trasferire questa esperienza e a trasformarla in istanza duratura alla pace. Per Patočka l’antidoto starebbe nella solidarietà degli scossi, di coloro che, feriti da certi eventi tragici, sono in grado di dire no «a quelle misure di mobilitazione che mirano a eterizzare lo stato di guerra […]» (p.55). La solidarietà degli scossi sta allora su un livello pre-politico e tuttavia «la scommessa è che quello che accade a questo livello – attraverso individui determinati e la solidarietà fra essi – possa incalzare il piano storico-politico, che pure si presenta caratterizzato dalla lotta, dal calcolo, quando non dalla potenza, dalla violenza e dalla guerra» (p. 56).
Da ultimo l’autore fa parlare Derrida, lettore e interprete di Lévinas, che ha pensato l’etica come filosofia prima tesa a spezzare il giogo dell’ontologia. Accogliere è atto pre-originario è l’Eccomi lontano dall’appropriazione noetica del mondo, è uno stare in balia di Altri, che trascende ogni mia possibilità di categorizzare, che a ogni istante mette in scacco la mia logica “appropriante”. Anche in questo caso è impossibile fare a meno del dialogo, per quanto polemico con Heidegger, che sembrerebbe ignorare: «l’originaria iscrizione dell’esserci in una irriducibile eteronomia, in uno squilibrio originario, vale a dire nella dipendenza costitutiva dallo sguardo, dal riconoscimento e dal desiderio dell’altro» (p. 61).
Il soggetto viene dunque a sé a partire da una soggezione da una passività originaria; come per Lévinas, la parola Io significa Eccomi, l’io diviene nella risposta, «nel modo del già aver sempre detto sì all’altro», la sua responsabilità dunque precede la sua libertà. L’ospitalità perciò si pone come modalità d’essere anteriore a ogni scelta.
E tuttavia al di là dell’evento a-nacronistico di Altri e dell’incondizionato sì del Medesimo, esiste un mondo storico di fatti che attestano il No delle leggi e dei procedimenti, l’inospitalità fattiva di porti chiusi e di muri alle frontiere.
Ecco perché l’autore si domanda quale sia il rapporto tra l’eterogeneità radicale di «un’ospitalità infinita, incondizionata, impossibile, eccessiva – che possiamo indicare come un’apertura pre-etica dell’etica –, e un’etica, un diritto, una politica dell’ospitalità?» (p. 74). Termini antinomici e tuttavia, come vuole Derrida, intrinsecamente intrecciati, poiché solo attraverso l’impossibile dell’incondizionato, il suo eccesso, si fa possibile la storia col suo carico di errori e le sue infinite possibilità di aggiustamenti, insomma il suo a-venire.
La storia allora deve svilupparsi tentando di dare vita all’ossimoro di negoziare sempre in nome e per conto dell’incondizionato. È qui che risiede la vera responsabilità, in una certa esperienza della possibilità dell’impossibile, in un double bind, per parafrasare Derrida.
La nuda vita invece, quella che non ha diritto ad avere diritti, ci appare costantemente dinnanzi agli occhi senza quasi più suscitare effetto: siamo bombardati da immagini di corpi ammassati su improbabili imbarcazioni, lasciati lì, in attesa, a guardare da lontano una terra vicina e un’ospitalità che si fa sempre più lontana. Allora la riflessione di Derrida, sulla vita e sul suo potere auto-immune si fa sempre più scottante.
Attraverso il processo autoimmunitario un organismo distrugge se stesso, va suicidandosi, o distrugge le proprie protezioni, come immunizzazione dall’immunità; come sostenuto da Derrida il vivente può “spontaneamente distruggere, in modo autonomo ciò stesso che, in lui, è destinato a proteggerlo contro l’intrusione aggressiva dell’altro”.
La fatalità autoimmunitaria è iscritta anche nel cuore della democrazia, che è fin dall’inizio «esposta al rischio della propria autodistruzione e, in un certo senso, intrinsecamente suicida» (p. 89). Ne sono un esempio gli accadimenti dell’11 settembre; dopo di essi la democrazia per auto-tutelarsi è andata aggredendo se stessa e il proprio sistema di diritti. E tuttavia come la biologia e la medicina insegnano, la minaccia di un’alterità che originariamente e da sempre minaccia ogni vita è al contempo anche chance senza la quale nessuna vita è possibile: «Un vivente non autoimmune, cioè non vulnerabile alla intrusione dell’altro, capace di una filtrazione assoluta, è infatti assolutamente morto» (p. 93). Vivere è dunque alterarsi contaminarsi in un quella che per Freud è una inestricabile coimplicazione vita morte.
Vivere in fondo è da sempre sopra-vivere, cioè «uscire da sé, protendersi oltre sé, esporsi all’altro, alla morte, tracciandosi, alterandosi, distaccandosi, rinunciando alla (illusione della) purezza» (p. 96).
Sopra-viviamo anche perché costantemente viviamo al di sopra delle possibilità stesse della vita, in bilico, tragicamente abbracciati alla morte. La vita come tale resta evento dalla struttura messianica che apre all’orizzonte sempre più contemporaneo di un’attesa senza orizzonte di attesa: la venuta imprevedibile dell’altro accomuna tutti i viventi e ci rende tutti esposti.
Fabiana Gambardella
S&F_n. 19_2018