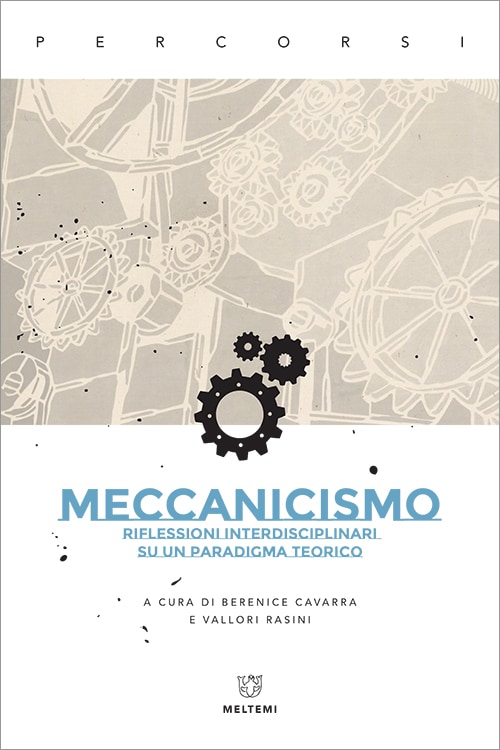Organico/meccanico: di metafore, paradossi e antinomie
Siamo animali che producono metafore. Esse sono da sempre l’esorcismo contro l’inspiegabile, il tentativo di addomesticare ciò che pare ostile ad ogni forma di chiarificazione, ciò che resta oscuro e a tratti impenetrabile. Quando l’intelletto poi, posa lo sguardo sulla vita, e tenta di dirla, allora la lingua pare sbizzarrirsi nella produzione esorbitante di metafore, antinomie e paradossi. Certo dire della pietra sembra più facile: ignara, essa giace sul sentiero, tocca la terra e non lo sa. Ma rendere conto di una totalità che diviene, di un tutto che ostinatamente e con pervicacia si impegna per trascendere la lineare composizione delle sue parti, diventa compito gravoso e complesso.
Il testo Meccanicismo. Riflessioni interdisciplinari su un paradigma teorico, a cura di Berenice Cavarra e Vallori Rasini, nasce da uno stimolante convegno svoltosi tra il 14 e 15 dicembre 2017 all’Università di Modena e Reggio Emilia, attraversa, con i suoi variegati contributi, la storia di un pensiero che tenta di raccontare la realtà a partire dai due paradigmi di meccanicismo e organicismo, dalle diverse declinazioni che essi prendono nel tempo, dalle metafore più o meno creative che li accompagnano.
Se è vero, come secoli di filosofia insegnano, che l’identità può delinearsi solo e sempre a partire dal suo contrario, l’analisi sul tema della vita si è prodotta a partire dalla definizione di antinomie. Come quella paradigmatica di meccanico e organico, di cui parla Antonello La Vergata, docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
A prescindere dalle diverse configurazioni che il termine meccanico ha preso nel corso del tempo, alla base di questo modo di teorizzare il vivente, c’è l’idea che i fenomeni che lo riguardano possano essere descritti ed esplicitati «con gli stessi strumenti, metodi, concetti, leggi che spiegano i fenomeni inorganici» (p. 21). Al contrario l’organicismo non si accontenta di questa riduzione e postula per la vita una «irriducibilità di principio» (ibid).
E tuttavia tali termini non possono mai darsi in maniera totalmente autonoma e nel corso del tempo hanno trovato in alcune ricerche il modo di ibridarsi, sottraendo gli studiosi alla scelta tra l’uno o l’altro dei poli in questione: uno fra tutti Claude Bernard, «il cui vitalismo fisico cercava di conciliare la credenza nel determinismo assoluto dei fenomeni vitali con la rivendicazione della loro specificità» (p. 22).
Ma l’evolversi delle conoscenze e prassi scientifiche ha determinato anche mutamenti nei modi di interpretare le due locuzioni. In questo caso la fisica quantistica produce la crisi della tradizionale concezione meccanicistica. Meccanico e deterministico non coincidono più, il determinismo è appannaggio di una dimensione metafisica e necessitarista del XVII secolo, a cui Peirce, ad esempio, «oppose la nozione della contingenza della natura» (p. 24). Il caso, inteso non solo come ignoranza delle cause, ma anche come indeterminazione delle cose, entra prepotentemente nella delineazione dei fenomeni viventi.
A partire da tali innovazioni la natura non è più interpretata come materia bensì come processo e insieme di relazioni, per cui il tutto, effettivamente è più della somma delle parti.
Bisogna inoltre specificare che in molti casi, «credere o no che la biologia sia riconducibile alla fisica, non ha conseguenze dirette sulla pratica dei ricercatori» (p. 32). La storia della scienza insegna infatti che molti progressi sono stati fatti nella conoscenza del vivente, talvolta attraverso processi di riduzione talaltra, al contrario, attraverso pratiche di complessificazione.
In effetti per la fisica meccanicistica classica, come sostenuto dal Prof. Barone dell’Università del Piemonte, tutto si riduce a materia e movimento, regolate da «leggi di evoluzione temporale espresse in forma matematica» (p. 111). Comprendere un fenomeno significa ricondurlo a tali leggi e dunque poterne prevedere anche il comportamento futuro.
Tuttavia è necessario distinguere tra le leggi intese come regolarità della natura per questo conoscibili, e le condizioni iniziali, che al contrario risultano del tutto accidentali. La fisica si occupa di scoprire le leggi.
Quando nel XX secolo irrompono la meccanica relativistica e quella quantistica, l’apparato newtoniano, esplicativo di tutto l’universo materiale, comincia a sfaldarsi. La fisica del Novecento va infatti a minare i due assunti del meccanicismo fisico: «da una parte, la conoscenza del mondo naturale si è arricchita di un livello esplicativo più generale di quello delle leggi dinamiche – il livello dei principi di invarianza o di simmetria – dall’altra, il dualismo particelle campi si è risolto con la nascita della teoria quantistica dei campi, che individua nei campi quantistici le entità primarie del mondo fisico e prevede la possibilità che le particelle vengano create e distrutte, demolendo così l’assunto ontologico del meccanicismo» (pp. 113-114). Con la relatività einsteniana si passa realmente da «una fisica delle leggi a una fisica dei principi» (p. 117), dando vita a una gerarchia della conoscenza caratterizzata da tre livelli: «gli eventi, che sono le informazioni più dirette sul mondo, le leggi che governano gli eventi; i principi di invarianza che vincolano le leggi» (ibid). Ad ogni modo pare che la direzione della fisica volga a un sempre maggior grado di necessità delle teorie. L’idea prevalente è che al livello fondamentale della natura tutto sia governato da un unico principio di invarianza ancora sconosciuto, oppure, come sostenuto da Wheeler, forse non ci sono leggi davvero fondamentali ma tutto è «costruito alla rinfusa sui risultati impredicibili di miliardi e miliardi di fenomeni quantistici elementari» (p. 124). In altre parole quelle che chiamiamo leggi di natura sarebbero proprietà emergenti da un substrato caotico per azione di un principio regolatore.
Percorso analogo di ricostruzione della logica dualistica che fonda l’Occidente, e che si esprime, nella descrizione della vita, attraverso la dicotomia meccanico-organico, viene intrapreso Bernardino Fantini dell’Università di Ginevra.
Anche in questo caso lo studioso pone l’accento sull’inestricabilità di fondo dei due termini, sul loro valore congiuntivo più che disgiuntivo.
Utilizziamo il termine macchina in presenza di quattro caratteristiche : «la presenza di elementi diversi, i legami causali fra tali elementi, lo svolgimento di azioni specifiche e il funzionamento diretto a uno scopo» (p. 65). Se la causa efficiente regola il comportamento della macchina, la causa finale viene utilizzata in relazione alla parola organismo, per metterne in evidenza la dimensione di progetto, la cui unità trascende il funzionamento delle singole parti. Ed ecco che si giunge alla seconda dicotomia pregnante nella spiegazione della vita, quella di meccanico e progetto. La scienza moderna inaugura l’applicazione del meccanicismo al mondo vivente e tuttavia anche in questo contesto le dimensioni di senso vanno spesso intrecciandosi e contaminandosi. Ne è autorevole emblema la filosofia di Descartes, che, sebbene riduca la descrizione della vita alle dimensioni di materia e movimento, allorché va designando al vertice dei gradi dell’organico un artefice divino, conferma l’inestricabilità delle opposizioni e la paradossalità sempre possibile, di un “meccanicismo teologico”. È alla fine del 1600, con Georg Ernst Sthal che il concetto di organismo viene utilizzato in maniera tecnica e quando nel 1729 Louis Bourguet parlerà delle macchine viventi come di macchine idrauliche, sarà costretto ad ammettere «che esistono dei fenomeni, come il funzionamento globale di un corpo organizzato o la sua riproduzione, che non si potranno spiegare con la pura meccanica» (p. 70).
Col tempo le metafore si susseguono e amplificano: la seconda metà del’Ottocento, con lo sviluppo della chimica organica vede la sostituzione della metafora della macchina con quella della fabbrica chimica, «in cui le reazioni e le catalisi enzimatiche prendono il posto delle forze meccaniche o idrauliche dei modelli seicenteschi» (p. 71). La scoperta del DNA pare confermare l’ipotesi meccanicistica; come sostenuto infatti da Francis Crick: «lo scopo ultimo del movimento moderno in biologia è in effetti spiegare tutta la biologia nei termini della fisica e della chimica» (p. 74). Tuttavia, ciò che fisica e chimica non spiegherebbero è la straordinaria qualità del progetto vivente (ibid.). Come sostenuto da Monod, i sistemi viventi sono dotati di teleonomia, morfogenesi autonoma e invarianza riproduttiva. La parola teleonomia sta allora a indicare il progetto dei viventi, «conservato nelle loro strutture e realizzato dalle loro funzioni, progetto che dà origine a un determinismo autonomo, a una “libertà” quasi totale» (p. 76).
Questo perché i sistemi viventi sono individui ma al contempo elementi di un insieme di relazioni. La loro complessità è stata nel tempo esplicitata attraverso l’uso di una serie di metafore. Il cristallo rende conto della stabilità del sistema, la freccia, icona delle scienze biologiche contemporanee, racconta dei processi dinamici, delle interazioni e degli scambi; il libro della vita rende conto del genoma: «il programma come insieme di messaggi conservati e trasmessi è indipendente dalla materia di cui è composto».
Tra essere e divenire
In che modo un organismo diviene dunque e che cosa si intende con la parola sviluppo? È quello che prova a spiegare Alessandro Minelli dell’Università di Padova, secondo cui la nozione tradizionale dello sviluppo peccherebbe di adultocentrismo, caratterizzandosi come «la sequenza dei processi che legano tra loro l’uovo e l’adulto» (p. 48). Lo scopo dello sviluppo sarebbe allora l’individuo adulto, come se un processo di rigenerazione non dovesse essere considerato alla stessa stregua di un processo di sviluppo. Per quanto sia vero che l’individuo è prodotto dallo sviluppo, esso tuttavia non ne è definito. Ecco perché risulta necessario distinguere tra «lo sviluppo come processo e lo sviluppo storicizzato nel singolo individuo» (p. 49). Perciò alla nozione tradizionale di sviluppo sembra opportuno sostituirne un’altra che lo definisce come «sequenza temporale di cambiamenti nell’organizzazione di un sistema vivente» (p. 51). Se dunque si evita di stabilire un punto dell’origine (l’uovo) e una fine espressa nell’adulto «la traiettoria di un generico processo di sviluppo rimane assimilabile a un segmento aperto» (ibid). L’autore procede attraverso un itinerario che va dalla meccanica dello sviluppo di Roux contrapposta al vitalismo di Drietsch, all’uso dei servosistemi per comprendere il fenomeno della vita, fino alla metafora del computer per rendere conto del programma scritto nei geni. Tuttavia per quanto risulti affascinante, tale metafora non è integralmente calzante: «La relazione tra genotipo e fenotipo non è lineare né univoca né totalmente predittibile», difficile marcare una linea netta che distingua i processi di sviluppo controllati dai geni da quelli modulati da fattori ambientali. È necessario allora superare il meccanicismo, riformularlo? «Per il momento sembra si debba concludere che nella costruzione di un fenotipo non c’è un determinismo meccanico più stretto di quello che dobbiamo riconoscere nelle vicende della vita quotidiana dove esso può dimostrare la sua fitness» (p. 61).
A proposito di “quello che i geni non dicono”, Mauro Mandrioli, dell’Università di Modena e Reggio Emilia ci mostra quanto a partire dal progetto genoma sia andata rafforzandosi una biologia genocentrica, che intendeva la definizione completa del vivente a partire dal suo corredo genetico, in grado di renderne conto in maniera integrale. In effetti come sostenuto da Rutheford, l’uomo necessita delle grandi narrazioni totalizzanti, per dare senso alle cose . Il genoma pareva potesse dirci chi siamo e perché. Ma, si chiede l’autore, è davvero solo il genoma a definire ciò che siamo?
Il genoma esprime certo ciò che siamo nel senso della nostra virtualità, e tuttavia il fatto che essa si attualizzi o meno non è purtroppo, o per fortuna, scritto al suo interno. Ecco perché l’epigenetica costituisce una dimensione importante nello studio della vita, poiché l’ambiente scrive sui nostri geni. Essa infatti si interessa di «variazioni del fenotipo che avvengono in assenza di variazioni nel genotipo» (p. 132).
Il fatto che sia dunque anche l’ambiente a forgiare quanto siamo pare evidente davanti ai gemelli, che, per quanto caratterizzati dal medesimo genotipo presentano delle differenze, addirittura nello sviluppo delle patologie. Ecco perché è forse ancora più importante nello studio della vita comprendere ciò che i geni non dicono. Tale difficoltà di ridurre la vita a un determinismo biologico racconta infatti della sua complessità.
Il Meccanicismo nella storia del pensiero
La disputa relativa al meccanicismo è già presente nell’Aristotele dossografo, come ci racconta una delle curatrici del testo, Berenice Cavarra, dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Sebbene talvolta impegnato a interpretare il passato in relazione alle sue peculiari istanze teoretiche, nel quarto libro della Physica, lo Stagirita affronta il problema del luogo: di contro ad Anassagora, Aristotele sostiene che «ogni cosa è trasportata verso il proprio luogo, se niente l’ostacola» […] (p. 152). Già in questo passaggio è implicita la critica all’atomismo, che interpreta le costituenti elementari come aventi «una stessa natura qualitativa», differenti solo per forma, dimensione e posizione. Materia e movimento conducono immediatamente al problema delle cause, a cui Aristotele dedica il secondo libro della Physica. Sostenendo che la natura è fine, Aristotele va criticando la spiegazione meccanicistica dell’universo, mettendo in evidenza l’aporia in cui incappano teorie come quella di Empedocle o degli atomisti che attribuiscono al caso la generazione del cielo e delle sfere divine, mentre le cose terrene sono generate non a caso: «Per conseguire un risultato è certamente necessario il contributo delle “cose che hanno una natura necessaria”, ma non è a causa di queste che qualcosa viene prodotto, bensì a causa di una finalità» (p. 156). Tale dibattito è approfondito dai commentatori di Aristotele, Giovanni Filopono e Simplicio di Cilicia. Per Filopono, la natura non solo agisce per un fine, ma secondo un buon fine, per il bene. Sempre commentando il passo 198b della Physica, Simplicio rende conto del fatto che per Aristotele «la materia è soggetta alla necessità in vista di un fine e non viceversa. Il fine non esiste “di necessità”, ma la necessità esiste in funzione del fine. La vera necessità, quindi, è la forma, o il progetto che essa realizza e che spesso rimane celato alla comprensione umana» (p. 164).
Anche i sistemi complessi come le società possono e sono state spesso interpretate in senso meccanicistico. Thomas Hobbes di contro proprio al finalismo di Aristotele, si impegna nel delineare una riflessione, che a tutti i livelli possa considerarsi meccanicistica, materialistica e deterministica. Ciò avviene già a partire dall’importante critica al concetto aristotelico dell’uomo come zoon politikon, a fondamento dell’ordine politico. Il sistema hobbesiano procede dunque a descrivere il mondo attraverso materia, movimento e causa efficiente. Carlo Altini, dell’Università di Modena e Reggio, prova a chiedersi se Hobbes abbia davvero costruito un «sistema radicalmente meccanicistico sotto tutti i punti di vista» (p. 173).
È soprattutto nel Leviatano che Hobbes fa un largo uso della metafora meccanica per descrivere la natura dello Stato, che altro non è che un uomo artificiale dotato di un’anima artificiale che si esprime come sovranità. E tuttavia malgrado l’utilizzo quasi iperbolico di metafore macchiniche per spiegare lo Stato, le sue parti e il suo funzionamento, si accompagna, nella stessa opera una parallela immagine dello Stato come come “persona sovrano-rappresentativa”. Questa prospettiva doppia emerge proprio nella dualità di una visione meccanicistica del sovrano «che esercita il proprio potere assoluto attenendosi ai criteri della legge positiva da lui stesso creata e l’immagine personalistica di un sovrano che esercita il proprio potere assoluto sospendendo a suo piacimento la validità delle leggi positive» (175-176).
Figura aporetica, il Leviatano è al contempo grande animale, grande macchina e Dio mortale esso pare condensare in sé meccanica e capriccio, legge inderogabile e arbitrio personalistico.
La domanda allora da porsi è se Hobbes sia un «precursore del decisionismo politico o del positivismo giuridico» (p. 179). E in effetti nell’opera hobbesiana le leggi sono tali non per la loro bontà ma solo come strumento di comando in possesso dell’autorità che le legittima, poiché senza tale autorità non c’è legge, mentre il sovrano esiste prima di esse ed esse sono sospese alla sua decisione arbitraria. In altre parole laddove la sovranità descritta da Hobbes si pone come volontà piuttosto che come ragione, che può anche sospendere a suo piacimento la legge, si allontana naturalmente dal modello razionale, impersonale e meccanico. Il saggio procede con un interessante confronto con Spinoza.
Di animali macchina come topoi della riflessione postcartesiana, si occupa Matteo Marcheschi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. In particolare si focalizza sull’opera del medico animista Stahl, tesa proprio a rilevare la differenza tra macchina e organismo, attraverso l’uso di una serie di metafore, che potremmo definire per certi versi spaesanti: il movimento dell’acqua che scorre naturalmente nel letto di un fiume viene considerato infatti meccanico, mentre al contrario le acque assumono un carattere organico laddove è paradossalmente l’artificio dell’uomo a incanalarle e direzionarle. Questo perché in tal modo esse rispondono a un fine.
Ecco perché utilizzare la metafora dell’organismo piuttosto che quella della macchina non significa «descrivere una proprietà, ma fondare un modello metaforico» (p. 197), che va a forgiare, innestandosi su ulteriori metafore, un orizzonte rappresentativo. Le metafore interagiscono e retroagiscono su quella iniziale, modellando i caratteri stessi dei paradigmi a cui fanno capo. A tal proposito è interessante notare come in questo caso l’organismo non sia ontologicamente altro rispetto alla macchina, quanto piuttosto una macchina dotata di finalità. Tali metafore ci dicono inoltre che il XVIII Secolo è teso a mostrare i livelli di interazione tra natura e artificio, basti pensare agli automi di Vaucanson, su cui riflette Diderot, che le vede talmente perfette da mettere in discussione i rigidi confini tra meccanico e organico. Per Diderot, che pare scegliere una terza via tra il modello finalistico e quello cartesiano, non è tanto l’animale a essere una macchina, bensì gli automi sempre più perfetti che vanno costruendosi, a divenire quasi animali. Dunque «anche le macchine possono aspirare a diventare animali» (p. 205). E allora ecco ancora un proliferare di metafore che si sovrappongono: l’uomo come clavicembalo che esiste vibrando, giacché per Diderot «ciascuno è il prodotto della peculiare intersezione tra la propria determinatezza biologica e la plasticità che l’esperienza modella costantemente» (ibid.). Diderot gioca con le metafore poiché comprende che la trasposizione analogica costante rende l’infinita attività metamorfica del reale.
Uno squarcio sul pensiero di La Mettrie, medico e filosofo non sistematico, ci è offerto da Fabio Polidori dell’Università di Trieste. Provocatore di professione, ne L’uomo macchina La Mettrie si diverte a stanare ogni forma di certezza dogmatica: poiché non ne sappiamo assolutamente niente del nostro destino o delle nostre origini, non ci resta che arrenderci alla nostra ignoranza, da cui, tra l’altro, dipende la nostra felicità.
Questo limite viene violato da chi osa trascendere i confini dell’esperienza allo scopo di giungere a una qualche conoscenza universale. La Mettrie elogia il meccanicismo di Descartes forzando il suo dettato e arrivando a sostenere che l’ambigua faccenda delle due sostanze fosse solo l’escamotage che il filosofo aveva trovato per giustificare la sua eresia agli occhi dei teologi. Il meccanicismo di questo provocatore è tuttavia più attento di quanto non si creda: esso infatti prende in considerazione il peculiare dinamismo che caratterizza il vivente, facendolo rientrare tuttavia nella sfera materiale. Infatti una volta eliminata la tentazione «di ricorrere a un principio trascendente […] la dimensione stessa dell’umano può presentarsi come una naturale progressione di quanto, internamente alla materia, si evolve per gradi successivi» (p. 224). Il metodo di La Mettrie, lungi dal condurre ad esiti scettici intende, salvaguardando l’ignoranza circa le origini e i fini, e attendendosi all’esperienza mai paga di un assetto definitivo, mantenere viva la ricerca.
L’ombra di Cartesio aleggia anche nella riflessione Novecentesca, spesso in chiave polemica. Di Arnold Gehlen ci racconta la professoressa Rasini, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, curatrice del testo. Gehlen deplora a Cartesio la scissione di ambiti del reale e del sapere, tra l’altro persistente anche ai giorni nostri. Per Gehlen è necessario descrivere l’umano a partire dalla sua unità e tale unità è rinvenuta nella categoria di azione. Vale a dire: la natura dice ciò che l’uomo è, cioè un ente caratterizzato dalla costante necessità di agire. Ente biologicamente carente, l’umano si costituisce attraverso l’azione che produce tecnica e attraverso una tecnica che costantemente forgia l’umano. La tecnica è naturale nell’uomo, gli è «ontologicamente essenziale» (p. 230), poiché senza tale stampella la sua originaria carenza biologica gli sarebbe stata fatale. L’agire tecnico è dunque per l’uomo «fondamento antropologico, non un risultato evolutivo» (p. 231). Instabile per natura, carente e alla mercé degli elementi, alla continua ricerca di sicurezza, l’uomo esercita la propria abilità tecnica proiettando fuori di sé «caratteristiche che gli appartengono, e innanzitutto la ritmicità dei propri processi organici» (p. 232). Dalle rudimentali tecniche magiche ai moderni espedienti artefattuali e culturali, l’umano prova a piegare l’ostilità della natura ai propri bisogni.
Alla base della trasposizione oggettivante, ci sarebbero secondo Gehlen delle invarianti strutturali, che di solito sono legate alla ritmicità, evidenti già nel Gestaltkreis, il circolo percezione-azione; attraverso di esse acquisiamo esperienze aumentando le nostre possibilità di sopravvivenza. L’umano dunque subisce il fascino degli automatismi, grazie ai quali forgia abitudini in grado di affrontare esperienze “problematiche”, senza tirare costantemente in gioco il compito arduo della riflessione. L’abitudine inoltre sarebbe anche alla base della stabilizzazione sociale che «non solo unilateralizza l’agire, impone cioè una precisa direzione al comportamento, ma contribuisce a rendere durature e collettivamente riconoscibili determinate modalità d’azione» (p.236). Le istituzioni allora risultano proprio gli organi a garanzia della stabilità, che ottengono attraverso il potere obbligante. Se ritmo, ripetizione, automatismo sono alla base della continuità tra vita interiore e agire esteriore, «il “perfezionamento” dell’umanità dell’uomo pare darsi proprio nella direzione di una sempre maggiore meccanizzazione» (p. 239). Tuttavia Gehlen non accoglie l’idea di una natura meccanica della vita: «non sovrappone insomma fenomeno vitale e attività meccanica, ma si esprime in termini di “isomorfismo”, di “uguaglianza delle forme” nei processi vitali e nelle attività della macchina» (p. 240).
Il contributo di Marco Ciardi, dell’Università di Bologna, focalizza l’attenzione sulle vicissitudini delle discipline economiche. Anche l’economia classica a un certo punto comincia ad avanzare una pretesa di oggettività, cercando di individuare modelli e leggi stabili, pur nella consapevolezza della non eternità delle strutture economiche. Léon Walras, tra i fondatori della scuola di economia neoclassica «si sforzò di fare per l’economia quello che Newton aveva fatto due secoli prima per la meccanica celeste» (p. 243). Il suo programma fu seguito da Vilfredo Pareto, intento a ripulire la scienza economica da ogni residuo di politica o filosofia. Il testo procede con un’interessante ricognizione del contesto storico «all’interno del quale, nel periodo di transizione dal Regno di Sardegna all’Unità d’Italia, gli studi ingegneristici esercitarono un’influenza sui fondamenti dell’economia, pensata come una scienza naturale» (p. 245). È chiaro dunque che la scienza economica neoclassica si è andata delineando nell’ambito del paradigma meccanicistico paradossalmente proprio quando la rivoluzione darwiniana e quella termodinamica andavano sconvolgendo i precedenti assetti stabili e introducevano il paradigma «del divenire della natura, del tempo irreversibile, dell’evoluzione cosmica» (p. 254). Dopo la lunga egemonia dell’impianto meccanicistico, la contemporaneità prova a riflettere su un rinnovamento delle scienze economiche legato proprio alla nascita di nuovi modelli epistemologici, senza tuttavia rinunciare del tutto a una qualche forma di oggettività.
Continuiamo insomma ad avere bisogno di grandi narrazioni o quantomeno, pur nella mirabolante progressione di ricerca e scoperte, l’umano non si stanca di anelare a una qualche forma di oggettività come dimora stabile, seppur temporanea, dove di tanto in tanto sostare.
Fabiana Gambardella
S&F_n. 24_2020