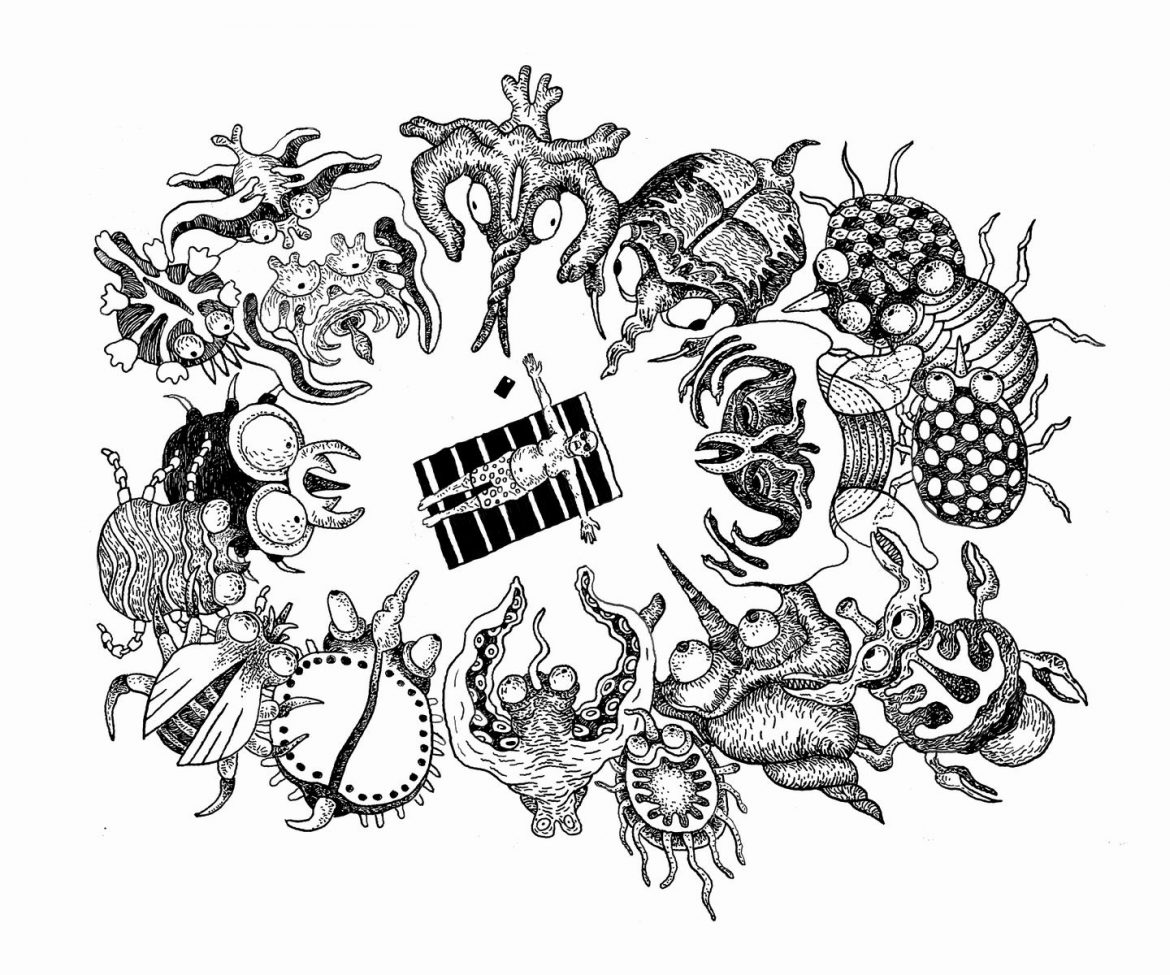Autore
Indice
- Bergson “megarico”?
- Il labirinto della libertà
- Un megarismo bergsoniano?
↓ download pdf
S&F_n. 25_2021_APPENDICE
Abstract
“The Error of Determinism and the Illusion of its Opponents”. The “megarian” Antimechanism of Bergson
In the third chapter of the Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson puts forward a purely megarian thesis on freedom. In order to found real freedom, he says, it must be emended from the possible. Only in this way will freedom be preserved from deterministic objection. To found metaphysical freedom by purifying it of contingency is a very paradoxical thesis to which, however, Bergson will always remain faithful. Bergson’s “megarism” has remained largely unnoticed despite the fact that it has been lying, like the purloined letter from Poe’s tale, on his desk since 1889. After Bergson we can therefore reconsider the meaning of megarian philosophy. We are, so to speak, “allowed” to ask ourselves whether those bizarre thinkers were really intransigent Eleatics or early process philosophers, pantheists and radical immanentists.
- Bergson “megarico”?
Reso immortale dal suo secondo capitolo, dove la durata reale fa la sua prima ufficiale comparsa, il Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), secondo l’intenzione del giovane dottorando Bergson, aveva il suo centro attraente e la sua ragion d’essere nel terzo e ultimo capitolo dedicato alla libertà. Per la storiografia filosofica quel capitolo riproporrebbe, nell’età del positivismo, l’eterno conflitto che fin da Aristotele, Metafisica 9, 3, contrappone i sostenitori del determinismo ai fautori della contingenza, i fan della necessità ai paladini del possibile, gli amanti del fato ai credenti nella libertà della “scelta”. Bergson stesso non si è sottratto a questa interpretazione dopotutto normalizzante del suo pensiero. Quando, nel 1904-1905, al Collège de France, deve introdurre il suo adorante pubblico al classico tema della libertà lo rinvia senza indugi ai celebri luoghi aristotelici nei quali sono confutate le tesi “megariche”. «Non c’è – dice – altro argomento che questo contro la libertà, non ce ne sono altri: tutti gli argomenti possibili, tutte le obiezioni possibili sollevate contro la libertà umana si riconducono o possono ricondursi a questa»[1]. Bergson si riferisce al celebre argomento di Diodoro Crono, confutato (così si dice…) da Aristotele in De Interpretatione 9. Come lo stagirita anche Bergson ribadisce che se avesse ragione Diodoro, se cioè valesse anche per il futuro (la famosa “battaglia navale” che domani ci sarà o non ci sarà), il principio della bivalenza (o p è vero o p non è vero), allora tutto sarebbe eternamente dato e niente sarebbe contingente. Niente caso, niente scelta, niente libertà, niente durata creatrice di imprevedibili novità. Bisogna perciò, continua Bergson criticando il “megarico” Spinoza, «credere» alla contingenza, «credere» che vi sia «qualcosa di intermediario tra la necessità e l’impossibile»[2] o, almeno, «comportarsi» come se lo si «accettasse»[3], bisogna, insomma, ribadire una volta di più il primato logico e ontologico del possibile. A essere in gioco è infatti la fede che, secondo lo storico della scienza Pierre Duhem, ha animato tutta la modernità: la fede nella contingenza[4]. Di essa Bergson, ormai filosofo consacrato, si presenta come un devoto. In questo non fa certo eccezione al secolo che sta iniziando, il quale, quasi con voce unanime, accoglierà con religioso entusiasmo la celeberrima sentenza heideggeriana che fissa la dimora del possibile molto, molto più in alto del reale[5].
Ma, si noti, il Bergson del Collège affronta i megarici passando attraverso il “dominatore” di Diodoro, che è certo tesi ascrivibile al megarismo, senza esserne tuttavia il cuore teoretico: più una conseguenza che una premessa, sulla cui stessa formulazione non vi è per altro accordo tra gli studiosi. La posizione teorica megarica la si trova invece nettamente enunciata per bocca di Aristotele in Metaph. 9, 3. Oi megarikoi sono coloro che ritengono che solo quando (otan) uno è in esercizio (energhe) uno può veramente (dynasthai) mentre se non c’è esercizio non c’è nemmeno il corrispettivo poter fare[6]. Insomma, l’atto in atto battezza la potenza, che non sussiste prima, sospesa in un limbo di virtualità in attesa di realizzazione (da qui la tesi diodorea secondo la quale il possibile è tale se e solo se è o sarà). Questa potenza, per i megarici, è illusoria, è una potenza “da spettri”, come la definirà uno dei pochi megarici del Novecento, Nicolai Hartmann[7]. L’argomento del “dominatore”, secondo i più avveduti storici, sarebbe una risposta, fortemente debitrice della grammatica concettuale aristotelica, all’affondo antimegarico di Aristotele contenuto nella Metafisica[8].
Ebbene, il giovane aspirante filosofo che si apprestava a sconvolgere la scena cultura europea, nel terzo capitolo della sua tesi di dottorato avanza a proposito della libertà – libertà che vuole non solo difendere dall’obiezione deterministica ma fondare metafisicamente – una tesi schiettamente megarica. Per fondare la libertà reale, dice, bisogna emendarla dal possibile. Solo così la si renderà immune dal veleno della necessità, un veleno che viene inoculato nel suo corpo proprio attraverso la vena di quel “possibile disgiuntivo” che Aristotele ha coniato polemizzando con oi megarikoi. Fondare la libertà metafisica purificandola della contingenza è tesi decisamente paradossale. Tuttavia Bergson non ha dubbi in proposito. Se possiamo, dice, discutere fino allo sfinimento su dove cercare ciò che rende libero un atto, senza forse mai giungere a una conclusione condivisa, di certo sappiamo dove non lo dobbiamo cercare: «non nel rapporto di quest’atto con ciò che esso non è o con ciò che avrebbe potuto essere»[9]. Non è nel potere di non che dobbiamo cercare la libertà. La dimora dell’atto libero non è la potenza dei contrari, la libertà non è la scelta, la sua ratio non è la contingenza, la libertà non è il poter essere altrimenti, il suo “simbolo” non è quella Y con cui da sempre la si raffigura alla lavagna fissandola nel punto atopico e utopico dove si scindono le due braccia della Y. Si può immaginare lo sbigottimento degli uditori di Bergson, che forse nemmeno compresero la radicalità della sua tesi. A giudicare dai passi sopra citati del Cours del 1904-1905 nemmeno Bergson restò fedele alla sua primigenia intuizione, forse intimorito dal prestigio universale di cui la contingenza godeva come antidoto del determinismo negli ambienti antipositivistici ai quali si rivolgeva. Ma tutte le volte che ha fatto filosofia in grande stile Bergson è costantemente ritornato a quel suo singolare megarismo giovanile.
A Oxford, ad esempio, nel 1920, in una occasione ufficiale, durante una conferenza che sarebbe divenuta lo schema di uno dei suoi saggi metodologici più importanti, Le possible et le réel (aprirà La Pensée et le mouvant del 1934), Bergson afferma che
il torto delle dottrine, - per altro rare nella storia della filosofia -, che hanno saputo fare posto all’indeterminazione e alla libertà nel mondo, è di non aver visto ciò che la loro affermazione implicava. Quando parlavano di indeterminazione, di libertà, intendevano con indeterminazione una competizione fra dei possibili, per libertà una scelta fra i possibili – come se la possibilità non fosse creata dalla libertà stessa![10].
Rivendicando una indeterminazione senza possibilità, affermando una libertà che invece di presupporre il possibile lo crea, il Bergson della piena maturità ribadisce la grande tesi critica del terzo capitolo del Saggio del 1898: lungi dall’esserne il fiero avversario, la contingenza è il cavallo di Troia con cui la necessità espugna la cittadella del reale, vincolandolo alla sua inflessibile legge. Se gli apologeti del possibile vedessero che cosa il loro antimegarismo implica si ritrarrebbero inorriditi: a generare l’errore del determinismo, a renderlo inemendabile teoricamente, è infatti proprio la loro illusione.
Questo megarismo di Bergson, lo ripeto, è rimasto per lo più inavvertito nonostante giacesse, come la lettera rubata del racconto di Poe, sulla sua scrivania di filosofo fin dal 1889. Non è un caso se gli unici che glielo rinfacceranno saranno i suoi avversari neotomisti, Jacques Maritain, ad esempio[11]. Guidati dal loro infallibile fiuto poliziesco capiranno fin da subito che cosa “ne va” veramente nella metafisica della durata creatrice e nella libertà bergsoniana: “ne va” del possibile, del dispositivo potenza-atto, della contingenza dell’ente e, quindi, di Dio causa trascendente e dell’Uomo come “eccezione sovrana” nel cuore della creazione. Nell’indeterminazione senza contingenza, in una libertà che crea il possibile, in questi strani ossimori che si presentano come veri e propri “arcani” per il pensiero logico, sospetteranno l’avversario di sempre: il “panteismo”[12]. Perché di questo “mostro”, che ha agitato i sonni dei dogmatici, il concetto forse più comprensivo è proprio quello che, senza mettere in gioco la sostanza “Dio” e la sostanza “mondo” e i loro rapporti, si richiama alla perfetta equazione megarica fra natura, potenza e atto: dove la potenza non è mai in pausa, dove la natura è il suo stesso atto in atto, senza residui ontologici di sorta, senza possibilità che volteggiano più in alto del reale, là fiorisce ciò che la tradizione ha raccolto sotto la sigla “panteismo”.
- Il labirinto della libertà
Che il determinismo sia un errore e che la “contingenza” sia una illusione è affermazione categorica che conclude, nel Saggio del 1889, la fenomenologia bergsoniana dell’“atto libero”. Di esso si dice che ne abbiamo una certezza di altro ordine rispetto al sapere riflessivo. Sentiamo che siamo liberi, ma questa certezza svanisce come neve al sole non appena dirigiamo il nostro sguardo su di essa per farne un “oggetto” di riflessione. Una volta “detta” e “definita”, la libertà che sentiamo incontrovertibilmente certa diviene un “oggetto” sul quale si esercita tutto il nostro scetticismo. “Ogni definizione della libertà darà ragione al determinismo”[13]. Per questo la sola via “bastarda” per accedere, nella riflessione, all’irriflesso che la precede sarà la via del “paradosso”. E le pagine del Saggio di paradossi ne contengono a profusione.
Cominciamo dal più clamoroso. Bergson si presenta dinanzi a una arcigna commissione di esame con una tesi dottorale sulla libertà contro il determinismo positivista e la illustra con esempi che lasciano stupefatti. Da che mondo è mondo, anche senza ricorrere alla filosofia, la descrizione dell’atto libero sembrerebbe implicare il vocabolario psicologico della scelta. La libertà è la libertà del libero arbitrio. Sono libero se, nel “punto” O, raffigurato dalla divaricazione delle braccia della Y, in eodem instanti et pro eodem instanti, come diceva il dottor sottile, posso i contrari (raffigurati dalle due braccia della Y con le tendenze OX e OZ). Il giovane dottorando decide invece di parlare un’altra lingua che pare smentire ogni autonomia del soggetto, anzi che ne inficia fin da subito la “sovranità” (il libero arbitrio). Questa, anche per il senso comune, consiste nel fatto che il soggetto, situato in O, si sente “capace” e, dunque, padrone di possibilità opposte (OX o OZ). Ma la potenza dei contrari discende da una potenza ancora più originaria, che è il vero senso della potenza aristotelicamente (e antimegaricamente) intesa. La sovranità del soggetto che può i contrari ha la sua radice in una potenza che può esonerarsi dal passare all’atto: una potenza può OX o OZ innanzi tutto perché può non OX o OZ, perché può sussistere come pura potenza indipendentemente dall’atto. Non c’è vera potenza sovrana, nel senso di Metaph. IX, 3, se non là dove vi è questa sorta di nulla che è, questa differenza del soggetto che può da ciò che può. Senza una potenza che si “ha” (che si “possiede”) a distanza, come una proprietà che si può sempre deporre, non c’è arbitrio sovrano. Il dualismo potenza/atto è il fondamento del libero arbitrio e il Novecento, con la sua nozione di “esistenza” come “aver da essere”, la farà propria[14].
Bergson invece afferma che siamo liberi quando i nostri atti emanano dalla nostra intera personalità, quando la esprimono, quando hanno con noi quella indefinita somiglianza che si riscontra tra l’artista e l’opera[15]. Emanazione, espressione, somiglianza: il vocabolario è neoplatonico. Non possiamo soffermarci qui sulla straordinaria importanza di Plotino per filosofia di Bergson (già ai tempi del Saggio)[16]. Ci basti osservare che per Plotino la generatività del Principio, to eph’emin (ciò che dipende da noi), per essere compresa doveva essere liberata dalla sua interpretazione aristotelica e antimegarica «affinché , scrive, non ci accada di distinguere da un lato “potenza” e dall’altro “atto”, e per di più un atto che ha ancora da venire»[17]. L’immagine umana, troppo umana, della “scelta” è allora non solo inadeguata ma procede proprio nella direzione contraria. Infatti Bergson, poche pagine dopo, radicalizzerà ulteriormente la propria tesi sull’atto libero, quasi a voler fugare ogni possibile equivoco, paragonandolo nientemeno che a «un frutto troppo maturo» che si stacca dall’albero[18]. L’esempio è talmente sconcertante da far quasi supporre un intento provocatorio. Come può la caduta di un frutto “troppo” maturo essere preso ad esempio dell’atto libero? Un frutto “troppo” maturo “non può non” staccarsi dall’albero! È, come si suol dire, “nell’ordine delle cose” che cada. È evidente che con il ricorso a questo esempio, così come al vocabolario neoplatonico, Bergson si prefigge due obiettivi teoretici: 1) sul piano logico-epistemologico escludere ciò che per la metafisica è il contrassegno della libertà umana, vale a dire la “potenza dei contrari”, la scelta, la capacità di cui un soggetto “disporrebbe” nella misura in cui può esonerarsi dal passaggio all’atto; 2) sul piano metafisico rubricare l’atto libero in un dominio non più solo psicologico, ma assegnarlo al dominio del vivente. In queste pagine, solitamente ascritte a un Bergson “psicologo”, interessato soltanto a far risaltare la differenza della coscienza-durata dalla natura-spazio omogeneo, l’atto libero è così riportato all’atto del vivente come un suo caso. Bergson lo afferma a chiare lettere: la libertà «consiste in un progresso dinamico in cui l’io e gli stessi motivi sono in continuo divenire, come veri e propri esseri viventi»[19]. Un “progresso” è una attualizzazione dal quale il soggetto, quale che sia, un “io” o un frutto troppo maturo, non può esonerarsi.
Biologizzare l’atto libero non significa certo meccanizzarlo. Bergson sta infatti parlando in nome della libertà contro l’errore del determinismo. Seppure espressa in un linguaggio forse ancora involuto, la sua tesi è già quella contenuta ne L’évolution créatrice (1907). L’ “io”, dice il giovane dottorando, non va inteso come una cosa che cambia nel tempo. L’ “io” è un progresso, un farsi, un mouvant. L’ ”io” è un atto, ma è un atto in atto non un atto compiuto. Il cambiamento è sostanziale e non predicativo. Rispetto a questo “assoluto del passaggio”, che è il solo essere effettivo, l’ “io” che la psicologia metafisica cercava al fondo del cambiamento, ma anche quel fascio di percezioni senza sostrato che restava, per la psicologia empiristica, dopo il fallimento della psicologia metafisica, sono solo il prodotto di un’analisi riflessiva. È a giochi fatti, quando il passaggio in atto è diventato un passato per uno sguardo di sorvolo o, come dice Bergson, quanto il tempo è stato proiettato nello spazio omogeno, che appaiono sulla scena l’Io sostanza metafisica o il fascio di percezioni sintetizzato secondo le leggi dell’associazione. E lo stesso deve dirsi per i motivi che spiegherebbero l’atto determinandolo: anch’essi non sono prima di esso, come cause, ma dopo di esso, quando si dipiegheranno agli occhi della riflessione. Il loro tempo è il futuro anteriore. Diverranno i motivi che spiegano l’azione quando l’azione sarà compiuta. Allora non ne saranno solo i motivi possibili ma anche quelli necessari. Al presente – un presente continuo – c’è però solo il quod dell’atto in atto, che è libero nella misura in cui è causa di se stesso, sebbene possa darsi come “oggetto” (come quidditas) solo rifratto nel prisma del linguaggio, dove la sua libertà viene meno, lasciando a disposizione del nostro sapere solo il corpo morto del “meccanismo”.
Fin dalle prime righe del terzo capitolo Bergson fornisce il lettore di un filo rosso per orientarsi nel labirinto della sua megarica “libertà”: il sentimento irrefutabile della libertà di cui vi parlo, dice, è il sentimento della propria “spontaneità” e, aggiunge, l’idea di spontaneità «è incontestabilmente più semplice di quello di inerzia», base invece della meccanica[20]. Virare la libertà nella spontaneità, fa sì che quel progresso in cui consiste l’atto libero possa poi essere illustrato con lo scandaloso esempio del frutto troppo maturo che cade dall’albero. Lo “spontaneo” è infatti il mediatore tra l’ambito morale, nel quale normalmente poniamo la “libertà”, e l’ambito naturale, nel quale normalmente cogliamo la “necessità” di cui il principio di inerzia è espressione compiuta. Ne consegue che quando sentiamo immediatamente la spontaneità, partecipiamo intuitivamente della natura che vive. Il dominio di una libertà senza possibilità incrocia quello della natura naturans e ne sposa la stessa forma processuale (“progresso”) che non è né contingente né necessario.
Un simbolismo grossolano
Siamo forse ancora lontani dall’apprezzare la novità radicale dell’antimeccanicismo bergsoniano. Per pensare un reale che è durata creatrice di imprevedibili novità dobbiamo, ci dice Bergson, emendarlo da quel modo, il possibile bilaterale, che pare essere la condizione stessa della creazione e del nuovo. Se, anzi, diamo una lettura dell’indeterminazione fondata sulla contingenza ci consegniamo nudi in mano al nemico, il quale avrà sempre ragione a mostrarci che il possibile a cui ci aggrappiamo, per dimostrare la libertà (il nostro potere di non), era soltanto un fantasma generato dalla nostra ignoranza della catena delle cause. La nostra illusione sulla possibilità genera insomma l’“errore” del determinismo che vorrebbe confutare!
I difensori della libertà ragionano tutti come Duns Scoto in Lectura I 39. Il loro simbolismo è quello della Y che il giovane Bergson dichiara “grossolano” in barba alla celebrata sottigliezza del dottore scozzese che lo ha promosso a illustrazione pressoché definitiva delle dinamiche dell’atto libero. In O, dicono, avremmo potuto prendere la strada che ci portava a X invece che a Z. Non abbiamo forse esitato? Non siamo forse stati tormentati e indecisi sul da farsi? E quell’indecisione come quel tormento di che cosa era segno se non della nostra libertà in O? Nello schema a Y , O è il punto in cui la volontà è una pura potenza dei contrari che precede la volizione (OX invece di OZ). La determinazione della volontà a volere questo o quello, cioè ad attualizzarsi, è posteriore all’evento della volontà che, in sé, è libera «ad actus oppositus (ut ad volendum et nolendum, et amandum et odiendum)», come scrive magnificamente lo scozzese[21]. Con il punto O si affaccia sulla scena della metafisica la “contingenza sincronica” che presto diventerà senso comune nella filosofia europea: i due contrari sono dati realmente in eodem instanti et pro eodem instanti[22]. Hanno realtà come contrari senza avere esistenza attuale (il contraddittorio non può avere attualità).
Come Bergson confuta questo simbolismo illustre? Innanzitutto denunciandone appunto il carattere simbolico. Già rappresentare l’esitazione con un punto è una fallacia gravida di equivoci. Un punto non ha dimensionalità. Un punto non si estende. L’esitazione – che faccio? Vado verso X o verso Z? – è invece una durata. L’esitazione è un intervallo. A raffigurarla funzionerebbe allora meglio una linea curva, ad esempio un microporzione della via accidentata che mi ha portato là dove effettivamente sono andato, a X, a esempio. Il punto fa astrazione dal vissuto della mia inquietudine che è parte integrante del percorso. Nell’esempio scandaloso del “frutto troppo maturo”, l’esitazione creatrice è nominata in quel “troppo” che non indica uno stato puntuale, omogeneo agli altri punti dello spazio, disteso sulla “linea retta” del tempo, ma un blocco di “durata reale”, una intensità, che genera una curvatura nello spazio. In secondo luogo, una raffigurazione secondo lo schema Y del percorso svolto e delle sue alternative possibili (da O verso X o Z)
potrà essere costruita solo se si assumerà l’ipotesi di una deliberazione compiuta e di una decisione presa. Potrete sì tracciarla in anticipo, ma solo perché supporrete di essere già arrivati al termine, e di assistere con l’immaginazione all’atto finale. Insomma, questa figura mi permette di vedere l’azione già compiuta, e non mentre la sto compiendo[23].
In altre parole, senza riflessione oggettivante, senza proiezione del tempo vissuto nello spazio, senza il raddoppiamento di un soggetto in sorvolo che accompagni passo a passo l’azione che sta compiendo, niente schema a Y, nessuna competizione fra dei possibili, nessun «rapporto di quest’atto con ciò che non è o con ciò che avrebbe potuto essere»[24]. Senza riflessione nessuna contingenza sincronica. Ma non era la spontaneità irriflessa dell’atto in atto ciò di cui si andava in cerca? La natura, di cui partecipiamo nell’atto libero, forse, “riflette”? La natura “sceglie”? È un soggetto sovrano che dispone del potere di/potere di non? Non si sta forse proiettando in tal modo la forma del poiein umano, del fare demiurgico-artigianale, sulla potenza naturante della natura?
Un antropomorfismo, questo, che si ritrova agente anche nelle più raffinate interpretazioni contemporanee della meccanica quantistica. Basti pensare alla “lettura modale” proposta recentemente da Michel Bitbol, per il quale
la situazione di un soggetto umano di fronte a una scelta d’azione (cioè il punto O della potenza dei contrari) (…) costituisce il più appropriato termine di paragone in tutte le configurazioni epistemologiche in cui l’intervento della categoria del possibile è altro da una semplice comodità di pensiero[25].
Come è il caso, appunto, della meccanica quantistica, per la quale il possibile bilaterale (la sovrapposizione degli stati) ha uno statuto reale senza essere attuale, proprio come avveniva per la potentia logica del dottor sottile. Last but not least l’illusione degli avversari del determinismo fornisce al determinista le armi finali per il suo definitivo trionfo. Il determinista, dopotutto, obietterà al sostenitore del poter essere altrimenti che le cose sono andate come sono andate. Dio non gioca a dadi. Non fingerà dunque di ignorare l’esito finale la cui conoscenza è presupposta dallo schema Y. E concluderà impeccabilmente che “se l’esperienza mostra che ci si è decisi per X, nel punto O non si dovrà porre un’attività indifferente, ma, al contrario, un’attività che malgrado le visibili esitazioni, già da prima era diretta nel senso OX” (114)
- Un megarismo bergsoniano?
La filosofia megarica è detta essere una sofistica eleatica. Vi sono buone ragioni a favore di questa interpretazione che non può essere discussa in questa sede. Sicuramente il Bergson docente di storia della filosofia al Collège la condivide. Stando a essa il megarismo è la filosofia del determinismo che annulla ogni libertà e ogni contingenza. Ma il giovane dottorando, come il maturo filosofo che, nel 1934, licenzia il suo “discorso sul metodo”, megarizza senza avvedersene proprio per fondare metafisicamente l’indeterminismo. Involontariamente ci offre così una chiave d’accesso inedita al pensiero dei megarici di cui non possiamo non tener conto ritornando a quegli arcaici filosofi. Dopo Bergson possiamo riconsiderare la loro impresa teorica. Siamo, per così dire, “autorizzati” a chiederci se quei bizzarri pensatori, amanti del paradosso e dell’eristica, fossero veramente i guardiani arcigni dell’essere parmenideo, i nemici giurati di ogni cambiamento, i teorici ante literam del più inflessibile determinismo positivista. Sono domande impegnative che richiederebbero una appropriata elaborazione in sede storiografica. Possiamo però affermare che l’uso che Bergson fa dell’argomento principe dei megarici sembra poter problematizzare questa interpretazione.
I megarici, lo sappiamo da Aristotele, enunciano quella che Nicolai Hartmann ha chiamato la «legge di possibilità del reale»: qualcosa è possibile solo nel caso in cui sia effettivo, qualora non sia effettivo non è allora neppure possibile[26]. Da questa tesi se ne può ricavare, come è stato fatto, il determinismo meccanicista più intransigente (l’ipotesi Laplace, per intenderci). La legge della possibilità del reale si converte infatti immediatamente nella “legge della necessità del reale”, secondo la quale ciò che è realmente effettivo è ipso facto realmente necessario, ma, ed è questa l’opzione rivoluzionaria bergsoniana, se ne può trarre una conseguenza indeterministica e antimeccanicistica: non l’indeterminismo della contingenza e del poter essere altrimenti, non l’indeterminismo a tinte antropomorfiche della “scelta”, ma l’indeterminismo del processo o del progresso dinamico.
Secondo il Bergson del Saggio, contrariamente a ciò che avviene nei sistemi dinamici chiusi, nei quali il tempo non fa nulla (tutte le equazioni della scienza fisica sono infatti caratterizzate da reversibilità e simmetria), per il vivente il tempo costituisce indubitabilmente un “guadagno”. Il tempo, insomma, fa qualcosa. In questo consiste la libertà ontologica del vivente. E che cosa fa? Crea del possibile, cioè elabora le condizioni di possibilità del suo stesso esistere attuale, le quali evidentemente non sono date prima secondo lo schema Y. Nei termini di un filosofo della biologia, che ha consacrato l’intera sua esistenza a contrastare il determinismo meccanicista in tutte le sue forme, Giuseppe Longo, il vivente è «una zona di criticità estesa nella materia»[27]. Il suo divenire non presuppone uno “spazio delle fasi” dato, vale a dire un sistema di invarianti di cui esso sarebbe la realizzazione programmata, come è nei sogni di un certo biologismo, ma lo “spazio delle fasi” cambia e si costituisce in funzione del suo atto. Il sentiero si forma insomma simultaneamente al cammino. Percorrerlo è generarlo. Il che è un altro modo di dire che qualcosa diventa possibile solo quando è effettivo (legge della possibilità del reale). A fondamento di tutte le dottrine che misconoscono la creatività dell’evoluzione, scriverà Bergson ne Il Possibile e il reale, c’è l’idea «che la possibilità delle cose preceda la loro esistenza», ma se noi lasciamo i sistemi chiusi per applicarci al “mondo della vita” allora scopriamo che il possibile è incessantemente generato dal reale[28].
Quando Bergson coglie nella “esitazione” il segno della libertà posta al cuore del vivente non pensa dunque all’oscillazione tra possibili che precederebbe la “scelta”. Pensa a un progresso accidentato, a una durata creatrice che si fa tramite negoziazioni con l’ambiente, rifunzionalizzazioni, esattamenti. Pensa il passaggio, l’atto del passare, o, come più tardi lo chiamerà, il mouvant, come l’essere stesso e denuncia la fallacia del linguaggio che sostanzializza questo passaggio facendone una cosa che passa, il divenire di un sostrato. Tutti paradossi che hanno reso celebri i megarici, facendone gli indiscussi campioni della eristica greca, ruotavano proprio intorno all’eterogeneità del linguaggio rispetto all’esperienza. Che sia il sorite o il terzo uomo, o il calvo o il cornuto, il paradosso denuncia sempre la stessa impossibilità per il logos di dire l’assoluto del passare. Ogni volta che ci prova si producono degli enti spettrali che si sostituiscono all’esperienza generando dei simulacri di realtà che i megarici si divertivano a demolire. Ma a essere messa in questione è sempre la pretesa veritativa del logos non l’effettività del passaggio!
Forse i megarici non sono stati gli “amici delle Idee” del Sofista platonico, come in molti ritengono. Forse non sono stati gli intransigenti difensori della trascendenza. Forse erano filosofi del processo, immanentisti e panteisti. Il loro assioma di partenza era l’equazione perfetta Physis = Dynamis = Energheia: la natura non è nient’altro che potenza e la potenza non è nient’altro che atto in atto. Non ci sono pause tra la potenza e l’atto. La ratio essendi come la ratio cognoscendi di una cosa è ciò che la cosa fa e non può non fare: è l’insieme dei suoi effetti concepibili, al di là dei quali, non c’è letteralmente nulla che sussista in sé. È questa continuità che è stata fatta saltare dalla confutazione aristotelica del megarismo, grazie alla quale il “potere” è articolato a un “soggetto” che ne “dispone”. Da essa si genera di quella “illusione” che il giovane dottorando Bergson denuncia come il “postulato comune” ai deterministi e ai loro avversari:
in breve, tanto i difensori che gli avversari della libertà sono d’accordo sul fatto di fare precedere l’azione da una specie di oscillazione meccanica tra i due punti, X e Y (Z nel nostro sistema di notazione). E, nel caso che io opti per X, i primi mi diranno: hai esitato, hai soppesato, e quindi Y (Z) era possibile. Mentre gli altri risponderanno: hai scelto X, avevi quindi una ragione per farlo, e se dichiariamo che Y (Z) era ugualmente possibile, dimentichiamo tale ragione; tralasciamo una delle condizioni del problema[29].
La diatriba secolare fra deterministi e i loro avversari lascia quindi “intatta” la questione della “vera” libertà. Bergson era tuttavia persuaso che bisognasse riaprire questa pratica per rispondere alle domande che la nuova scienza antimeccanicistica poneva alla filosofia, senza cadere nella esiziale illusione del possibile. Per questo, nel terzo capitolo della sua tesi di dottorato, getta un colpo d’occhio molto indietro nel tempo e ritorna, senza avvedersene, alla radice megarica del problema.
[1] H. Bergson, L’évolution du problème de la liberté. Cours au Collége de France 1904-1905, Puf, Paris 2017, p. 104.
[2] Ibid., p. 255.
[3] Ibid., p. 99.
[4] P. Duhem, Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Hermann, Paris 1913-1959, vol. VI.
[5] M. Heidegger, Essere e tempo, tr. it. Longanesi, Milano 2009, p. 54.
[6] Metaph. IX, 3, 1046b 29-30.
[7] N. Hartmann, Possibilità ed effettività, tr. it. Mimesis, Milano 2018, p. 237
[8] Cfr. P.-M. Schuhl, Le dominatuer et les possibles, Puf, Paris 1960, che accetta l’ipotesi di H. Maier (1899), secondo il quale De int. 9 risponderebbe a Diodoro che, a sua volta, con l’argomento del dominatore avrebbe reagito polemicamente ad Aristotele Metaph. 9, 3.
[9] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, p. 117.
[10] Id., La Pensée et le mouvant, Puf, Paris 2013, pp.114-115 (corsivo mio).
[11] Cfr. J. Maritain, La philosophie bergsonienne, Riviére, Paris, 1930, ( 1° ed. 1914). Si veda, a questo proposito, il mio saggio La metafisica naturale dell’intelligenza umana (Maritain lettore di Bergson), in appendice a Rocco Ronchi, Bergson filosofo dell’interpretazione, Marietti, Torino 1990, pp. 207-231.
[12] Cfr. J. Maritain, La philosophie bergsonienne, cit., p. 320.
[13] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 139.
[14] Un sua recentissima riformulazione la si trova in P. Virno, Avere, Boringhieri, Torino 2020.
[15] Cfr. H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., pp. 107-111.
[16] Cfr. F. Leoni – R. Ronchi, Psiché. Bergson lettore di Plotino, Introduzione a Henri Bergson, Plotino. Corso del 1898-1899 all’École Normale Supérieure, Textus, L’Aquila 2019, pp. 11-34.
[17] Plotino, Enneadi, (Trattato 39) VI 8 1, 11-13.
[18] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 113. Equivoco alimentato anche da altre descrizioni bergsoniane dell’atto libero che hanno fatto fiorire interpretazione irrazionalistiche ed estetizzanti del bergsonismo. Gli atti liberi, dice Bergson, sono “rari” (ibid., p. 108). Intere esistenze possono consumarsi senza conoscere la vera libertà. Gli atti liberi si presentano con il tratto della discontinuità rispetto al corso ordinario della vita e si segnalano per l’assenza di un motivo che li giustifichi: “quanto più profondamente siamo liberi, tanto più si manifesta l’assenza di ogni ragione tangibile” (ibid., p. 110). “Vogliamo sapere in base a quale ragione ci siamo decisi, e scopriamo che l’abbiamo fatto senza ragione, e forse perfino contro ogni ragione. Ma, in alcuni casi, questa è la miglior ragione” (ibid. p. 109). L’atto è libero perché infondato? È il “bel gesto” in odore di protofascismo dannunziano? Nient’affatto. La discontinuità, di cui parla Bergson, concerne l’io meccanico, superficiale, l’io che è agito e non agente. Dove c’è, spinozianamente, un io che è causa adeguata delle proprie azioni, l’atto libero è espressione dell’io “tutto intero” (ibid., p. 107). L’immanenza dell’atto è assoluta, “e l’atto sarà tanto più libero quanto più la serie dinamica a cui si ricollega si identificherà con l’io fondamentale” (ibid., p. 108).
[19] Cfr. H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 117.
[20] Ibid., p. 92.
[21] J. Duns Scotus, Contingency et Freedom. Lectura 1 39, Editor: Research Group John Duns Scotus, Springer Science + Businness Media Dordrecht, 1994, p. 108.
[22] Ibid., p. 118.
[23] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p. 115.
[24] Ibid., p. 117.
[25] M. Bitbol, La pratique des possibles. Une lecture pragmatiste et modale de la mécanique quantique, Hermann, Paris 2015, p. 30.
[26] N. Hartmann, Possibilità ed effettività, cit., pp. 235-242
[27] F. Bailly, G. Longo, Mathématiques et sciences de la nature, Hermann, Paris 2006, p. 76.
[28] H. Bergson, La Pensée et le mouvant, cit., p. 109.
[29] H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, cit., p.115.