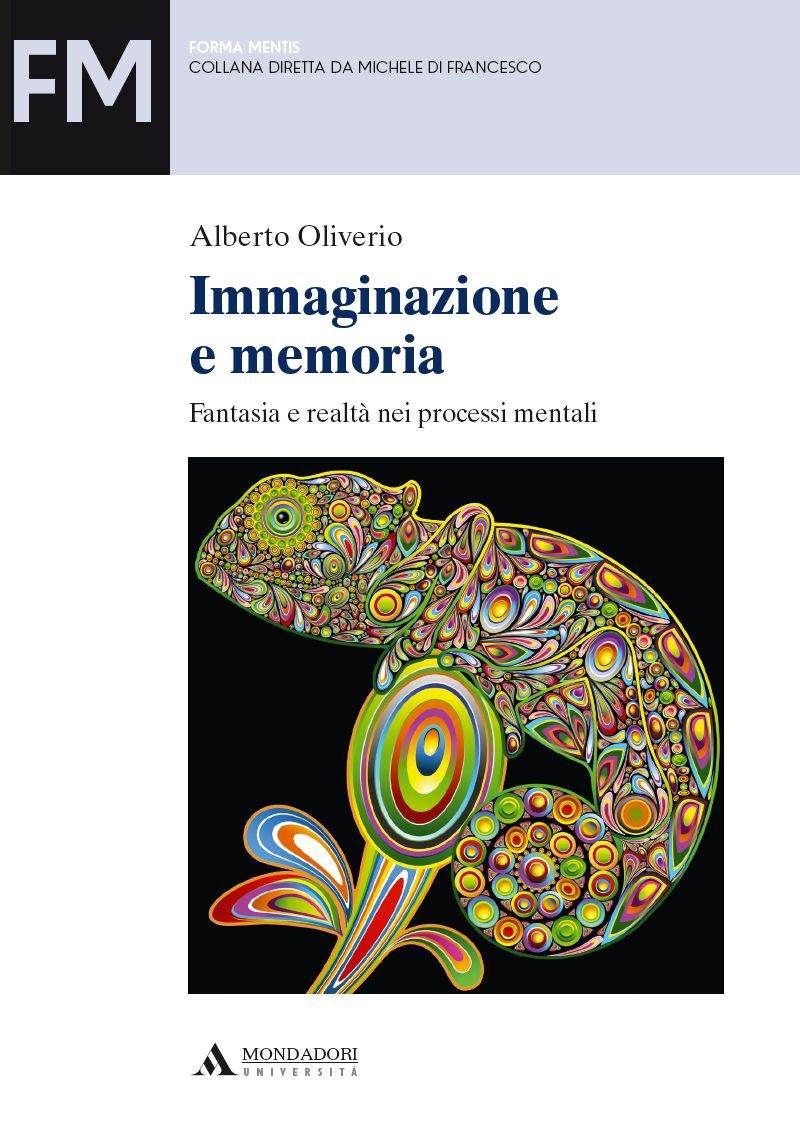Immaginazione e Memoria è un libro per molti versi esemplare. Lo è nel suo genere, come opera di alta divulgazione, per la chiarezza e l’equilibrio con cui esplora e racconta l’ambito variegato e complesso delle ricerche più recenti – ma in chiave storica anche di quelle meno recenti – intorno alla neurologia dell’immaginazione e della memoria, fornendone un’immagine vivace e insieme accurata.
Lo è per l’ampiezza della prospettiva entro la quale inquadra il suo tema e ne argomenta gli snodi, integrando neuroscienze e fisiologia, psicologia (della Gestalt, cognitiva, ma anche dinamica) ed etologia, filosofia della mente ed estetica, neuroetica e letteratura… Con un approccio non semplicemente interdisciplinare o multidisciplinare, ma propriamente “sintetico”, dove tutto è di prima mano (nella sua lunga carriera di ricerca ed insegnamento, Alberto Oliverio ha avuto il merito e il coraggio di lavorare e produrre, spesso da pioniere, in tanti settori, dalla medicina all’etologia, dalla psicobiologia alla neuroetica, dall’antropologia alla filosofia della scienza).
E lo è anche, esemplare, come testo di studio e di ricerca, sia per la ricchezza dei suoi riferimenti, sia – e ancor più – per il rigore e la lucidità con cui Oliverio vi propone le proprie posizioni più personali, pur senza trascurare quelle alternative, verso le quali mantiene sempre aperto il confronto; nella convinzione dell’«irriducibile pluralità delle forme di comprensione della realtà», di cui ci parla proprio nelle ultime pagine e da cui consegue «l’autonomia costitutiva della filosofia» che solo uno «sciatto riduzionismo» vorrebbe annullare (p. 243 sgg.). Posizione che però si premura di dare a Cesare quel che è di Cesare e quindi di riconoscere che per le neuroscienze il riduzionismo – sostituendo il “perché” comportamentale con il “come” neurale – rimane un approccio fondamentale, purché perseguito con la consapevolezza dei suoi limiti.
Dal punto di vista strettamente neurologico questi limiti dipendono innanzitutto dalla complessità e plasticità del “come”, ossia delle attività neuronali elettriche e chimiche connesse con le varie funzioni cerebrali e mentali; complessità che si esprime nel fatto che quelle attività non sono né statiche né sempre unitarie, ma attraversano continue ristrutturazioni e possono essere surrogate (quando, per esempio, una certa funzione per ragioni di varia natura viene presa in carico da reti neuronali e svolta secondo strategie differenti da quelle usuali). Vi è, insomma, nella fisiologia del cervello, una spiccata «versatilità funzionale che ridimensiona una concezione rigidamente modulare e deterministica della mente» (p. 243).
Questo il leitmotiv di Immaginazione e Memoria: la plasticità del cervello, che in ultima analisi è espressione del fatto che si tratta di un organo dotato di estrema motilità: niente affatto, come saremmo ingenuamente propensi a immaginare, una struttura reticolare statica i cui vari nodi abbiano sin dall’inizio un proprio ruolo prestabilito geneticamente, bensì qualcosa di vivente, che si nutre, cresce, muta costantemente e così anche deperisce e decade. Insieme alla mano, il nostro organo più attivo e creativo, nell’interpretare e dare forma alla realtà con cui è in contatto, un dare forma che è anche sempre un darsi forma. Come dimostra nella maniera più icastica proprio la funzione mnemonica.
Forse non è alieno un pizzico di ironia nel porre insieme e insieme contrapporre, come Oliverio fa all’inizio del suo libro, immaginazione e memoria all’insegna di quella che sarebbe la loro differenza più banale: la prima volta al futuro, non vincolata alla durezza dell’essente, e quindi libera e creativa, laddove la seconda svolgerebbe un ruolo conservativo, di custodia più o meno efficiente del passato. Differenza che, in questi termini, non vi è affatto, pur non venendo ovviamente meno la distinzione, anche neurologica, delle due funzioni, che però condividono l’essenziale tratto interpretativo della loro azione. Interpretativo e, potremmo dire, “narrativo”.
E così Oliverio imposta il suo discorso su due versanti, da un lato quello del rapporto tra percezione sensibile e immaginazione, mostrando come già nella sensibilità, pensata tradizionalmente come facoltà meramente ricettiva, il cervello agisca invece creativamente nel mettere in forma le immagini, che poi popolano l’immaginazione come materia già formata, che per certi versi delimita e modera la produzione fantastica. E sull’altro versante troviamo il rapporto tra memoria e oblio, entro il quale pure si produce un almeno parziale capovolgimento: la memoria non è affatto solo conservazione, così come l’oblio non è mera perdita, ma esso stesso per certi versi facoltà attiva – e nel dire questo Oliverio non dimentica affatto il Nietzsche della II Inattuale Sull’utilità e il danno della storia per la vita e la sua teoria del trofismo di memoria e oblio (p. 9).
Ma al di là dei rapporti interni con i loro correlati più immediati, immaginazione e memoria intrattengono anche tra loro una relazione di reciprocità che è schiettamente circolare: «non esiste immaginazione senza memoria, ma neanche memoria senza immaginazione, una memoria priva di quanto la nostra mente immagina a proposito dei ricordi, sguarnita del supporto di quella vasta popolazione di immagini mentali che popolano le trame nervose. Ogni esperienza deve fare i conti con l’immaginazione, conscia o inconscia che essa sia» (p. 3).
Una trama complessa, dunque, in cui tutto dipende da ognuno e ognuno da tutto. E una trama delicata, sensibile ai mutamenti dell’esperienza in una maniera che è difficilmente prevedibile. Il carattere sistemico, o forse meglio organico, del nesso tra percezione, immaginazione e memoria, infatti, induce nel discorso di Oliverio anche un accento vagamente kulturkritisch, che è delicato e sobrio, ma non episodico: il riferimento alla novità antropologica rappresentata dal profluvio di immagini cui si è sempre più esposti, con effetti ambigui sulla nostra percezione della realtà e anche sulla nostra memoria: «L’analisi nietzschiana non poteva però contemplare le trasformazioni dell’immaginario e il massiccio bombardamento di immagini che avrebbero avuto luogo con la diffusione dei nuovi media […]. In che misura un bagno nell’immaginario mediatico e un continuo flusso di immagini possono parassitare la nostra mente, farsi memoria, rendere incerti i confini tra esperienze dirette ed esperienze mediate?» (p. 10).
Vorrei però concludere questa recensione – il cui scopo non può ovviamente essere quello di dare una sinossi completa di un testo di tale ricchezza, ma solamente invitare a leggerlo in proprio – con un accenno a quella che mi pare la sua acquisizione teorica più importante: quel che prima dicevo il carattere narrativo della memoria.
Dalla seconda metà del ‘900 si era imposta, sulla scia della cibernetica, una concezione informatica della memoria, cui in genere ci si riferisce come modello “storage and recovery”: immagazzinamento e recupero. Il «cervello cassettiera», lo chiama Oliverio, dove i ricordi sono registrati da qualche parte e la rammemorazione consiste esclusivamente nel loro riportarli più o meno imperfettamente alla coscienza. Per lo più o invero sempre imperfettamente: un modello, dunque, di decadimento progressivo. Quel che invece la neurologia più recente ci mostra è qualcosa di diverso: indubbiamente non vi è mai recupero integrale, ma questo semplicemente perché non vi è neppure un immagazzinamento integrale.
La traccia mnemonica non è un engramma, non l’impressione su una tabula inerte e omogenea, è piuttosto sin dall’inizio uno spunto immaginativo, tutto nutrito di immagini e simboli, a partire dal quale rinarrare le proprie esperienze, per ridare loro forma e figura a ogni successivo ricordo. Che ogni volta le muta, in quel che i neurologi chiamano “riconsolidamento”: il ricordo ancorato alla “memoria a lungo termine” nell’atto della rammemorazione ritorna in uno stato più labile, dove viene riformato, reinterpretato, rinarrato, per poi riconsolidarsi nella sua nuova forma, che rimane latente e disponibile ad una nuova narrazione. Finché dura.
Nicola Russo
02_2020
S&F_n. 23_2020