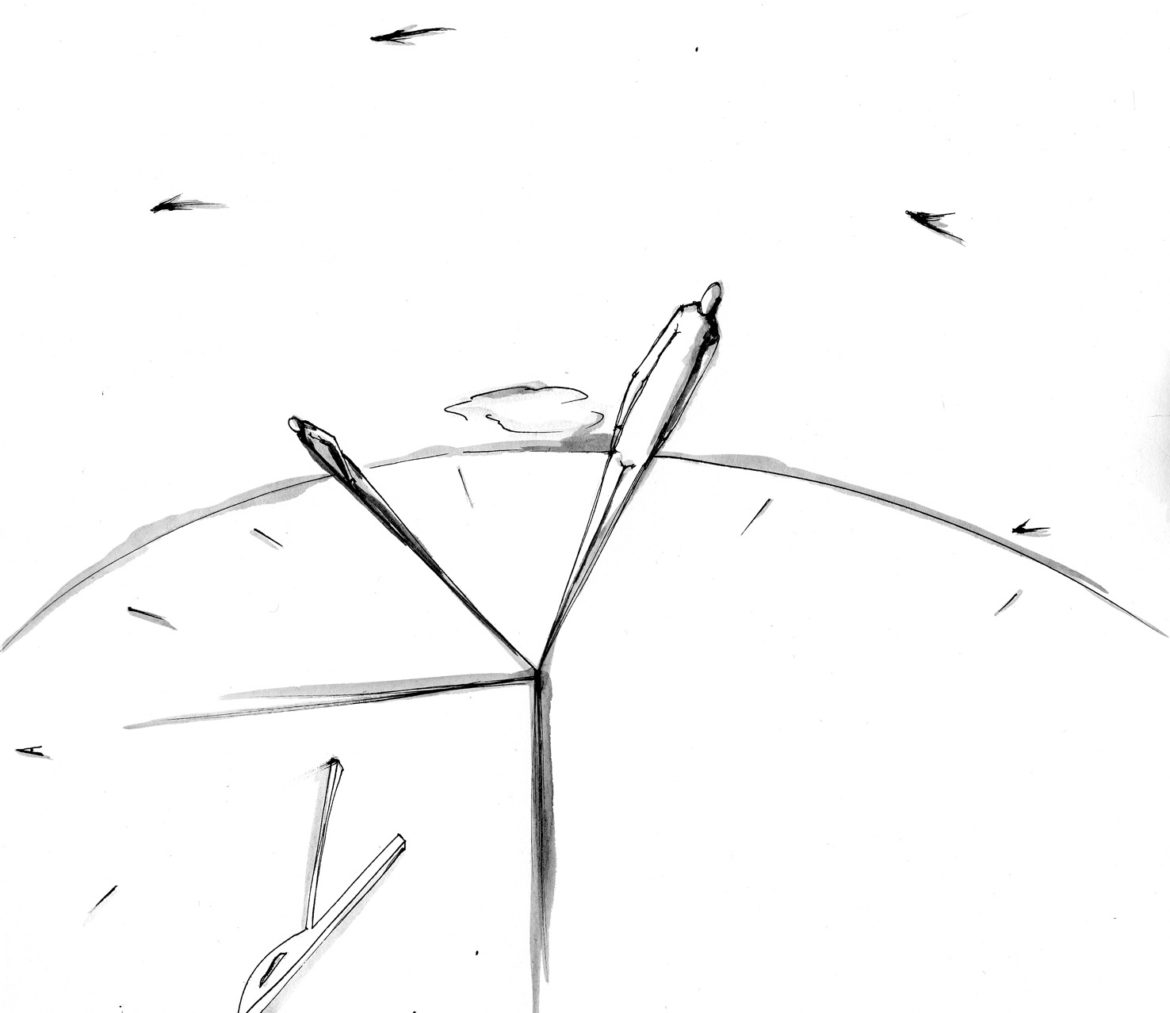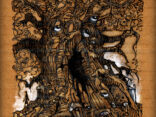Autore
Indice
- Natura, dannata Natura
- Gli aspetti filosofici del darwinismo secondo Jonas
- La scoperta della vita e le distrazioni dei bioeticisti
- Non ci resta che il Nichilismo? La proposta del “Nuovo pensiero”
S&F_n. 04_2010
- Natura, dannata Natura
Nata per risolvere le complesse questioni morali poste dalle nuove scienze della vita, la bioetica trova nella vita il suo più grande limite epistemologico. La bioetica incontra cioè il suo più intricato ostacolo proprio nella dimensione del bíos, i cui equilibri pure vorrebbe tutelare e proteggere. Situazione paradossale, eppure non inedita nella storia delle idee. È accaduto qualcosa di analogo alla dottrina giusnaturalistica, vale a dire a quella teoria filosofica orientata a fondare l’etica e il diritto su principi e su valori desunti da una presunta legge naturale. Nell’ambito del giusnaturalismo, a differenza della bioetica, la natura è considerata innanzitutto depositaria e non semplice destinataria di norme, e tuttavia come nel caso della bioetica siamo di fronte a un pensiero che continua a produrre delle assiologie a partire da un modello di riferimento irreparabilmente eroso. Sì perché l’etica-della-vita, la bio-etica, si struttura in gran parte ancora come un’etica-dalla-vita, vale a dire come un sistema di valori indirizzati a regolamentare le questioni più spinose che il progresso tecnologico pone all’“equilibrio” e all’“ordine” dei fenomeni biologici (dalla manipolazione di cellule staminali ai trapianti, dall’ingegneria genetica all’eutanasia, per non parlare degli innumerevoli aspetti delle bioetiche animaliste e ambientaliste) sulla base di un costrutto proteso a derivare proprio da quei fenomeni, vale a dire dalla biologia, i criteri ultimi della loro tutela. A circa quarant’anni dalla sua formalizzazione[1], questa disciplina è ancora in gran parte fondata sul presupposto di poter teorizzare un’etica della vita radicando nella vita i suoi valori, come se per proteggere la vita e tutte le sue molteplici manifestazioni, a cominciare da quelle antropologiche, non vi fosse altro modo che riconoscere nella vita stessa una paradigmatica fonte di valore; come se per proteggere e tutelare la natura non vi fosse modo più efficace che identificare nella natura stessa la sede di un’etica prima.
Il giusnaturalismo e la bioetica (non tutta, ma di certo una sua significativa parte) hanno dunque questo tratto in comune, sono dottrine che istituiscono i loro principi e loro valori in una precisa idea di natura, nel primo caso declinata in senso cosmologico, nel secondo declinata in senso essenzialmente biologico[2]. C’è una realtà complessa (Natura), si presume di decifrare l’ordine recondito di tale complessità (legge naturale), da questo ordine vengono desunte atemporali e universali norme di condotta (legge morale). Il fatto è che quell’idea di Natura, sia che si parli del Cosmo sia che si parli della Vita, non sta più in piedi da tempo. Così come il giusnaturalismo «compiuto nell’ordine suo»[3] ha infatti finito col perdere la sua “natura” di riferimento con la rivoluzione cosmologica galileiana, così gran parte della bioetica contemporanea ha finito col perdere la sua “natura” di riferimento con la rivoluzione biologica darwiniana. La filosofia, soprattutto quando è filosofia morale, non può certo dipendere dai dettati dei saperi positivi, ma è altrettanto vero che se vuol pretendere di fondare un’«etica per la civiltà tecnologica»[4] non può d’altra parte nemmeno presumere di ignorarli. Dalla scoperta della dinamica finitezza del cosmo[5] a quella della intrinseca casualità delle forme viventi[6], le descrizioni dell’essere restituiteci dalle scienze moderne e contemporanee sembrano non dare scampo ad alcuna metafisica di sorta. Fisica, biologia, e ancora: neuroscienze, genetica, bioingegneria, paleoantropologia, meccanica quantistica, scienze computazionali, e così via sul solco dei saperi che con la placida forza dei fatti stanno trasformando la nostra visione del mondo, della vita e di noi stessi, hanno agito e continuano inesorabilmente ad agire come tanti squarci sull’apparente staticità e solidità dell’essere, suggerendo tutte la medesima cosa: viviamo in un contesto di liquidità generale[7]. L’ordine e la ragione che la filosofia greca prima e la metafisica cristiana poi (da Aristotele a Tommaso) avevano immesso nell’essere delle cose (fisiche, naturali e umane) si è andato sgretolando, e gran parte delle difficoltà di definire un’etica per la bioetica nasce proprio dalla frantumazione della presunta ratio posta a fondamento del cosiddetto ordine naturale. Come ha scritto un esegeta e autorevolissimo rappresentante di questa tradizione:
Molto in generale si può dire che se l’inizio del mondo è dovuto ad uno scoppio primordiale, allora non è più la ragione il criterio e il fondamento della realtà, bensì l’irrazionale; anche la ragione è, in questo caso, un prodotto collaterale dell’irrazionale verificatosi solo per “caso e necessità”, anzi per errore ed in quanto tale da ultimo è essa stessa irrazionale[8].
L’insofferenza per la teoria del Big bang e per quella evoluzionistica, divulgatrici di una visione “irrazionalistica” della Natura in cui ogni apparente ordine altro non sarebbe se non il frutto di uno «scoppio primordiale» e di «caso e necessità», è direttamente proporzionale al modo in cui queste nuove teorie del cosmo e della vita erodono un concetto di cosmo e di vita da molti giudicati come l’unica ed effettiva condizione per fondare un’etica, a cominciare proprio dalla bioetica. Il fatto è che quel cosmo e quella vita non ci sono più. In questo senso una bioetica che pretenda ancora di radicare nell’essere la tavola dei suoi valori sembra destinata a fallire. Detto in altri termini, così come il giusnaturalismo ha dovuto fare i conti con l’idea di un cosmo post-galileiano, e dunque irrimediabilmente distante dalla cosmologia aristotelico-tolemaico-tomista, la bioetica ha da fare i conti con l’idea di una natura post-darwiniana, la quale, come ha osservato uno dei più attenti pensatori del disincanto moderno, ci dice che noi altro non siamo se non «un prodotto del mondo – se non una creazione di Dio. Siamo esseri naturali nonostante logos, lingua, riflessione e trascendenza […]. Questo naturalismo – aggiunge significativamente il filosofo – non è una mitologia e non mi pare incerto ma piuttosto evidente»[9]. Una bioetica giusnaturalistica, di questo in fondo si tratta, sia essa di ispirazione religiosa o di ispirazione laica, non saprebbe più su quale natura fondare i suoi principi a meno di non pretendere illusoriamente di dedurre norme certe dal mutevole regno del «caso e della necessità» o, cosa ancora più disdicevole, pretendere di ammantare coi crismi della morale la legge che regola i cruenti dinamismi della vita.
A partire da Darwin la natura perde le sistematiche fattezze di un regno ordinato, diventa assolutamente incommensurabile a quel che non a caso Linneo aveva definito Systema Naturae, e diventa qualcosa che assomiglia di più a un’«avventura» che non a una «struttura».
- Gli aspetti filosofici del darwinismo secondo Jonas
In un capitolo di Organismo e libertà, senz’altro una delle più importanti opere di filosofia della biologia del secolo scorso, Hans Jonas ragiona intorno agli “aspetti filosofici del darwinismo”[10] e fa notare come già il mero fatto dell’evoluzione rivoluzioni di per sé il concetto di vita e come in che termini, a partire da questa rivoluzione, il regno del bíos acquisti impensati caratteri di imprevedibilità. Una delle più diffuse teorie della vita predarwiniana, quella cartesiana, aveva infatti come punto di riferimento una precisa struttura meccanica, vale a dire il dato organismo di un dato animale, e a partire da questo meccanismo comprendeva la vita come funzione o prestazione particolare del corpo-macchina. In questo quadro la vita appare quindi come la funzione di un dato meccanismo, le cui prestazioni sono più che sufficienti a risolvere ogni questione relativa ai caratteri di una cosa vivente. Refrattario a ogni minimo cenno di casualità, il “sistema biologico” cartesiano non contempla nient’altro che strutture dominate dalla ferrea legge della causalità e in questo senso si configura come un sistema pienamente assimilabile ai rassicuranti determinismi della fisica. È facile comprendere come un’idea di natura siffatta possa ancora legittimare la fondazione naturalistica di un’etica se non già di una bioetica. L’evoluzionismo, invece, spariglia totalmente le carte in tavola.
La teoria evoluzionistica – osserva il pensatore ebreo-tedesco – considera questo tipo di struttura dato [il corpo-macchina di un certo organismo] la condizione per una realizzazione specifica di vita, come esso stesso prodotto della vita, come risultato e fermata temporanea di un continuo dinamismo, il quale va definito a sua volta come “vita”[11].
Il cambiamento di paradigma è evidente: nella visione evoluzionistica la vita smette di essere un dato per divenire una conquista, un processo i cui equipaggiamenti assumono di volta in volta i caratteri di un’acquisizione.
La trasformazione della vita da dato a conquista rappresenta, dice Jonas, «una delle più grandi scoperte che siano mai state fatte riguardo alla natura della vita»[12]. Ciò innanzitutto per due ragioni. Tanto per cominciare la visione evoluzionistica della vita implica il venir meno di «essenze immutabili dalla realtà segnando così la vittoria finale del nominalismo sul realismo, il quale aveva il suo ultimo bastione nell’idea di specie naturali»[13]. In secondo luogo l’anti-finalismo del darwinismo fa sì che il processo dell’evoluzione si presenti letteralmente come un’avventura:
Quest’idea specificamente moderna di un’avventurosità della vita non progettata e dal finale aperto, che fa da corollario alla scomparsa di un’essenza immutabile, è di nuovo un’importante conseguenza filosofica della teoria scientifica dell’evoluzione[14].
Appare evidente come argomentare, oggi, intorno alla identificazione di Ratio e Natura, alla luce di una sapere che trasforma la natura in un avventuroso teatro di forze in perenne formazione e, soprattutto, de-formazione, non ha più alcun senso. Se con Cartesio la vita è sostanzialmente assimilabile alla funzione di una data struttura organica, e quindi è ancora plausibile una visione profondamente statica dell’essere, con Darwin la vita è ciò che disfa continuamente ogni struttura data per raggiungere, attraverso riorganizzazione e adattamento, nuovi assetti strutturali temporaneamente in grado di continuare a vivere. Altro che ordine! Qui è piuttosto il dis-ordine, una sorta caos produttore e disgregatore di forme, a svolgere il ruolo di principio organizzativo.
- La scoperta della Vita e le distrazioni dei bioeticisti
La teoria darwiniana traccia i lineamenti di un essere intrinsecamente dinamico, al cui cospetto scompare del tutto l’ordinata natura su cui ancorare qualsivoglia assiologia. Insieme alle essenze immutabili si smarriscono infatti anche i solidi ancoraggi di cui abbisognano ogni filosofia morale e ogni bioetica giusnaturalisticamente orientate. Nel momento stesso in cui decreta la «vittoria del nominalismo» lasciando definitivamente alle spalle del pensiero biologico il realismo aristotelico e linneano, Darwin smantella infatti il formidabile gioco di specchi che nella tradizione metafisica poneva tra Dio e l’ultima delle creature viventi la consistenza di un unico grande ordine verticalmente distribuito, e così destituisce di ogni significato la poderosa metafora della scala naturae. Si tratta di un evento di prim’ordine perché si tratta del venir meno, per la prima volta nella storia del pensiero occidentale, dell’idea di un cosmo chiuso e, con esso, del correlato principio di gradualità, secondo cui dall’essere più imperfetto si sale progressivamente verso quello più perfetto, e del correlato principio di pienezza, secondo cui tra i vari gradini dell’essere non è ammissibile alcun intervallo o frattura[15]. Qual è la principale conseguenza del venir meno di questi due principi? L’ammutolimento della più loquace fonte della morale. Se sulla base del principio di pienezza e di gradualità si può infatti dire che «le forme della natura si distribuiscono su una scala ontologica che dal basso progredisce verso l’alto, un scala che non conosce vuoti, poiché la natura nel suo insieme è un tutto, è la Forma delle forme, è una Forma compatta, afflitta da horror vacui»[16], in seguito alla loro scomparsa si deve invece riconoscere che la natura diventa una realtà dalla consistenza ontologica effimera, refrattaria a ogni gerarchizzazione e per di più passibile di vuoti e fratture.
E allora, se è vero, come ha lucidamente messo in luce Armando del Giudice, che il primo compito della bioetica è quello di riflettere sulla modernità[17], si può forse ignorare il rovesciamento di paradigmi interpretativi che nella modernità ha insistito sui concetti di natura e di vita? Si può forse ignorare, nel momento in cui si tenta di costruire una possibile etica della vita, l’avvenuta scomparsa di un regno vivente abitato da essenze immutabili e processi sapientemente orientati? Si può infine ignorare, nel momento in cui si è chiamati a legiferare sugli usi corretti delle tecnologie della vita se non addirittura a stabilire i modi della sua prossima ridefinizione artificiale, il fatto che il concetto stesso di vita sia nato non più di due secoli orsono proprio a suggellare la definitiva disgregazione dell’ordine naturale? Sì perché nonostante il montare di riflessioni bioetiche modellate su un concetto vita tenacemente commensurabile a qualche ordine naturale pre-moderno, è utile ricordare insieme a Michel Foucault che una delle più importanti scoperte della modernità è proprio la vita:
Si vogliono scrivere storie della biologia nel XVIII secolo; ma non si avverte che la biologia non esisteva e che la sezione del sapere a noi familiare da più di centocinquant’anni non può valere per un periodo anteriore. E che se la biologia era sconosciuta, era per una ragione assai semplice: la vita stessa non esisteva. Esistevano soltanto esseri viventi: apparivano attraverso una griglia del sapere costituito dalla storia naturale[18].
Il naturalista classico a differenza del biologo moderno, suggerisce l’epistemologo francese, non cerca né studia la vita, ma cerca e studia le strutture di cui la vita sarebbe, cartesianamente parlando, nient’altro che una funzione. Fino agli inizi del XIX secolo la vita dunque non esiste ma esistono solo gli esseri viventi, i quali «formano una, o piuttosto numerose classi entro la serie di tutte le cose del mondo: e se si può parlare della vita lo si fa unicamente come di un carattere – nel senso tassonomico della parola – entro l’universale distribuzione degli esseri». Forte della magnifica corrispondenza tra cose e parole, essere e ratio, linguaggio mondo e pensiero, «il naturalista è [dunque] l’uomo del visibile strutturato e della denominazione caratteristica. Non della vita»[19]. Il biologo, per converso, è l’uomo dell’invisibile forza che costantemente struttura e destruttura le forme viventi. Il bioeticista, a sua volta, non potrà essere che l’uomo che nella sua impresa eticizzante dovrà necessariamente imbattersi in questa anomica forza di destrutturazione e quindi fondare su nuove basi, non più naturalistiche, una possibile etica della vita.
- Non ci resta che il Nichilismo? La proposta del “Nuovo pensiero”
A molti la scomparsa di una natura paradigmatica[20] appare come l’inevitabile condanna a un mortifero nichilismo. Se la natura e la vita diventano mute, dicono in molti, non resta altro che accettare lo scacco di dover riconoscere come eticamente lecito tutto quello che è tecnicamente realizzabile, finendo cosi col partecipare volenti o nolenti alle glorie laicistiche di un inarrestabile utilitarismo. Come pensare, infatti, che in questo quadro possa ancora sussistere lo spazio per una bioetica di orientamento religioso, visto e considerato il profondo feeling che la sensibilità religiosa solitamente imbastisce con le trame dell’ontologia? Eppure i margini per una bioetica siffatta non appaiono del tutto inesistenti, considerato che accanto all’ontologismo di derivazione cristiana, e in particolare cattolica, la cultura religiosa, intesa nel senso più ampio possibile, mette a disposizione delle nostre analisi molti altri serbatoi concettuali e categoriali cui attingere. Tra essi spicca senz’altro quello ebraico. La tradizione ebraica, per bocca di alcuni significativi interpreti del XX secolo, ci dischiude infatti nuove prospettive teoretiche per pensare un’etica per la bioetica, e ce le dischiude nella misura in cui il cosiddetto “Nuovo pensiero”, inaugurato da pensatori quali Hermann Cohen, Leo Baeck, Franz Rosenzweig, Abraham Heschel, Emmanuel Lévinas, solo per citarne alcuni, ha potuto ingaggiare nel solco della tradizione ebraica una delle più radicali critiche alla rigida ontologia del pensiero occidentale e, di qui, ha contribuito a spostare l’accento di ogni filosofia morale che intenda farsi interprete del proprio tempo dal primato dell’Essere al primato dell’Agire[21]. Distante da ogni gioco di rispecchiamenti tra ontologia e conoscenza del divino, la religione ebraica (con le dovute precisazioni si potrebbe dire la filosofia ebraica[22]) si interessa essenzialmente all’etica e dunque trova nella dimensione dell’agire e non in quella dell’essere il suo elemento privilegiato. Come ha scritto Leo Baeck ne L’essenza dell’ebraismo,
La conoscenza del divino ci istruisce su ciò che l’uomo deve essere: il divino ci dice che cosa è l’umano. […] L’ebraismo non è solo etico, bensì l’etica costituisce il suo principio, la sua essenza[23].
Svanito l’ordine iscritto nell’essere stesso delle cose, svanito quest’ordine per mano dei saperi scientifici, qualsiasi operazione diretta a rinsaldare una cosmologia o magari una biologia nuovamente sature di ordine e di valori, assume nel migliore dei casi le fattezze di un’operazione nostalgica se non addirittura naif, in ogni caso inattuale e pertanto inadatta a dettare i criteri cui ispirare eventuali limitazioni ai sempre più ampi poteri di intervento sprigionati dalle fucine della tecnica. Proprio perché si candida a svolgere il ruolo di coscienza delle “scienze nuove”, la bioetica non può certo pensare di ignorarne le acquisizioni o eludere le loro rinnovate ontologie di riferimento, ma ha da pensare, o magari da riscoprire, nuove fondamenta per una nuova moralità. È proprio per queste ragioni che, nell’ambito della riflessione bioetica, può assumere un ruolo teoreticamente assai significativo un pensiero che, come dice Lévinas, pone le ragioni del proprio filosofare non più nell’essere e nell’ontologia ma nell’Altrimenti che essere o al di là dell’essenza[24].
[1] Com’è noto il termine “bioetica” nasce ad opera dell’oncologo Van Rensselaer Potter quando, nel 1970, pubblica l’articolo Bioethics. The science of Survival, in «Perspectives in Biology and Medicine», 14, 1970, pp. 127-153. Di notevole significato, come più volte ha avuto modo di sottolineare lo stesso Potter, è anche un altro articolo pubblicato lo stesso anno, Biocybernetics and Survival, in «Zygon. Journal of Religion and Sciences», 5, 1970, pp. 229-246. Tuttavia è nell’anno successivo, nel 1971, che Potter pubblica quello che di fatto sarà il libro che formalizzerà la nascita di questa nuova disciplina: Bioethics. A Bridge to the Future, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1971, tr. it. Bioetica. Ponte per il futuro, Messina 2000.
[2] Come sottolinea lo stesso Potter: «Ho scelto bio- per indicare il sapere biologico, la scienza dunque dei sistemi viventi; e ho scelto -etica per indicare il sapere circa i sistemi di valori umani. V. R. Potter, Humility and responsibility – A Bioethic for Oncologist: Presidential Address, in «Cancer Research», 35, 1975, pp. 2297-2306: 2299.
[3] Cfr. P. Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna (1961), Liguori, Napoli 2000, pp. 61-75.
[4] Cfr. H. Jonas, Principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1978), tr. it. Einaudi, Torino 1990.
[5] Cfr. S. Hawking, Dal Big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo (1988), tr. it. BUR, Milano 1994. Hawking per esempio sottolinea come «La vecchia idea di un universo essenzialmente immutabile che potrebbe esistere da sempre, e che potrebbe continuare a esistere per sempre, fu sostituita (negli anni Venti del XX secolo) dalla nozione di un universo dinamico in espansione, che sembrava avere avuto inizio in un tempo finito in passato, e che potrebbe durare per un tempo finito in futuro». E aggiunge: «Deve esserci stato un tempo, nella fase iniziale della vita dell’universo, in cui l’universo era così piccolo che bisogna dedurne che in relazione ad esso non si possano più ignorare gli effetti su piccola scala dell’altra grande teoria parziale del XX secolo, la meccanica quantistica», p. 50 e p. 69. Poiché la meccanica quantistica, come è noto, introietta nella fisica il principio di indeterminazione, se ne deduce come la cosmologia abbia oggi finito col riconoscere l’esistenza di un certo livello di “irrazionalità” nel cosmo, ovvero nella materia.
[6] Cfr. J. Maynard Smith, The problems of Biology, Oxford 1986.
[7] Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida (2000), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2002.
[8] J. Ratzinger, Teologia e politica nella Chiesa, in Chiesa, ecumenismo e politica, Nuovi saggi di ecclesiologia, Jaca Book, Milano 1987, p. 148.
[9] K. Löwith, Sämtliche Schriften, Stuttgart, p. 409.
[10] H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica (1966), tr. it. Einaudi, Torino 1999, pp. 52-74.
[11] Ibid., pp. 59-60.
[12] Ibid., p. 60.
[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Cfr. D. Tarizzo, La vita, un’invenzione recente, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 84-87.
[16] Ibid., p. 85.
[17] Cfr. A. Del Giudice, Hans Jonas: la bioetica come problema di storia della filosofia, Giannini, Napoli 2007, p. 254.
[18] M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (1966), tr. it. Bompiani, Milano 1998, pp. 143-144. Corsivo mio.
[19] Ibid., pp. 178-179.
[20] Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana? (1973), tr. it. Feltrinelli, Milano 2001.
[21] Sulle sfaccettature e le complesse articolazioni del cosiddetto “Nuovo pensiero” rimane utilissimo il volume di E. D'Antuono, Ebraismo e filosofia. Saggio su Franz Rosenzweig, Guida, Napoli 1999.
[22] Sulla correttezza di una tale denominazione si veda quanto osservato da Gianluca Giannini: «Di “filosofia ebraica” è consentito parlare, purché con questa dicitura non si indichi una elaborazione di mera matrice, di genitura, giudaica, bensì una produzione calata appieno in un determinato contesto culturale, attraversata e sovente dedotta da una specifica, unica nel suo complesso e, quindi, inassorbibile in altra, tradizione che ebbe inizio allorquando Abramo lasciò la città di Ur e si pose in cammino nel deserto, dando vita ad una religione monoteistica, totalmente defisicizzata, contraltare della idolatria pagana e tale da non proporsi come un patrimonio di fede rivelato una volta per tutte sul Sinai, tramandato senza mutamenti, bensì come una religione “sempre in crescita”». G. Giannini, Abraham Joshua Heschel e l'Ebraismo dal Nordamerica, in «Dialeghestai. Rivista telematica di filosofia», http://mondodomani.org/dialegesthai/gg01.htm.
[23] L. Baeck, L’essenza dell’ebraismo (1936), tr. it. Marietti, Genova 1988, p. 15.
[24] E. Lévinas, Altrimenti che essere o dal di là dell’essenza (1974), tr. it. Jaca Book, Milano 2006.