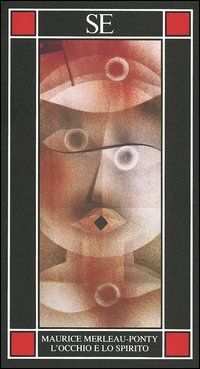L’Oeil et l’Esprit è l’ultimo saggio portato a termine da Merleau-Ponty nell’estate del 1960. A leggere il testo si ha la sensazione che l’autore proceda verso un’interrogazione della visione in modo originario, «come se tutte le sue opere precedenti non pesassero sul suo pensiero» (p. 71), sostiene Claude Lefort all’interno della postfazione. Già dal titolo, L’Oeil et l’Esprit,si individua il soggetto dell’interrogazione e il suo medium: lo spirito e l’occhio. L’occhio, infatti, è l’apertura verso il mondo, nel quale l’autore vorrebbe ricollocare il nostro spirito. Questo tentativo è reso possibile dall’arte e in modo particolare dalla pittura, che attingono a questo strato di senso bruto, ossia alla nostra storicità primordiale. Tale meditazione si sviluppa da una questione ben precisa, di cui l’autore parla sin dalle prime pagine: il manipolandum che l’uomo pensa di essere e che è diventato entrando in un regime di cultura, dove non esistono né vero né falso in merito a se stesso e alla storia. Egli, perciò, vive in un sonno o incubo da cui non esiste risveglio. Queste questioni non sono molto distanti da quelle che ci toccano più da vicino, seppure, ormai, siamo alla deriva di un processo che Merleau-Ponty ha vissuto nella sua pienezza.
Ora, «la scienza manipola le cose e rinuncia ad abitarle»e «si confronta di quando in quando con il mondo effettuale», trattando ogni essere come un oggetto in generale, mentre la scienza classica «conservava il senso dell’opacità del mondo, ed era il mondo che intendeva raggiungere con le sue costruzioni» (p. 13). In tal senso è necessario «che il pensiero scientifico si ricollochi in un c’è preliminare, nel luogo, sul terreno del mondo sensibile e del mondo lavorato, così come sono nella nostra vita». Si tratta di un’affermazione carica di significato, perché non si focalizza soltanto sul referente ultimo della scienza, il mondo sensibile, ma anche su chi opera in esso: il nostro corpo; «non quel corpo possibile che è lecito definire una macchina dell’informazione, ma questo corpo effettuale che chiamo mio», «la sentinella che vigila silenziosa sotto le mie parole e sotto le mie sensazioni» (p. 15). Ha ragione dunque Lefort quando dice che la scrittura dell’autore riecheggia lo splendore del visibile e lo trasmette. Le pagine che seguono sono l’espressione di tale intento e sviluppano, inoltre, l’interessante intreccio tra scienza e arte, laddove quest’ultima ci ricolloca negli spazi dai quali i sofismi della ragione ci hanno allontanato.
Il pittore, interessandosi (inter-esse) al mondo e prestando il suo corpo, lo trasforma in pittura. Per «comprendere tali transustanziazioni, bisogna ritrovare il corpo operante ed effettuale, che non è porzione di spazio, un fascio di funzioni», bensì un intreccio di visione e movimento. Questo corpo mobile rientra nel mondo visibile, ne fa parte e per questo possiamo dirigerlo nel visibile. È possibile perché «tutto ciò che vedo è per principio alla mia portata, segnato sulla mappa dell’io posso» (p. 17); «immerso nel visibile mediante il suo corpo, anch’esso visibile, il vedente non si appropria di ciò che vede: l’accosta soltanto allo sguardo, che apre sul mondo» (p. 18). Di qui si libera lo stupore di chi si muove nel mondo col proprio corpo, fonte di ogni sapere che va, talvolta, al di là del concepibile. L’enigma di questo doppio intreccio mondo-corpo sta nel fatto che il corpo è insieme vedente e visibile. Esso è annoverabile tra le cose, «ma poiché vede e si muove, tiene le cose in cerchio intorno a sé»(p. 19); c’è un re-incrociarsi fra vedente evisibile, fra chi tocca e chi è toccato, quando si accende la scintilla della percezione sensibile.
La pittura illustra l’enigma del corpo, «qualità, luce, colore, profondità, che sono laggiù davanti a noi, sono là soltanto perché risveglino un’eco nel nostro corpo, perché esso li accolga» (p. 20). E così il pittore impara da se stesso vedendo, perché «è toccato da un certo impatto con il mondo, e lo restituisce al visibile mediante i segni tracciati dalla mano» (p. 23), donando esistenza a ciò che la visione profana crede invisibile. «L’interrogazione della pittura mira a questa genesi segreta e fabbrile delle cose nel nostro corpo» (p. 25). Si comprende che il corpo è quel medium, quella via di mezzo tra lo spirito e il mondo. Premessa dimenticata dalla visione in senso profano.
Non stupisce il richiamo dell’autore alla Dioptrique di Cartesio, il breviario «di un pensiero che non vuole più abitare il visibile» (p. 29), ma ricostruirlo secondo il modello che se ne crea. La visione, invece, non è la metamorfosi delle cose stesse nella visione che ne abbiamo, ma è pensiero che decifra, in modo rigoroso, i segni dati nel corpo. Questa visione di fatto e il c’è che contiene è un segreto perduto, fin quando non viene ritrovato un nuovo equilibrio fra scienza e filosofia. Per questo motivo l’autore ricerca un pensiero sul quel composto di anima e corpo che noi siamo, su quel sapere di posizione o situazione cui Cartesio si era dedicato, per raggiungere un esito che ci consenta di cogliere una questione molto profonda: l’enigma dell’esteriorità. L’attenzione data alla pittura si muove in questa direzione poiché quel tipo di visione non è uno sguardo su un di fuori, secondo una relazione fisico-ottica col mondo. «Il mondo non è più davanti a lui per rappresentazione: è piuttosto il pittore che nasce nelle cose» (p. 49) e perforando la pelle delle cose mostra come esse si fanno in quanto tali. La conseguenza è che l’arte non può più dirsi costruzione, artificio, rapporto industrioso con uno spazio e un mondo esterno, «il quadro fornirebbe ai miei occhi più o meno quel che viene offerto dai movimenti reali» (p. 54). Al cuore di tale esperienza si giunge quando si definisce l’occhio come la finestra dell’anima, poiché si compie il prodigio di aprire a essa ciò che non è anima.
Merleau-Ponty scopre lo spazio in cui la ragione ritorna a interrogarsi, lo stato di uno stupore continuo, l’Essere quel che non è mai completamente. In questa interrogazione perenne la ragione reclama una positività per colmare il suo vuoto e su questo terreno instabile si costituisce il nostro essere manipolandum. «Se le creazioni non sono», però, «un dato acquisito, non è solo perché passano, come tutte le cose, ma perché hanno pressoché tutta la loro vita dinanzi a sé» (p.63). Esse, dunque, restano tentativi di traduzione di un che di misterioso che, come ha scritto J. Gasquet, il celebre biografo di Cézanne, «s’aggroviglia alle radici stesse dell’essere, alla sorgente impalpabile delle sensazioni».
Nunzia Capasso
11_2009