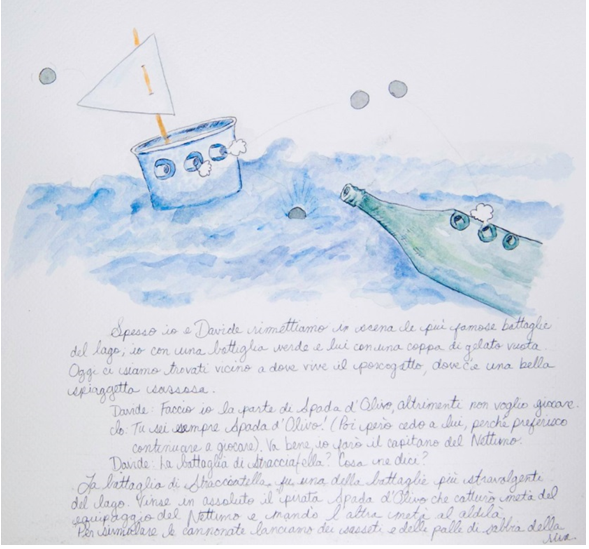Autore
Indice
- La psichiatria: un problema di definizione
- La questione delle norme tra biologia e scienze umane: fatti o valori?
- Il nodo dell’anomia e come ripensare il nesso vitale/sociale
- Scienza dell’uomo o dispositivo di potere? A mo’ di conclusione inconcludente
↓download pdf
S&F_n. 14_2015
Abstract
Anomy, Abnormality and Pathology: Remarks on relationship between Philosophy, Humanities and Psichiatry
In this paper we intend to analyse the relationship between philosophy, psychiatry and, in wider terms, among human sciences. The key issue is here identified as the mechanism that produces the relationship between physiology (normality) and pathology in medical and the human sciences. The path that we will follow is divided into three stages: first, we will analyse the confusion between fact and value (i.e.; between the quantitative and qualitative dimension in the human phenomenon); second, we will approach the connection between the birth of the human sciences and the emergence of the device normal/pathological (Comte and the principle Broussais; Durkheim and the notion of anomie in relation to the division of labour and suicide); finally, we will touch upon the ultimate question about psychiatry: is it a science of “man” (Binswanger) or a knowledge/power based device that determines the structure of modernity (Foucault)?
1. La psichiatria: un problema di definizione
«Non c’è una sola psichiatria» dice Eugenio Borgna, psichiatra di formazione fenomenologica, «ma ci sono (dunque) diverse psichiatrie» e «ogni psichiatria sottintende un suo proprio metodo conoscitivo e un suo proprio orizzonte tematico» a tal punto che «a ciascuna psichiatria è collegato fatalmente un suo proprio atteggiamento interiore»[1]. Questa citazione, che potrebbe essere messa da esergo a qualsiasi saggio che intenda analizzare lo statuto epistemologico di questa particolarissima “scienza”, la psichiatria, mette immediatamente al centro dell’attenzione alcuni elementi assolutamente fondamentali: in primo luogo, il fatto che la psichiatria non possa essere una sola laddove il suo oggetto – per definizione sfuggente: la “malattia mentale” – necessita di un particolare metodo di conoscenza e di un ancor più particolare orizzonte di senso, non è una sola, insomma, perché il suo oggetto è multiforme e camaleontico; in secondo luogo, la psichiatria avrebbe un proprio atteggiamento interiore, il che indica come la costruzione di un sapere, soprattutto quando è liminale tra la scienza e i “saperi dell’uomo”, presupponga da parte del “soggetto” un modo particolare di porsi dinanzi al proprio “oggetto”, una "postura" o, se si vuole, una visione del mondo.
Questa complessità richiama da vicino – seppur con la dovuta distanza nella percezione del problema – quanto Michel Foucault pensava del dispositivo di sapere/potere che sarebbe stato messo in campo dalla psichiatria, laddove sosteneva che essa si colloca «nella zona di confine che sta tra una manifestazione della verità secondo le norme della conoscenza e una produzione della verità nella forma della prova», mettendo in crisi «la stessa conoscenza, la sua forma, la norma “soggetto-oggetto”» e richiamando l’attenzione su «i rapporti tra le strutture economiche e politiche della nostra società e la conoscenza»[2]. È chiaro, dunque, che quando ci si trova a parlare di psichiatria, dal punto di vista filosofico e delle cosiddette scienze umane, la complessità del suo oggetto – la “malattia mentale” – si arricchisce di determinazioni che provengono da almeno tre orizzonti di senso e atteggiamenti differenti: innanzitutto, quello che potremmo definire come “concezione naturalistica e biologica” della psichiatria in connessione alla relazione normale/anormale (o patologico); su un altro piano, quello che potremmo definire come “concezione sociologica e politica (in senso lato)” di essa in connessione a una prospettiva sociogenetica; infine, quello che potrebbe essere definito come “approccio fenomenologico-esistenziale” a partire dalla condition humain.
Tra i vari metodi conoscitivi, orizzonti di senso e atteggiamenti fondamentali che la psichiatria ha messo in campo, questi tre rappresentano altrettante interrogazioni per la filosofia. Dalla “concezione naturale e biologica” non possono che sorgere domande intorno allo statuto epistemologico della scienza psichiatrica e del suo oggetto, la malattia mentale, o, come direbbe Ludwig Binswanger, l’uomo[3], e soprattutto non ci si può non interrogare circa la dimensione “biologica” dalla quale sembra essere sorto l’intero orizzonte di comprensione della realtà della modernità matura – il problema ideologico della naturalizzazione dell’umano e della relazione complessa natura/cultura. Dalla “concezione sociologica e politica (in senso lato)” non possono che presentarsi domande intorno alla stessa costituzione della socialità moderna e su come la stessa relazione normale/anormale non riguardi soltanto l’oggetto della psichiatria ma diventi una sorta di passe-partout per la comprensione dei dispositivi di funzionamento della realtà sociale moderna; tale concezione, inoltre, pone anche il problema per nulla secondario delle cause: se esse siano riducibili a modificazioni di carattere biologico oppure a modificazioni e a forme di “autoriproduzione” soggettiva delle trasformazioni che si compiono nel reale; infine essa ci interroga sui rapporti tra norme sociali e norme vitali in un orizzonte complessivo che dal piano individuale passa a quello vitale e sociale. Dall’“approccio fenomenologico-esistenziale” sorgono domande che pongono l’uomo al centro della riflessione, quale sia la sua costituzione e cosa rappresenti, dal punto di vista della struttura fondamentale dell’esserci, la possibilità stessa della cosiddetta “malattia mentale”; essa, nel suo dispiegarsi nella realtà empirica (ontica) con modificazioni sempre differenti, potrebbe divenire la cartina di tornasole per la comprensione (ontologica) dell’umano, delle sue possibilità, della sua storicità.
Il nostro punto di partenza, all’interno di queste note, è proprio cercare la maniera attraverso la quale questi tre piani possano trovare un punto di incontro, o, per meglio dire, cercare di comprendere quale sia la base comune che ha permesso che sorgesse una psichiatria nella modernità e quale il motivo per cui essa possa interrogare il proprio oggetto a partire da metodi, orizzonti e atteggiamenti tanto distanti l’uno dall’altro.
Se «nell’orizzonte di una psichiatria somatologica (biologica) non può esistere una soggettività […] portatrice di segni che cambiano la loro connotazione semantica da un contesto ambientale all’altro»[4], è anche vero che «non tutta la psichiatria può essere ricondotta a una condizione sovrastrutturale (epifenomenica) di radici sociogenetiche»[5]; insomma, si tratta di provare a comprendere lo sfondo a partire dal quale è stato possibile produrre un sapere psichiatrico e perché la posta in gioco della sua definizione sia tanto alta: all’interno delle sue determinazioni, sembra possibile ritrovare il fondo di tutte le domande sull’uomo come ente dotato di senso, dalla sua dimensione naturale-biologica e l’operatività di essa alla sua dimensione intimamente sociale e, se vogliamo, intersoggettiva, fino allo sprofondamento nell’abisso, dolorosamente individuale, dell’inconscio. Il percorso (necessariamente limitato) che cercheremo di attraversare si compone, allora, di tre passaggi fondamentali: in primo luogo, la relazione tra norme vitali e norme sociali e la questione (labirintica) della relazione tra normale e anormale nella confusione (determinante e, forse, determinata) tra fatto e valore; in secondo luogo, si analizzerà il sorgere delle scienze umane nella modernità a partire dall’orizzonte di senso determinato dalla relazione normale/anormale e si approfondirà in particolare la nozione durkheimiana di anomia – al centro sarà posto lo “scandalo” rappresentato dal suicidio; infine, si ritornerà sullo statuto se non altro anfibio della psichiatria, chiedendoci (senza, probabilmente, trovare risposta) se essa sia (o possa essere) realmente una scienza dell’uomo o se la sua operatività fondamentale riguardi la sua determinazione come “dispositivo di sapere/potere” all’interno del quale si definiscono le caratteristiche della costituzione della nostra società contemporanea e della nostra possibilità di comprensione di essa.
- La questione delle norme tra biologia e scienze umane: fatti o valori?
Innanzitutto, il problema della norma. Quando ci si approccia alla questione della relazione tra normale e patologico (o “anormale”) nello sviluppo delle scienze sociali, punto di partenza resta l’importante saggio di Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, all’interno del quale si pongono le basi per una riflessione quanto mai complessiva (ma non, ovviamente, risolutiva) sulla questione[6]. L’interrogazione fondamentale, al di là della ricchezza dei materiali presenti nel testo, riguarda la relazione tra una dimensione qualitativa e una dimensione quantitativa nel processo di comprensione del fenomeno umano e delle sue forme di espressione fisiologiche e patologiche: in poche parole, la salute, come anche la malattia, sono dei fatti o dei valori? Si tratta di una questione di analisi quantitativa o di definizione qualitativa? La risposta, ovviamente, non è semplice, anche se Canguilhem la tenta nella direzione di un vitalismo della forma-di-vita e della salute come stato essenzialmente connesso alla possibilità reale di espressione, potenza e apertura al mondo da parte di quel vivente particolare che è il vivente umano[7]. A noi, in questa sede, interessa analizzare un altro aspetto, il dispositivo mediante il quale la relazione normale/patologico, posta a fondamento di quella che dovrebbe essere considerata la scienza umana per eccellenza, la scienza medica e psichiatrica, non soltanto si esponga in tutta la sua ambiguità irrisolta, ma soprattutto si riversi all’interno delle scienze umane, fornendo loro il punto d’appoggio per la propria formulazione. Insomma, il nodo delle norme vitali (salute/malattia) funge da premessa latente della questione patente delle norme sociali (normale/anormale) e sembra sempre più chiaro che l’analisi dal punto di vista biologico (in senso moderno) del fenomeno umano non possa scindersi da due fondamentali “emergenze”: da un lato, quella che potrebbe essere definita la “nascita del sociale” nella modernità – insomma tra il dispositivo di sapere vitale-biologico e quello sociale ci sarebbe una relazione immediata e non soltanto di “contemporaneità” ma di implicazione reciproca; dall’altro, quella che potrebbe essere definita la ”percezione della finitudine” – la finitezza biologico-vitale dell’umano sarebbe alla base della “confusione” (che ha avuto e continua ad avere risvolti tecnico-politici inquietanti) tra la dimensione soggettiva e la dimensione oggettiva del fenomeno umano – l’uomo come soggetto e portatore di valori e l’uomo come oggetto e manifestazione di fatti e la distanza tra queste due determinazioni e la politica/polemica della loro relazione[8].
Georges Canguilhem, in realtà, nota "semplicemente" come in Claude Bernard, fondatore della clinica moderna e coagulo di molte questioni fondamentali e fondanti la modernità, vi sia «una compresenza di concetti qualitativi e quantitativi nella definizione data dei fenomeni patologici»[9] e ancor di più un’indagine sul vitale che si compie nella duplice determinazione di meccanismo ed espressione[10]. Nel fondatore della medicina di laboratorio moderna, un fenomeno fisiologico o patologico, o, per meglio dire, la possibilità continuata del passaggio dall’uno all’altro, può essere indagato in maniera quantitativa, a partire dal meccanismo di funzionamento dell’organo o della funzione (il “meccanicismo” di Claude Bernard), o può essere analizzato dal punto di vista qualitativo come forma di espressione dis-ordinata, dis-armonica e s-proporzionata dell’intero organismo umano da intendersi come un “tutto” (il “vitalismo” di Claude Bernard) [11]. Il problema del normale nella medicina moderna è proprio questo: considerare salute e malattia come fatti quantitativamente descrivibili ma determinarli e agire su di essi, anche dal punto di vista dell’immaginario, come valori qualitativamente connotati; in questo senso, è chiaro come la medicina, comunque la si voglia intendere, rappresenti, anche soltanto per questo, una scienza umana più che una scienza naturale: l’uomo è allo stesso tempo l’oggetto di questa scienza e il soggetto di questa conoscenza e la sua selvaggia finitudine biologico-vitale viene ricondotta alla realtà mediante la costruzione di un uomo cosificato, ridotto ad oggetto misurabile quantitativamente (semplicemente-presente) e osservato dall’uomo-scienziato che legge nella misura quantitativa del fatto la realizzazione qualitativa del valore. Semplificando al massimo, il nesso che intendiamo sottolineare è che la stessa nascita della relazione normale/anormale in medicina determina la “confusione” o il “passaggio” da normale a normativo: ciò che è da considerarsi in misura quantitativa normale (e plasmata da questa, poi, in maniera qualitativa) diviene il paradigma normativo della realizzazione individuale e collettiva dell’umano. Non è un caso, insomma, che la questione del normale e dell’anormale come chiave di lettura della realtà umana sia nata proprio con il fondatore del positivismo e della sociologia moderna, Auguste Comte.
Il filosofo francese – la cui influenza sull’intero sviluppo successivo della riflessione francese, anche per negazione o rimozione, è ancora probabilmente da misurare in tutta la sua portata – aveva notato immediatamente come la medicina nascente (e poi sistematizzata da Claude Bernard) avesse prodotto uno dei paradigmi fondamentali per la comprensione dei fenomeni umani e sociali – il “principio Broussais” secondo il quale salute e malattia si differenziano soltanto per “intensità” quantitativa – e che tale paradigma andasse posto a fondamento della nuova scienza della società, quella “sociologia”, il cui compito era essenzialmente “sociocratico”, cioè di analizzare le strutture fondamentali del vivere in comune in vista della realizzazione, allo stesso tempo spirituale e razionale, del potere sociale umano[12]. Ciò che preme sottolineare è che Auguste Comte, nella sua definizione e nel suo intrecciare biocrazia e sociocrazia, aveva posto le basi di quella relazione complessa tra la dimensione del sapere (la razionalità scientifica “applicata” all’umano) e la dimensione del potere (la razionalità scientifica “applicata” alle tecniche di governo) sullo sfondo e l’orizzonte determinato dalla dimensione sfuggente della vita come ciò a partire dal quale è possibile affrontare un discorso biologico o sociale sull’umano, quella finitudine umana stritolata da una forza selvaggia, incomprensibile e che "tumultua" nel fondo oscuro del vivente e che porta con sé pulsioni incontrollate e dunque “da controllare”. La stretta relazione tra la questione del normale/anormale e la dimensione sociale (e poi, va da sé, politica) del problema può essere espressa in maniera ancora più limpida, se si analizza la maniera attraverso la quale il padre della sociologia francese nonché uno dei padri indiscussi della sociologia contemporanea, Émile Durkheim, applica, nel testo fondativo Le regole del metodo sociologico del 1895, al “corpo sociale” il medesimo schema che la medicina applica al “corpo vivente” – e così se il “corpo sociale” è destinato a contrarre malattie, come del resto accade al “corpo vivente”, diviene chiaro che «il dovere dell’uomo di Stato non è più quello di spingere violentemente le società verso un ideale che gli sembra seducente, ma il suo ruolo è quello del medico: egli previene l’insorgere delle malattie attraverso una buona igiene e, quando esse sono dichiarate, cerca di guarirle»[13]. Insomma, se il sociale può essere analizzato con gli stessi paradigmi epistemologici del vitale, è chiaro come la medesima confusione di fatto e valore, che abbiamo visto a fondamento della scienza medica e psichiatrica, si determini in maniera del tutto simile anche all’interno della scienza sociologica; anzi, con Durkheim è possibile dire che quella che noi definiamo “confusione” sia un vero e proprio progetto culturale e politico, che trova la sua fondazione nella definizione di fatto sociale[14]. La complessità di questa nuova nozione si determina proprio per il fatto che esso rappresenta allo stesso tempo un fatto oggettivo, dunque passibile di analisi di carattere “scientifico” e quantitativo, ma rappresenti anche un obbligo costrittivo morale capace di esercitare una costrizione esterna sull’individuo, dunque come valore. Il sociale, allora, si determina alla stessa maniera mediante la quale si determina il vitale: esso è un fatto, nella misura in cui è suscettibile di variazioni quantitative – Durkheim del resto accorda grande “fiducia” alla dimensione della statistica e della demografia – ma è anche un valore nella misura in cui rappresenta una forza costrittiva e una linea di tendenza che si produce all’interno dell’umano. Nelle società umane – come nei singoli corpi individuali – il normale si fa normativo e il patologico/anormale si fa devianza[15]: il dispositivo, del quale la medicina e la psichiatria sono allo stesso tempo causa ed effetto, si è prodotto e la relazione complessa e, se vogliamo, contraddittoria tra norme vitali e norme sociali è venuta alla luce.
L’ultimo elemento che occorre sottolineare è che vi è una contemporaneità di nascita per quanto riguarda il “vitale” (inteso in senso moderno, come quella forza sfuggente che tutto permea e che si fa soltanto in parte imbrigliare in una concezione quantitativa e che diviene poi, con Darwin, motore della storia universale degli esseri viventi) e il “sociale” (anch’esso inteso in senso moderno, come quella dimensione che si produce con la fine delle relazioni “naturali” tra gli individui e la relazione ciclica di essi con la natura – la “premodernità”): questa contemporaneità è delineata proprio dal paradigma Broussais, da Comte e poi da Durkheim, insomma, allo stesso tempo determinata e delineata dalla relazione normale/anormale e dalla base sulla quale si è prodotta. In questo senso, la psichiatria ha avuto un ruolo assolutamente determinante: da un lato si è posta come “conoscenza” e ha definito e lavorato intorno alla distinzione tra normale e anormale in maniera tale da rispecchiare a pieno il dispositivo della modernità, probabilmente producendolo o, comunque, definendolo nella maniera più “netta”; dall’altro si è immediatamente posta come una “pratica” di confine tra una concezione complessiva dell’uomo (antropologia), una concezione dei doveri dell’uomo (morale) e una concezione di igiene pubblica di cui devono essere fatti oggetto gli uomini (politica). La devianza, come ciò che si definisce nei termini di anormalità e patologia, non può che essere uno dei centri fondamentali per l’analisi del funzionamento delle società contemporanea: l’esigenza dell’esclusione (che può essere, ovviamente, anche “includente” attraverso le istituzionalizzazioni della “cura”[16]) conduce all’inferiorizzazione di determinati gruppi umani e sociali, e, quando i processi di esclusione e di inferiorizzazione trovano la propria base su una dimensione naturale e biologica del fatto umano, ritraducendole sempre in una dimensione di valore (è la confusione propria della modernità), è chiaro come il dispositivo medico-psichiatrico funzioni da paradigma complessivo in vista della comprensione e del “controllo” del fenomeno umano.
È possibile, allora, dire che il problema della relazione tra norme vitali e norme sociali si determini in questo modo, nella contrapposizione tra l’idea dell’anormale come variante quantitativa (un fatto) che porta al(la necessità di) controllo sociale e l’idea dell’anormale come variante qualitativa (un valore) che porta al(la possibilità di) conflitto sociale; ed è chiaro, allo stesso tempo, che la psichiatria viva tutte queste contraddizioni e le esponga nella sua stessa storia e nella sua stessa “complessità epistemologica”[17]. Il nesso, sul piano politico, si sposta sulla dicotomia controllo/conflitto.
L’anormalità biologico-sociale (fatto-valore) diviene – sociologicamente – anomia e, soprattutto, diviene una sfida contemporaneamente a ciò che è “giusto” biologicamente e a ciò che è “giusto” socialmente; non è un caso, dunque, che uno dei primi grandi problemi delle moderne scienze umane e della sociologia europea sia stato il suicidio: «non bisogna stupirsi che il suicidio – crimine un tempo, poiché era un modo di usurpare il diritto di morte che solo il sovrano, quello terreno e quello dell’al di là, aveva il diritto di esercitare – sia diventato nel corso del XIX secolo uno dei primi comportamenti ad entrare nel campo dell’analisi sociologica; esso faceva apparire, alle frontiere e negli interstizi del potere che si esercita sulla vita, il diritto individuale e privato di morire. Quest’ostinazione a morire, così strana e tuttavia così regolare, così costante nelle sue manifestazioni, così poco spiegabile con particolarità o accidenti individuali, fu uno dei primi stupori di una società il cui potere politico si era dato il compito di gestire la vita»[18]. Il passaggio latente da Auguste Comte a Michel Foucault diviene immediatamente patente.
- Il nodo dell’anomia e come ripensare il nesso vitale/sociale
Nell’ambito della scienza sociologica assume particolare valore – e, soprattutto, per quanto riguarda il nostro discorso sulla relazione tra vitale e sociale – il concetto durkheimiano di anomia. Si tratta di una concettualizzazione che dà pienamente il senso di quanto si andava dicendo precedentemente: nel tentativo di costruzione scientifica delle basi della sociologia, Durkheim “crea” questa nozione per poi abbandonarla nelle opere della maturità – la motivazione di questo “abbandono” sta nel fatto che probabilmente si tratta di un “qualcosa” di dubbia scientificità e che avrebbe a che vedere con un “atteggiamento interiore” o “orizzonte di senso” più che con una definizione rigorosa di carattere scientifico, una mescolanza, ancora una volta e forse troppo esasperata ed evidente, di fatto e valore. La storia del concetto di anomia, comunque, non si chiude con Durkheim ma riceve nuova vita (oltre che un tradimento concettuale, anch’esso capace di “slatentizzare” un passaggio importante nella modernità matura) nella sociologia della devianza di stampo anglo-sassone – quest’ultimo aspetto verrà soltanto sfiorato, perché ci si intende concentrare soprattutto sull’“origine” della questione[19].
È possibile affermare in via del tutto preliminare come l’anomia abbia, nel sistema durkheimiano e nella sua specifica metaforologia inconsapevole, la funzione di descrivere il sintomo sociale da considerarsi più rilevante e “pericoloso”; la motivazione è che esso rappresenterebbe la manifestazione di un disagio di natura patologica che può sempre colpire e che sembra che, proprio con l’avvento della società organica e borghese, stia colpendo il corpo sociale. La nozione viene approfondita – e non è un caso – nelle due opere fondative della sua sociologia: La divisione del lavoro sociale del 1893[20] e Il suicidio del 1897[21]. Per cogliere il suo valore sintomatologico, bisogna descrivere rapidamente qual è lo stato di salute secondo Durkheim in cui può (e deve) vivere il corpo sociale: nel passaggio dalla solidarietà meccanica alla solidarietà organica, lo stato di salute è determinato dal fatto che la società va in contro a una complessificazione e a una maggiore articolazione delle sue funzioni attraverso una sempre più specializzata divisione del lavoro sociale; contemporaneamente, si ha anche una maggiore “densità” di tipo morale proprio perché si accresce la necessità di una cooperazione sociale e di una vera e propria solidarietà capace di condurre a una maggiore integrazione e di divenire l’unico fondamento possibile per la definizione del progresso umano e sociale – della salute umana e sociale. Il corpo sociale, divenuto “organico”, ne acquisisce le caratteristiche: il vitale entra nel sociale e ciò che rappresenta l’integrazione tra le funzioni di un apparato vitale diviene anche l’integrazione tra le funzioni di un apparato sociale. Il pericolo è la dis-integrazione e la salute si determina, allora, come uno stato di cose che è allo stesso tempo quantitativo (e ha le caratteristiche di un fatto) e qualitativo (si definisce come un valore), dunque un “qualcosa” che può essere analizzato con strumenti che potremmo definire “sociometrici” e un “qualcosa” che diviene un valore fondamentale per lo sviluppo umano e sociale, le magnifiche sorti e progressive. L’anomia, a questo punto, si definisce come sintomo che slatentizza una patologia soggiacente al corpo sociale, nella misura in cui determina una dis-funzione come conseguenza di una dis-integrazione. Secondo Durkheim «un qualsiasi essere vivente non può essere felice né vivere se i suoi bisogni non sono in sufficiente rapporto con i sui mezzi» in quanto «se esigono di più di quanto possa loro essere accordato o, semplicemente, esigono altre cose, saranno frustrati di continuo e non potranno funzionare senza dolore […] nell’animale, per lo meno allo stato normale, quest’equilibrio si stabilisce con una spontaneità automatica perché dipende da condizioni puramente materiali […] ma non è così per l’uomo, perché la maggior parte dei suoi bisogni non sono dipendenti dal corpo, o non lo sono nello stesso grado»[22]. L’anomia, possibilità patologica della modernità “organica”, ha il suo fondamento nella dis-funzione che si produce tra mezzi e fini, cioè quando sopraggiunge una divisione anomica del lavoro: le trasformazioni sociali troppo rapide provocano una trasformazione delle funzioni e dei ruoli prima che esse possano essere regolate dal corpo sociale e riprodotte “serenamente” dall’individuo. Le crisi ma anche le accelerazioni economiche, dunque, hanno la caratteristica della variante ambientale che colpisce un sistema organico, la quale, se vincente, porta a una nuova organizzazione, ma se perdente, porta alla disgregazione. L’anomia, dunque, si mostra come sintomo patologico in quanto manifesta una crisi di regolazione del corpo sociale e diviene fondamentale per l’analisi dell’uomo di Stato, il quale, secondo Durkheim e come abbiamo visto, dovrebbe agire più come un medico che non come “statista”. A questo punto, si coglie in profondità la questione delle norme sociali, della normalità/normatività sociale e della patologia sociale: per anomia, insomma, non bisogna intendere l’assenza complessiva di norme sociali (come potrebbe suggerire l’etimologia del termine), in quanto nessun organismo (naturale o sociale che sia) può sopravvivere senza un insieme di norme di funzionamento; bisogna piuttosto intendere con essa una dis-funzione regolativa e uno stato di dis-integrazione delle norme sociali che non mantengono più il corpo nella sua unità: si tratta di un sintomo piuttosto importante di una nuova regolazione funzionale per cui le norme sociali risultano inadeguate e i bisogni di ogni singolo individuo perdono la propria mediazione (mediazione per imposizione) da parte della coscienza collettiva e della cultura comune. Insomma, l’anomia sembra assumere nelle pagine di Durkheim o la densità della patologia e dell’anormalità sulla quale occorre intervenire con le armi di un medico o addirittura la forma di una sorta di pulsione di morte latente che ogni corpo sociale (come, del resto, secondo Freud, ogni corpo vivente) porta con sé e, a tratti, rende patente e sulla quale bisogna intervenire con gli strumenti di una psichiatria o di un’anti-psichiatria (nella misura in cui, secondo Foucault, la stessa psicanalisi rappresenta il primo movimento anti-psichiatrico nella storia della psichiatria[23]). Il pericolo dell’anarchia che ogni anomia porta con sé non può che essere il pericolo della disgregazione organica del corpo sociale. Forzando, ovviamente, la lettera di Durkheim, possiamo affermare che il suicidio, in questo senso, rappresenti il luogo dove l’anomia diviene ancora più visibile proprio perché rappresenta una pulsione di morte individuale che trova le sue ragioni profonde nella pulsione di morte sociale che ogni sistema di integrazione porta con sé. La psichiatria, dunque, assume proprio questa funzione: regolamentare il corpo e l’anima individuale attraverso un meccanismo istituzionale di regolazione del corpo e dell’anima sociale.
Del resto, si potrebbe anche azzardare un certo parallelismo – almeno nella nostra prospettiva – tra l’anomia o divisione anomica del lavoro e l’alienazione in senso marxiano[24] o, addirittura, tra l’anomia e l’atteggiamento blasé riscontrato da Simmel come "tipico" della modernità dominata dallo spirito oggettivo, intellettualistico e monetario[25]. Continuando con la metaforica della medicina, l’anomia in quanto sintomo di una “crisi” epocale può essere fatta dialogare con l’alienazione e l’atteggiamento blasé nella misura in cui le trasformazioni della modernità, l’ascesa del modo di produzione capitalistico e della morale borghese e l’abbondono delle consolidate forme di comunità “naturali” che hanno caratterizzato il mondo pre-moderno hanno prodotto uno smottamento che si pone essenzialmente su tre livelli: in primo luogo, strutturale perché riguarda l’appartenenza a classi sociali, gruppi e comunità, sulla base di un differente modo di produzione e di una ciclicità economica “nuova” e imprevista che produce (e ri-produce) fenomeni anomici (Durkheim), fenomeni di alienazione (Marx e, se vogliamo, il racconto di Chaplin in Tempi moderni) e atteggiamenti nevrotici (il blasé simmeliano); in secondo luogo, sovrastrutturale perché riguarda la produzione ideologica borghese, come le forme di naturalizzazione dell’umano tipico dell’orizzonte di senso della modernità matura almeno a partire da Adam Smith, muovendo dalle quali si (ri)producono le inferiorizzazioni questa volta di carattere “biologico” che hanno prodotto i più vasti orrori della storia dell’umanità nell’ultimo secolo; in terzo luogo, sottostrutturale perché riguarda anche la produzione dell’Io nella sua dimensione psicologico-individuale e psicologico-collettiva, con lo sviluppo di nuove forme di soggettivazione o di divisioni dell’Io[26], con una vera e propria moltiplicazione di riferimenti individuali e collettivi dove l’unità della persona si perde nei rivoli dei contesti e delle situazioni all’interno del quale si gioca la dinamica adattamento/esclusione che è la rappresentazione sul piano sottostrutturale della dicotomia controllo/conflitto che abbiamo visto agire dal punto di vista politico e di quella normale/anormale che abbiamo visto essere fondamentale per la comprensione dell’intero orizzonte della modernità.
Insomma, la modernità è l’epoca dell’avvenuto squilibrio tra la dimensione dell’individuo e la dimensione della comunità e il ruolo della psichiatria in questo contesto è assolutamente determinante, nella misura in cui da un lato definisce e “stabilizza” determinati stati individuali e dall’altro cerca di costruire ponti tra le tre dimensioni che abbiamo appena analizzato: sul piano strutturale, la psichiatria interviene dal lato dell’istituzione – del resto, la psichiatria nasce immediatamente come una scienza che ha a che vedere con la salute pubblica, il controllo e l’igiene; sul piano sovrastrutturale, si trova costretta a lavorare tra la tentazione biologista tipicamente moderna e la ricerca fenomenologico-esistenziale che è potuta sfociare, nei rappresentanti meno ortodossi della psichiatria inglese (come Laing e Cooper), nell’antipsichiatria; sul piano sottostrutturale, la psichiatria diviene chiave di lettura dell’umano e chiave interpretativa (sia in senso ortodosso sia in senso critico) di ciò che si definisce costruzione del Sé o processo di soggettivazione.
Insomma, se la domanda sulla psichiatria può essere costruita in questo senso, se essa sia una scienza dell’uomo nella sua totalità, complessità e storicità (laddove, comunque, bisogna intendersi su cosa sia uomo) o se si riveli, invece, come un dispositivo di potere la cui conflittualità si espone nell’intero corpo sociale e non soltanto sul versante dell’istituzione; la risposta – è chiaro – non può che essere soltanto “tentata”: l’idea di fondo che muove queste brevi riflessioni è che quando si parla di psichiatria in senso lato si finisce, in un modo o nell’altro, a parlare del “tutto” della modernità matura e quando si parla del “tutto” della modernità è chiaro che non si possa pretendere una “soluzione”, nel senso di uno “scioglimento”, della trama complessa della contemporaneità nella quale, ci piaccia o no, siamo ancora pienamente immersi.
- Scienza dell’uomo o dispositivo di potere? A mo’ di conclusione inconcludente
Per Ludwig Binswanger non c’è alcun dubbio, la psichiatria deve essere – e non può non essere – una scienza dell’uomo: «intendo indicare sin dall’inizio che il fondamento e il terreno su cui la psichiatria come scienza autonoma può radicarsi non è né l’anatomia e la fisiologia del cervello, né la biologia, né la psicologia, la caratteriologia e tipologia di genere, né ancora la scienza della “persona”, ma l’uomo»[27]. Il lavoro dello psichiatra, allora, è quello di partire dal presupposto che dinanzi a sé non ha un malato semplicemente-presente, una cosa da analizzare con atteggiamento disinteressato e sul quale applicare una determinata procedura, ma un uomo da comprendersi sul «fondo [Grund] della nostra comune sorte umana, sul fondo della condition humaine»[28] che permette che vi sia l’incontro e il confronto tra due modalità differenti di essere-nel-mondo. Il comune destino è quello, inteso in senso heideggeriano, dell’ek-sistere in quanto con-essere, cioè la precedenza dell’incontro e della «reciprocità d’amore e di amicizia con un “tu”»[29]. L’atteggiamento di Binswanger non nega l’importanza dell’accertamento psicopatologico, ma se lo psichiatra deve curare non può restare fermo a quella tipologia di accertamento ma deve mettere in gioco l’intera struttura esistenziale dell’esserci nella dimensione intersoggettiva della relazione e dell’ascolto: «chi sia da considerare come malato mentale lo decide la psicopatologia e la psichiatria clinica; ma in cosa il malato come uomo compreso a partire dall’essenza umana o dall’esserci umano, si distingua dall’uomo sano, questo solo l’analisi esistenziale può indicare e dire in un linguaggio adeguato all’esistenza umana»[30]. L’obiettivo teorico di Binswanger può essere letto anche in questi termini: il tentativo di strappare la dicotomia salute/malattia (normale/anormale) dal suo fondamento biologico e legarlo, invece, alla dimensione esistenziale di quell’ente particolare chiamato uomo. Si potrebbe dire che Binswanger pensi a partire dall’esistenza (l’ek-sistere) invece che a partire dalla vita (la forza selvaggia e tumultuante che da Darwin in poi ha determinato uno degli orizzonti di senso della modernità). Insomma, sembra che la psichiatria, per essere una scienza umana, debba abbandonare il paradigma a partire dal quale sarebbe nata e si sarebbe sviluppata, allontanare le seduzioni di una spiegazione scientifica o scientista e dedicarsi alla sua missione che consiste nel «comprendere e descrivere disturbi psichiatrici in primo luogo nella loro essenza propria, cioè come modificazioni della struttura dell’essere-nel-mondo»[31].
La psichiatria, dunque, non può che essere scienza dell’uomo nella misura in cui il suo unico oggetto possibile è l’uomo nella sua interezza e non la malattia come accadimento che colpisce un ente semplicemente-presente e cosificato. Su questo punto, sembra difficile non essere concordi; eppure, secondo Michel Foucault, la psichiatria rappresenta non soltanto un dispositivo di potere, ma il dispositivo di potere fondamentale per la comprensione della modernità. Sullo sfondo della costruzione della scienza psichiatrica si anniderebbero tutte le problematizzazioni connesse da un lato all’emergere e al consolidarsi dell’orizzonte di senso borghese e dall’altro alla definizione di una naturalizzazione dell’umano con la possibilità, sempre ritornante, di inferiorizzazioni sulla base di un principio o di un altro. Michel Foucault ha letto con attenzione Binswanger[32], ma il suo approccio ben presto si è spostato su un’altra posizione (che non prevede, comunque, la “negazione” dell’impostazione binswangeriana): l’anormale e la follia non sono tanto da analizzarsi in vista della definizione di un’autenticità umana, ma come forme di produzione sullo sfondo di mutate relazioni di potere e regimi discorsivi. Per Foucault la psichiatria si configura come un “potere” individuale (del medico) e sociale (della società) e rappresenta il modello privilegiato che assume la forma fondamentale di organizzazione del corpo sociale nella modernità matura: il potere di normalizzazione[33]. Da Comte a Foucault, la strada non è stata poi così lunga: Comte, spettatore del consolidamento definitivo del nuovo sistema borghese, delinea e determina la necessità, per essa, di dotarsi di una “strumentazione” scientifica per la gestione del corpo sociale – il principio Broussais e la dicotomia normale/anormale diventano quasi un “principio cosmico” (laddove “cosmo” è anche e soprattutto, secondo l’etimologia greca, “ordine”); Foucault, spettatore della crisi di una serie di sovrastrutture borghesi (il decennio degli anni ‘60 e i movimenti “anti”), ritrova l’intuizione comtiana all’interno dell’intera genealogia della modernità e la definisce in chiave critica e, soprattutto, la determina come il fondo (i tedeschi probabilmente direbbero Grund) a partire dal quale si sarebbe sviluppato l’intero orizzonte di senso moderno.
La psichiatria, allora, è un dispositivo di potere, non soltanto per la questione manicomiale (l’istituzione, per Foucault, viene concettualmente dopo) e la cosificazione dell’uomo malato/anormale, ma perché non poteva che svilupparsi in questa maniera; la dimensione politica della modernità, infatti, non sarebbe dominata soltanto dalla legge, che ha la sua forza nella costrizione e il suo significato nel prelievo, ma anche e soprattutto dalla norma, che ha la sua forza nella disciplina/sicurezza e il suo significato nella produzione. In parole povere, analizzare la modernità matura sotto la lente della norma (normale/normativo) significa affrontare i molteplici ambiti dell’umano da una prospettiva differente e soprattutto comprendere che il potere non reprime soltanto ma produce soprattutto, e produce soggettività e produce sistemi e produce regimi discorsivi. Quando Foucault analizza la genealogia della costruzione concettuale dell’“anormale”[34] ritrova tre elementi che sono andati a costruire quel confuso sfondo culturale mediante il quale noi oggi possiamo definire qualcuno “anormale”: il mostro umano con la sua dimensione di infrazione giuridica alla legge di natura; l’individuo da correggere con la sua dimensione di infrazione disciplinare e la sua contraddizione che si determina nel fatto che egli è allo stesso tempo “da correggere” e “incorreggibile”; il bambino masturbatore con la sua dimensione onnicomprensiva riguardante la natura della natura umana in quanto sessuale. Il normale e l’anormale sono concetti ambigui ma con potenza normativa nella misura in cui incrociano un modello giuridico, un modello morale (oggi si direbbe “comportamentale”) e un modello biologico-naturale. Fondamentale è quella che viene chiamata la “scoperta degli istinti” come ciò che può sempre “perturbare” il giusto andamento di un comportamento: «è l’importanza di un ingranaggio cominciando dal quale la nozione di istinto potrà apparire e formarsi, perché l’istinto sarà, evidentemente il grande vettore del problema dell’anomalia, se non proprio l’operatore attraverso il quale la mostruosità criminale e la semplice follia patologica troveranno il loro principio di coordinamento»[35]; è appunto attraverso la dimensione biologico-naturale dell’istinto che «la psichiatria del XIX secolo potrà ricondurre nell’ambito della malattia e della medicina mentale tutti i turbamenti, tutte le irregolarità, tutti i grandi turbamenti e tutte le piccole irregolarità di comportamento che non dipendono dalla follia propriamente detta […] con la nozione di istinto affiorerà un campo di problemi nuovi e, al contempo, si avrà la possibilità di reiscrivere la psichiatria non solo in un modello medico che essa aveva utilizzato da lungo tempo, ma anche in una problematica biologica. L’istinto dell’uomo è l’istinto dell’animale? L’istinto morboso dell’uomo è la ripetizione dell’istinto animale? L’istinto anormale dell’uomo è un riaffioramento di istinti arcaici dell’uomo?»[36].
Al di là della parzialità e dell’incompletezza di cui soffrono a volte alcune genealogie foucaultiane e della “surinterpretazione” di cui viene spesso accusato il filosofo francese, questa riflessione ci permette di tornare e di chiudere sulla questione della relazione tra norme naturali e norme sociali dal punto di vista di una confusione tra fatto e valore: il mostro richiama la dimensione giuridica, l’incorreggibile la dimensione politico-disciplinare, il masturbatore la dimensione sessuale e individuale – l’anormale o il malato mentale (l’oggetto della psichiatria) non può che mettere in discussione sia il piano della legge, sia il piano della norma, sia il piano della realizzazione individuale. La psichiatria è, in questo senso, scienza dell’uomo, nella misura in cui ne indaga tutte le possibili relazioni e realizzazioni, ed è scienza dell’uomo soltanto nella misura in cui rappresenta il dispositivo di sapere/potere che meglio racconta la confusione tra fatto e valore, tra dimensione metrica e valutativa, che si compie nell’umano, in quell’umano che è proprio della modernità matura.
[1] E. Borgna, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli, Milano 2006, p. 19.
[2] M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), tr. it. Feltrinelli, Milano 2010, p. 285.
[3] Cfr. L. Binswanger, La psichiatria come scienza dell’uomo (1957), tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2013.
[4] E. Borgna, Come se finisse il mondo, cit., p. 19.
[5] Ibid., p. 23.
[6] Il riferimento è ovviamente a G. Canguilhem, Il normale e il patologico (1966), tr. it. Einaudi, Torino 1998. In realtà l’epistemologo è tornato più volte sulla questione anche all’interno di saggi più brevi: cfr. G. Canguilhem, La conoscenza della vita (1952), tr. it. Il Mulino, Bologna 1976, nel quale si trovano alcuni scritti particolarmente importanti come Il normale e il patologico, pp. 219‐237, e La mostruosità e il portentoso, pp. 239‐255.
[7] Anche sulla questione della definizione di ciò che è malattia e ciò che è salute, dal punto di vista valoriale, Canguilhem è intervenuto spesso. Per approfondire, cfr. G. Canguilhem, Sulla medicina. Scritti 1955‐1989, tr. it. Einaudi, Torino 2007. Segnaliamo in particolar modo La salute: concetto volgare e questione filosofica del 1988, pp. 23-34, e Le malattie del 1989, pp. 13-21. Per un inquadramento generale di tutte le problematizzazioni connesse a questi scritti sulla medicina, ci permettiamo di rinviare D. Salottolo, Per una critica della ragion medica: alcune note a partire dagli scritti sulla medicina di Canguilhem, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 2, 2009, consultabile liberamente su www.scienzaefilosofia.it.
[8] Il riferimento è, in questo caso, alla grande intuizione di Michel Foucault che connette la “nuova” percezione della finitudine umana, legata all’avvento delle tre positività proprie della modernità matura, la vita, il linguaggio e il lavoro, alla nascita delle scienze umane e sociali all’interno di quella definizione dell’umano che si compie nel suo essere un “allotropo empirico-trascendentale”: cfr. M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (1966), tr. it. BUR, Milano 2004.
[9] G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit. pp. 49-50.
[10] Sulla questione del metodo in Claude Bernard (e nella medicina moderna) sempre in bilico tra meccanicismo scientista e vitalismo metafisico cfr. D. Salottolo, De-complessificazione della vita e “costruzione” del metodo tra condizioni fisico-chimiche e manifestazioni vitali. Alcune note sulla fisiologia di Claude Bernard, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 12, 2014, consultabile liberamente su www.scienzaefilosofia.it.
[11] Per quanto riguarda l’importanza della figura di Claude Bernard per la definizione di alcune contraddizioni fondative della medicina moderna, rinviamo all’introduzione della nostra traduzione ed edizione di alcuni scritti del medico francese: cfr. D. Salottolo, Claude Bernard e lo strano caso del suo “determinismo armoniosamente subordinato” in C. Bernard, Un determinismo armoniosamente subordinato. Epistemologia, fisiologia e definizione della vita, tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 7-41.
[12] Cfr. A. Comte, Système de politique positive (1851), in Œuvres d’Auguste Comte, Anthropos, Paris 1969, t. VII, pp. 612-619.
[13] É. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Alcan, Paris 1895, p. 93. La traduzione è nostra.
[14] Per un approfondimento sulla questione della definizione di “fatto sociale” in Durkheim e in connessione con le teorie del suo allievo, Marcel Mauss, cfr. S. G. Meštrovic, Durkheim’s concept of anomie considered as a ‘total’ social fact, in «The British Journal of Sociology», vol. 38, n. 4, 1987, pp. 567-583.
[15] Sulla questione della devianza si è particolarmente esercitata la sociologia di matrice anglosassone. Importante, in questo senso, è il libro di E. Goffman, Stigma. L’identità negata (1963), tr. it. Giuffrè Editore, Milano 1983, all’interno del quale si delinea come l’identità individuale possa essere plasmata dalle procedure di stigmatizzazione basate sulla relazione (culturale e non naturale) normale/anormale.
[16] Anche su questo punto è la sociologia anglosassone a restituire un importante e insuperato studio. Cfr. E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza (1961), tr. it. Einaudi, Torino 1968.
[17] Sulla questione epistemologica riguardante lo statuto della psichiatria, si permetta di rinviare a D. Salottolo, L’impasse epistemologica, le relazioni di potere e lo stigma. Alcuni appunti sulla storia della psichiatria, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 13, 2015, consultabile liberamente su www.scienzaefilosofia.it.
[18] M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1 (1976), tr. it. Feltrinelli, Milano 2003, pp. 122-123.
[19] Per un’analisi molto puntuale dell’origine e dell’utilizzazione del termine anomia nei vari scritti di Durkheim cfr. S. G. Meštrovic, H. M. Brown, Durkheim’s concept of anomie as dérèglement, in «Social Problems», vol. 33, n. 2, 1985, pp. 81-99.
[20] Cfr. E. Durkheim, La divisione del lavoro sociale (1893), tr. it. Edizioni di Comunità, Torino 1999.
[21] Cfr. Id., Il suicidio (1897), tr. it. BUR, Milano 2014.
[22] Ibid., p. 323.
[23] Cfr. M. Foucault, Il potere psichiatrico, cit., pp. 285-296.
[24] Sulla questione della relazione tra alienazione e anomia, seppur da una prospettiva differente rispetto alla nostra, cfr. A. Giddens, Capitalismo e teoria sociale. Marx, Durkheim, Weber (1971), tr. it. Il Saggiatore, Milano 2009, pp. 364-374.
[25] Cfr. G. Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito (1903), tr. it. Armando Editore, Roma 2007.
[26] Cfr. R. G. Laing, L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale (1955), tr. it. Einaudi, Torino 2001.
[27] L. Binswanger, La psichiatria come scienza dell’uomo, cit., p. 37.
[28] Ibid., p. 39
[29] Ibidem.
[30] Ibid., p. 41.
[31] Ibid., p. 45.
[32] Cfr. M. Foucault, Introduction, in L. Binswanger, Le rêve et l’Existence (1954) e La psychologie de 1850 à 1950 (1957), in Id., Dits et écrits, vol. I. 1954-1975, Gallimard, Paris 2001, rispettivamente pp. 93-147 e pp. 148-186.
[33] Cfr. M. Foucault, Il potere psichiatrico, cit.
[34] Cfr. Id., Gli anormali. Corso al Collège de France (1974‐1975), tr. it. Feltrinelli, Milano 2009, pp. 57‐78.
[35] Ibid., p. 122
[36] Ibid., pp. 122-123.