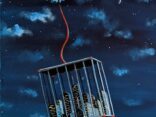Autore
Indice
- Materialismo gaudente
- Di medicina e altri saperi
- Ipotesi di ieri, ipotesi di oggi
S&F_n. 17_2017
Abstract
Physician-Philosopher La Mettrie: Materialisms, medical Knowledge, Science
In the notable season of the 18th century French materialism, the doctor-philosopher La Mettrie was at the cutting edge. His materialistic attitude could not be recollected with a systematic setting and his objective remained that of talking about the bonheur of the few. The privileged role that he gave to the medicine and his interest for the other sciences made him an interesting philosopher of the science of his time. Certain discussions were still too attached to the environment in which they were elaborated but instead other ones could be recollected to some “undying” problem of the science.
-
Materialismo gaudente -
Far risalire il segreto del materialismo settecentesco francese – nei suoi tratti comuni a più autori e nella versione di La Mettrie – esclusivamente a una questione gnoseologica significa tradirne lo spirito e ridurlo a pensiero di nicchia in ritardo sul suo stesso tempo. Da questo punto di vista, un grandissimo interprete come Cassirer, che, dalla sua ottica, ha ricostruito mirabilmente il secolo dei Lumi, ha potuto dire che il materialismo
com’è rappresentato per esempio dal «Système de la Nature» dell’Holbach e da «L’Homme Machine» del Lamettrie, non è che un fenomeno isolato, assolutamente privo di importanza tipica[1].
A mo’ di difesa, invece, Olivier Bloch ha sintetizzato così i tratti salienti del riduzionismo anti–materialista:
1/réduction de sa place et de son importance, elle–même permise par 2/ l’inclusion du matérialisme dans un cadre où sa position devient subordonnée, celui du problème de la connaissance, à l’égard duquel le matérialisme est classé comme une sous–espèce de traditions sensualistes et empiristes, inclusion et classement qui suppose à leur tour 3/ une distorsion de la disposition relative des auteurs et de leur insertion dans la chronologie[2].
Dipingere dunque il materialismo semplicemente come un momento poco importante dell’indagine filosofica riguardo al problema della conoscenza equivale a non coglierne l’obiettivo profondo e a disperderne l’interesse, anche se – sia concesso – in nessun caso, esso fu «fenomeno isolato, assolutamente degno di importanza tipica».
Nel caso di La Mettrie – e, en passant, parlare di “caso La Mettrie”, coglie il cuore del mistero che ha spesso regnato intorno al filosofo di Saint-Malo –, la sistematica mancanza di sistematicità non ha aiutato a far prendere sul serio la sua impostazione materialistica: egli talvolta dà l’impressione di non rileggersi neanche[3], e, in più, riempie i propri scritti di confutazioni a se medesimo (per sfuggire alla censura, ma anche a testimonianza di un pensiero estremamente fluido). Con Moravia potremmo dire che
La Mettrie non tollera alcuna reductio a questa o a quella scuola filosofica e sarà compreso appieno solo da chi sappia ripercorrere pazientemente (fuori dal mito della coerenza e del système) i tratti diversi del suo tutt’altro che lineare pensiero[4].
Urge allora segnalare un nodo di partenza fondamentale in tale mare magnum, dando la parola proprio al medico-filosofo e mostrando un’implicazione decisiva del suo materialismo:
Sapete perché ho ancora qualche stima per gli uomini? Perché li credo seriamente delle macchine. Se non fosse così, ne conosco pochi la cui compagnia sarebbe da stimarsi. Il materialismo è l’antidoto della misantropia[5].
La Mettrie è molto chiaro: antidoto alla misantropia. Il sapere materialista di La Mettrie non è un sapere neutrale. Esso non è sistematico, e non vuole esserlo. Preferisce perdere qualcosa in profondità, ma abbracciare tutto in ampiezza. Non c’è campo del vissuto umano che non lo riguardi: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Un sapere materialista deve poter fornire una regola di vita, dimostrare che la materia non è solo questione cosmica ma umana – e anche troppo umana, qualche volta[6]. Il suo spirito è antropologico, e il suo segreto è etico, come proprio Cassirer rileva:
Questo nocciolo [il nocciolo del materialismo] infatti, per quanto ciò possa sembrare paradossale a prima vista, non è afferrabile da parte della sola filosofia della natura, ma soltanto da parte dell’etica. Il materialismo, nella forma in cui si presenta nel secolo XVIII, in cui è motivato e difeso, non è semplice dogma fisico o metafisico: è invece un imperativo. Esso non vuole soltanto porre e convalidare una tesi circa la natura delle cose; ma ordina e vieta[7].
Ciò non implica necessariamente che non si discenda mai nei particolari della pura speculazione, e non si tenti di inserirsi in maniera acuta nei dibattiti scientifici o filosofici del tempo (scienza e filosofia, parole ancora quasi perfettamente congruenti all’epoca). Ma ogni richiamo, in fondo, rimane al cuore dell’uomo. Che si studino piante, “costruisca” animali-macchina, teorizzi sostanze che soggiacciono, cosa importa della materia se non arriva a dirci qualcosa di più su ciò che siamo e ciò che dobbiamo essere? L’equazione è allora ben presto fatta: Tutto è Materia, l’uomo è materia, allora l’uomo non è altro che carne che freme. Alla conoscenza ci si arriva parlando della materia che l’uomo è. Ciò che appare evidente è che lo stesso concetto di materia si presenta tutt’altro che univoco, e, talvolta, è semplicemente metafora di carne sofferente o gaudente, più che principio saldo.
Si bien que, en dépit de sa démarche résolument empiriste et expressément anti–métaphysicienne, La Mettrie a conscience que la choix du matérialisme est loin d’être satisfaisant, dans la mesure où, en fin d’analyse, le médecin–philosophe en est réduit à délaisser le langage du philosophe, et donc à recourir, à l’instar du poète, à l’usage métaphorique de la langue pour dire la nature de l’âme[8].
2. Di medicina e altri saperi
-
Che, in quel tempo, la Scienza fosse anche strumentale per la felicità, – elemento di una ricerca del bonheur che si articola in maniera più ampia – è difficile non notarlo. Se si vogliono ben capire i materialisti del ‘700, a ogni modo un gruppo molto meno coeso di ciò che si è creduto, allora, bisogna sempre tenere insieme due dimensioni uguali e diverse del pensiero, e la teoria della materia non può prescindere dallo spunto regolativo che lo studio teoretico offre alle prassi comportamentali del filosofo. Anche nelle ricerche meno vicine al campo dell’immediatamente utilizzabile, sembra sempre soggiacere una sensibilità attenta alla ricaduta che la ricerca potrà avere per l’ethos (singolo, o di massa). Spinoza, Cartesio[9], certo; macchine, materia, moto, meccanica, vitalità, fatalismo, ovviamente; ma se non posso legarvi il mio bonheur cosa importa?
E si badi: segreto etico, ma non per forza politico; La Mettrie, ad esempio, che ha in totale indifferenza la politica, si situa del tutto “al di qua” dell’impegno – in questo, grande assente del banchetto materialista. All’appello della politica, La Mettrie non risponde. Bonheur, carne, felicità: ma che siano di pochi e senza impegno. Il dover essere del medico-filosofo non prevede divulgazione e non ammette, per presa di posizione costitutiva, ardore politico. Si ha una possibilità di godimento, o una promessa dello stesso, ma a patto che rimanga affare di pochi e che ognuno costruisca da sé la propria dinamica di bonheur materiale, fluttuando, se necessario, anche tra speranze mancate e posterità ininfluenti[10]. Il suo è un materialismo monista posto da un forte Io-soggetto, che domina flussi di bonheur e riflussi di noia, ed è poco interessato alla condivisione altra o democratica dell’accesso al piacere. In breve, il materialismo è, sì, il farmaco all’odio, ma va tenuto segreto: «La Mettrie n’est pas un libérateur social du désir»[11].
Non ci si smuove dalla più classica delle doppie morali, dunque. D’altronde, non è a un sistema cui La Mettrie ambisce, ma, al più a una critica sistematica che segua l’ispirazione del furore che smuove il filosofo :
I concetti più importanti del suo pensiero (corpo, anima, materia, macchina, piacere, voluttà, felicità, necessità, rimorsi) non sono oggetto di una definizione precisa, né di un’analisi approfondita. La velocità del suo pensiero genera talvolta la precipitazione del discorso. Ma almeno leggendo i suoi libri si ascolta la voce del filosofo. Pensiero vivente[12].
Quello che conta è arrivare a postulare una vera e propria teoria unificata dell’uomo naturale.
La strada privilegiata per arrivarci? La medicina. La Mettrie è un convinto assertore del legame assoluto che vige tra Medicina e Verità. Un medico deve curare – essere un medico di frontiera, e non lo dico a caso, in quanto La Mettrie fu medico sul fronte – ma soprattutto deve lavorare ai nessi organici parte-tutto e teoria-prassi sottintesi alle proprie prescrizioni. Una teoria della medicina è una teoria dell’umano e degli statuti della verità. Ma cosa vuol dire che la medicina porta dritti alla verità? Ecco un tratto davvero caratteristico di La Mettrie. Per arrivare alle verità su natura e dintorni, dice, limitatevi a farvi medico[13]. Cosa vuol dire? In primis, che tra medicina e filosofia la relazione deve fondarsi su termini di complementarità ed equivalenza[14]. La medicina e la filosofia hanno un tratto fondamentale in comune: sono entrambe sottomesse alla Natura. In che modo? Perché entrambe devono basarsi sulla ricerca continua delle cause fenomeniche degli eventi: e dunque, con tutta evidenza, qui si nasconde anche un’altra equivalenza tra discipline, ossia quella tra fisica e filosofia. Non basta però la sola sperimentazione: è una giusta miscela quella che va cercata. Allo sperimentalismo empirico sul campo, bisogna affiancare comunque un’impostazione metodica che permetta di trarre conclusioni generali e non disperdersi nell’induzione.
Così come non tutti i filosofi sono dello stesso valore, così anche i medici hanno una loro precisa gerarchia di validità; i più degni di fiducia sono quelli più portati nella fisica e nella meccanica, perché tali conoscenze mostreranno loro come naturale l’abbandono del vetusto concetto di anima immateriale. Il medico è il più veritiero degli scienziati, oltre, ovviamente, a essere il più utile.
Non è allora solo un gioco di parole parlare di “medico filosofo” e di “filosofo medico”. Il primo, dopo anni di studio fisico-fisiologico-clinico, non può prescindere dal dare una dimensione teoretico-epistemologica alla sua disciplina, e non può quindi abdicare al tentativo di mettere insieme tutti i singoli casi della sua professione; non deve, dunque, rinunciare a una filosofia della medicina che evidenzi il rapporto tra singolarità e ricorsività, tra esperienza inesauribile e rimando all’Universale. Il “filosofo medico”, dal suo canto, è il pensatore che non si rifugia nell’alveo dello spiritualismo, ma si confronta con gli ultimi ritrovati del sapere operativo e si convince sempre più dell’essenziale unità psico-fisica dell’uomo; inoltre – e qui La Mettrie rimanda la sua ispirazione quasi agli albori della filosofia greca – cosa di più intimamente unitario vi è di medicina e filosofia in quanto discipline che nel loro statuto più intimo parlano e scrivono di morte? Il medico e il filosofo, da diverse prospettive ma con l’unitarietà che si va mostrando, sono i depositari del pensiero che vuole affrontare l’indicibile, sia esso la morte o una nuova inclinazione dell’umano:
Incominciamo dunque a vedere non ciò che è stato pensato ma ciò che occorre pensare per la tranquillità della vita[15].
Medicina e filosofia sono discipline che devono basare il loro statuto su un approccio empirico, ma senza lasciarsi fagocitare dal più cieco sperimentalismo, e non rinunciando a formulare ipotesi che trascendano le singolarità. Sono, ancora, discipline veritative a base dialogica, in cui l’indagine comporta rischi calcolati e continui capovolgimenti, in cui non si può prescindere dal più schietto dei rapporti con i pazienti da interrogare o con gli alleati nella ricerca. Strumenti e pensiero devono necessariamente allearsi per redigere la storia naturale dell’uomo e accennare a una prima timida natura storicizzata, seguita nelle sue diverse epoche[16].
La medicina o la filosofia: due modi di affermare la stessa Verità.
È in questo quadro che, forse, ha più senso inserire ogni discorso sul Materialismo di La Mettrie. Designato spesso tra le file dei metafisici, egli invece rifugge le generalizzazioni grossolane. Non rifiuta di rilanciare ad infinitum le proprie deduzioni, ma solo assicurandosi di farle posare su ben salde basi empiriche, e ricordando sempre che quello che si sta tentando è un gioco a diverso tasso di probabilità, in cui la deduzione sistematica è lecita esclusivamente alla fine del percorso e mai come dogma a priori. Certamente, vi è una reversibilità tra ipotesi e tesi, tra empiria e deduzione sintetica: ma la priorità deve metodicamente essere sempre assegnata al singolo evento sperimentato. In questo, un rappresentante del Materialismo spesso dipinto come rozzo – lui, ma anche il materialismo – si dimostra allineato con la scienza del suo tempo. Sia chiaro, anche il Materialismo è metafisica; ma quello che si rifiuta in primis non è la deduzione sistematica in sé, quanto l’arbitrio razionalista, la priorità temporale accordata all’ipotesi, e la riluttanza ad abbandonare le teorie generali che si rivelano semplicemente false con l’avanzare della sperimentazione – en passant, se la materia del ‘700 non ha più motivo di esistere nella scienza contemporanea, queste regole metodiche sono lontane dall’essere soltanto un ricordo.
In più, ciò che soggiace – come una sostanza – all’intero impianto lamettriano è il tentativo di portare alla luce una nuova sensibilità grazie al costante utilizzo dell’analogia, negando i salti ontologici.
Non si tratta di rendere gli uomini uguali alle macchine o di trasformare le macchine in umanoidi; né ne L’uomo pianta troviamo un tentativo di riduzionismo tra uomini e vegetali.
La Mettrie non intende affermare qui il meccanicismo cartesiano estendendolo agli uomini, bensì rimarcare che l’uomo, nella sua costituzione organica, obbedisce alle stesse leggi della materia sensibile cui sono sottoposti gli altri enti fisici in natura: si afferma l’unità materiale degli animali e dell’uomo, nel contesto di una dottrina generale organicistica (non meccanica) degli essere viventi[17].
Quello che conta è, allora, teorizzare una nuova sensibilità unitaria che attraversi il cosmo, che spieghi sia le strutture analoghe tra viventi sia le implacabili diversità. Parlare di una sola sostanza diversamente modificata non indica l’equivalenza di tutti gli organismi, l’appiattimento della differenza in una democrazia del creato scialba e poco realistica. Al contrario, proprio partendo dal punto fisso di una materia unica, si potrà meglio apprezzare la straordinaria diversità nella continuità dell’universo. Vi è una sola sostanza, sì, ma essa si modifica; in più, il principio della sensibilità della materia garantisce le diversità tra gli organismi, e salva anche le sfere più alte dello spirito umano[18].
Tali funzioni complesse, infatti, derivano direttamente dai bisogni:
Più un corpo organizzato prova dei bisogni, più la natura gli ha dato i mezzi per soddisfarli. Questi mezzi sono i diversi gradi di quella sagacia ch’è nota sotto il nome di istinto negli animali e di anima nel’uomo. Meno necessità ha un corpo organizzato, meno è difficile da nutrire e da allevare, e più la sua porzione di intelligenza è modesta. Gli esseri privi di bisogni sono altresì privi di intelligenza: ecco l’ultima legge che deriva dalle prime due[19].
Nella valigia del medico, quindi, entrano sensibilità della materia, analogia, e sostanza unica. Ma non di sola pratica medica – teorica o “clinica” (rigorosamente tra virgolette dato i tempi) – si vive. Alla conoscenza si può arrivare per vie traverse, oltre alla privilegiata medicina; si deve scrutare nei meandri della botanica, negli archivi della zoologia e negli ingranaggi della meccanica, e tentare poi l’ipotesi che unisca i fenomeni in un’immensa scala naturae, anche oscillando non univocamente tra termini come meccanicismo, vitalismo, determinismo, sensismo – e anzi, una ricerca sulle differenti sfere d’influenza di tali concetti nel pensiero di La Mettrie può solo prendere atto del labirintico e strumentale uso che di essi vien fatto.
3. Ipotesi di ieri, ipotesi di sempre
-
Un’epoca di grande fermento ha l’obbligo di lanciarsi in previsioni, attraverso i suoi alfieri: sta poi al giudizio storico valutarne l’importanza e soppesarne con riconoscenza il giudizio. Davanti alle ipotesi scientifiche di Julien Offray de La Mettrie, oggi, si può sorridere, provare stupore o semplicemente metterle in prospettiva. Col senno del poi, alcune delle sue ipotesi particolari sono del tutto risibili per la scienza contemporanea; non per questo, però, uno sguardo olistico su di un momento di vorticoso ardire intelletuale come il ‘700 francese può prescinderne. La previsione è la forma più gratuita di errore, certo, ma, durante il Secolo dei Lumi, essa assume un ruolo addirittura più fecondo di molte certezze positive. Le sudate carte – le impegnative ricerche “sul campo” – possono, talvolta, essere abbandonate per i leggiadri studi – ossia i tentativi di teorizzare, se non mondi possibili, modi impensati di abitare quel mondo. Troviamo nelle opere di La Mettrie, quindi, diversi tentativi di anticipare i tempi della scienza e potenti sforzi per cogliere con l’intuito qualcosa di là dell’impegno quotidiano dei “manovali della scienza” – definizione del medico-filosofo che torna anche in Diderot.
Certo, La Mettrie, se in alcuni di questi aspetti – ipotesi olistiche degne solo se successive all’esaurirsi della ricerca empirica; disprezzo per i Sistemi; importanza della scienza; interesse per il problema educativo – è quasi un illuminista, si distacca dai contemporanei, evidenziando così un ritardo sul suo stesso tempo abbastanza sorprendente, sul ruolo della divulgazione, vista come un inutile quisquilia, inessenziale alla scienza, che è di pochi e di pochi deve rimanere.
Tornando alle previsioni, un esempio di questi tentativi anticipatori che tanto affascinavano il medico-filosofo può essere questo:
Perché dunque l’educazione delle scimmie dovrebbe essere impossibile? Perché, dopotutto, a forza di applicazione non potrebbe imitare i movimenti necessari per articolare parole, secondo l’esempio dei sordi[20]?
Ipotesi lontane, perché «per la natura non c’è nulla di bizzarro»[21]
Perché vi domando, o anti–epicurei moderni, perché la terra, questa comune madre e nutrice di tutti i corpi, avrebbe rifiutato ai grani animali ciò che accorda alle piante più vili e più perniciose? Tali grani si trovano sempre nelle sue viscere feconde; e questa matrice non ha in fondo nulla di più singolare di quella della donna. Ma la terra non è più la culla dell’umanità. Non la vediamo più produrre degli uomini! No, non rimproveriamole la sua attuale sterilità: sotto quest’aspetto essa ha dato quel che doveva dare. Come una vecchia gallina non fa più uova, così una vecchia donna non fa più bambini. Questa è all’incirca la risposta che Lucrezio ha dato a tale obiezione[22].
e intuizioni feconde:
Le prime generazioni debbono essere state assai imperfette. In un caso sarà mancato l’esofago, in un altro lo stomaco; qui la vulva, là gli intestini, ecc. È evidente che i soli animali in grado di vivere, di conservarsi e di perpetuare la loro specie saranno stati quelli trovatisi in possesso di tutte le parti necessarie alla generazione, e ai quali insomma non sia mancata qualche parte essenziale. Viceversa. Gli animali risultati privi di qualche parte assolutamente necessaria saranno morti o poco tempo dopo la loro nascita, o almeno senza potersi riprodurre. Come per l’arte, così anche per la natura la perfezione non è stata l’opera di un giorno[23].
Se lo scopo è corteggiare un’ipotesi, pensarne sviluppi lontanissimi, la posta in gioco merita una giocata coraggiosa e rischiosa. Unica regola immanente del gioco: evitare di chiudere tutto in un sistema, il quale è sempre poco fecondo, paralizzante per lo spirito, comodo solo per chi ama le certezze e non la sfida intellettuale progressiva. Il pericolo del Sistema è sempre vivo: bisogna continuamente ricordare che esso ha dignità solo come collana di ipotesi, utile se tiene insieme conoscenze acquisite “sul campo” ma devastante per la ricerca scientifica se postulato in maniera dogmatica.
Tanti sono i filosofi i quali hanno sostenuto l’opinione di Epicuro, che ho osato mescolare la mia debole voce alla loro. Del resto anch’io come loro non ho elaborato che un sistema; il che ci mostra in quale abisso ci si getta quando, volendo attraversare la notte dei tempi, si vuole portare il proprio sguardo presuntuoso su ciò che non offre ad esso alcuna presa. Ammettete la creazione o rifiutatela: qualsiasi tesi è parimenti misteriosa e parimenti incomprensibile[24].
Schermandosi sempre dal pericolo di divenire sistematico suo malgrado, deriva che talvolta gli appare come inevitabile, La Mettrie si ferma, infine, al di qua dell’interrogativo radicale che tramuta ogni indagine filosofica in una scommessa religiosa - la creazione -, e si rifiuta coerentemente di continuare.
Un’ultima domanda, allora. Delle posizioni scientifiche di La Mettrie, oggi, cosa rimane? Al netto di ogni distanza storica, non poco. Dall’atteggiamento dell’ultimo passo citato, e da molteplici spunti disseminati in altri significativi pensieri lamettriani, si possono trarre degli elementi per una scienza trans–storica, che trascenda gli interessi momentanei di La Mettrie – simpatie e rivalità tra scienziati, nomenclature datate e impostazioni contingenti – e si colleghi all’indagine scientifica di sempre. Se, infatti, del dibattito del suo tempo ci arrivano echi lontani – nomi noti o protagonisti sbiaditi e ormai quasi imperscrutabili: il maestro Boerhavve, il poco stimato Haller (cui dedica beffardamente L’uomo macchina), La Peyronie, Malpighi, Tralles, Cowper, Sténon, Harvey, Boyle, Trembley – alcuni elementi del suo pensiero inseriscono a buon diritto La Mettrie tra i più fruttuosi filosofi della sua epoca e tra i più vicini alla contemporaneità. Senza dubbio, già solo con l’Uomo macchina La Mettrie si è posto tra gli ispiratori di dibattiti vivissimi che talvolta appaiono ancora quasi fanta-scientifici; in più, a ben vedere, anche altre sue “fughe intellettuali” appaiono feconde tutt’oggi, e rivalutano da sole l’opera e la solidità del pensiero del medico-filosofo. La Mettrie manifesta un’apertura fiduciosa verso l’ignoto e un interesse olistico per il più grande spettacolo della terra, l’uomo, ma al contempo rifiuta di qualificare come scientifiche le ipotesi che possono essere, tutt’al più, considerate alla stregua di suggestioni o di avventure dell’intelletto. Egli non chiude in un sistema la dialettica tra il caso e la necessità all’interno di quell’orologiaio cieco[25] che è la natura, ma evidenzia la questione in maniera esemplare e viva. La Mettrie ha probabilmente lasciato più interrogativi aperti che risposte, ma questo, lungi dall’essere un difetto, lo rende un filosofo speciale, entusiasta anche quando superficiale: come alcuni suoi contemporanei, egli non elimina le difficoltà, bensì le moltiplica con ardore, e non rifugge dal problema per eccellenza di una teoria non spiritualista dell’umano, ossia quello del sopraggiungere della coscienza nella materia.
-
[1] E. Cassirer, La filosofia dell’illuminismo (1932), tr. it. La Nuova Italia, Firenze 1973, p. 87.
[2] O. Bloch, Oublier le matérialisme (1979), in Matière à histoires, Vrin, Paris 1997, p. 351.
[3] M. Onfray, Illuminismo estremo. Controstoria della filosofia IV (2007), Salani Editore, Milano 2010, p. 93.
[4] S. Moravia, Introduzione a J. O. de La Mettrie, Opere filosofiche, a cura di S. Moravia, Laterza, Bari 1978, p. XLVIII.
[5] J. O. de La Mettrie, Sistema di Epicuro (1751), in Opere filosofiche, cit., p. 278, corsivo mio.
[6] Per la fama “diabolica” di La Mettrie, spregiato sia di materialisti sia dai rivali, si veda F. A. Lange, Storia del materialismo e critica del suo significato nel presente. Vol I: Storia del materialismo fino a Kant (1873–1875), a cura di Luca Gigante, Edizioni Immanenza, Napoli 2015, pp. 314–316. Per converso, una delle poche “recensioni” positive che La Mettrie ha ricevuto, ossia quella del Marchese de Sade, non ha certo contribuito alla sua ricezione; per tale rapporto, si veda P. Amodio, Complicazioni erotiche della volontà di sapere. Libido sciendi e scientia libidinandi nell’età dei libertini, Giannini Editore, Napoli 2014, pp. 95–101.
[7] E. Cassirer, op. cit., p. 105.
[8] J. Richard, Médecine, physique et métaphysique dans les œuvres philosophiques de La Mettrie in S. Audière, J. C. Bourdin, J. M. Lardic, F. Markovits, Y. C. Zarka (a cura di), Matérialistes français du XVIIIe siècle. La Mettrie, Helvétius, d’Holbach, PUF, Paris 2005, p. 43.
[9] Sui rapporti tra La Mettrie e Cartesio si veda G. Mensching, L’esprit dans l’oeuvre de La Mettrie, ibid.
[10] Sul ruolo della gloria postuma nella costruzione del bonheur materialista, si veda: J. O. de La Mettrie, Antiseneca, in Opere complete, cit., p. 341.
[11] C. Wolfe, La réduction médicale de la morale chez La Mettrie, in S. Audière, J. C. Bourdin, J. M. Lardic, F. Markovits, Y. C. Zarka (a cura di), op. cit., p. 59.
[12] M. Onfray, op. cit., p. 90.
[13] J. O. de La Mettrie, Discorso preliminare (1751), in Opere complete, cit., p. 4.
[14] J. Richard, op. cit., p. 28.
[15] J. O. de La Mettrie, L’uomo macchina (1747), a cura di Fabio Polidori, Mimesis edizioni, Milano–Udine, 2015, p. 32.
[16] F. Markovitz, La Mettrie et le thème de l’histoire naturelle de l’homme, in S. Audière, J.C. Bourdin, J.M. Lardic, F. Markovits, Y. C. Zarka (a cura di), op. cit.
[17] P. Quintili, Julien Offray de La Mettrie (1709–1751). Il piacere, la libertà, la critica: L’arte di godere, in J. O. de La Mettrie, Denis Diderot, L’arte di godere. Testi dei filosofi libertini del XVIII secolo, a cura di P. Quintili, Manifesto libri, Roma 2006, pp. 108–109.
[18] F. A. Lange, op. cit., p. 321.
[19] J. O. de La Mettrie, L’uomo pianta (1748), in Opere, cit., p. 247.
[20] Id., L’uomo macchina, cit., p. 39.
[21] Id., Antiseneca, cit., p. 306.
[22] Id., Sistema di Epicuro, cit., pp. 262–263.
[23] Ibid., pp. 263–264.
[24] Ibid., p. 276.
[25] Il caso e la necessità, L’orologiaio cieco, Il più grande spettacolo della terra sono titoli ormai classici della letteratura scientifica contemporanea. Citare essi significa segnalare – tra gli innumerevoli esempi possibili – alcuni elementi del dibattito odierno che presentano tracce anche prettamente settecentesche. Oltre all’opera di Jacques Monod, i due titoli di Richard Dawkins non sono un caso: il biologo inglese è uno degli alfieri contemporanei dell’ateismo e di un certo materialismo, ed è stato talvolta designato – al pari del filosofo Michel Onfray – come un “D’Holbach redivivo”. Per alcuni spunti, si veda A. Sandrier, D’Holbach redivivus (II): l’athéisme de Richard Dawkins, in Les Dossiers du Grihl, mis en ligne le 07 novembre 2009, http://dossiersgrihl.revues.org/3664.