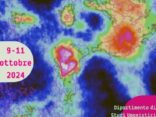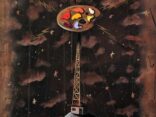Autore
Indice
- Introduzione Mitologie e Simple Narratives
- Social Frame, Tecnosfera e Generazioni Future
- Nel Segno Della Carne: Semiotica Alimentare e sostenibilità
↓ download pdf
S&F_n. 30_2030
Abstract
New patways for a sustainable future
The report discusses a number of key issues addressed during the international conference New pathways for a sustainable future: science and ethics for a renewed society, held at the University of Turin on 20 November 2023. The conference is part of the international project rganized by the Unita consortium, with the collaboration of leading national and international academics and research centres
- Introduzione
Il 20 Novembre 2023 ha avuto luogo, presso l’aula Gallino dell’Università degli Studi di Torino, la Conferenza “New Pathway for a Sustainable Future: Science and Ethics for a Renewed Society”.
L’incontro è stato scandito da quattro panel che, seppur formalmente suddivisi, hanno esposto una circolarità critico-problematica di questioni interconnesse: a) Democracy, New Technologies and Future Generetions; b) Green Industry and Human Values; c) Agri-food, sustainability and adaptation; d) Cellular Agriculture.
Il presente report, lungi dal poter restituire la complessità delle relazioni di cui è andata componendosi la conferenza, si occuperà di tratteggiare alcuni punti di contatto tra i contributi offerti dai relatori, con l’obiettivo di far emergere la fertilità e l’urgenza storica delle tematiche trattate e dibattute.
Non a caso, i concetti di fertilità, ovvero la capacità di riproduzione propria di un organismo vivente, e di urgenza storica, nel senso di una necessità impellente richiesta da una specifica condizione spazio-temporale, circoscrivono il nucleo problematico intorno al quale hanno orbitato i diciannove interventi. Un nucleo problematico inerente alla contemporanea crisi esistenziale dell’umano che, non concernendo esclusivamente le questioni etiche riguardanti la riproduzione della specie umana in un ambiente-mondo consegnato inesorabilmente ad una condizione di invivibilità ecologica, risulta, in ultima analisi, fondata su una ideologica e nociva interpretazione dell’umano in quanto mero consumatore d’energia.
Non a caso, i quattro panel che hanno composto la Conferenza (Democrazia, nuove tecnologie e generazioni future; Green Industry e valori umani; Agri-food, sostenibilità e adattamento, Agricoltura cellulare) riportano, nei propri titoli, delle cornici di questioni che, nel loro limitare uno specifico campo d’indagine, al contempo, pongono dei punti di contatto da dover investigare per esaminare lo sviluppo di un futuro sostenibile per la specie Sapiens: Come interpretare il rapporto tra lo sviluppo delle nuove tecnologie e il sistema di governo democratico? Che ruolo assume la sfera economica nella decisione etica circa il valore da affermare nelle società del XXI secolo? Fino a che punto sarà sostenibile l’attuale sistema produttivo antropico? In altre parole, il futuro verso il quale si sta proiettando l’umano sarà sostenibile per la propria persistenza? Sarà possibile trascendere l’attuale sistema economico-produttivo per garantire una circolarità ecologica tra umano, natura e macchine?
Tali questioni hanno composto l’ossatura di un incontro che si è mosso, sin dalla sua genesi progettuale, in direzione di uno stretto confronto tra diversi settori scientifico-disciplinari che hanno richiesto (e richiedono) sempre più punti di contatto e confronto con limitrofe sfere del sapere.
A questo proposito vale la pensa sottolineare che il Dott. Luca Lo Sapio, in quanto organizzatore della Conferenza, anche sulla scia del format inaugurato dalla Task Force di Ateneo della Federico II di Napoli Human&Future (di cui lo stesso Lo Sapio è membro), ha dimostrato empiricamente, attraverso un incontro composto da diciannove relatori, la necessità scientifica che, oggigiorno più che mai, richiede il confronto diretto tra diversi ambiti disciplinari in vista di una comprensione dell’umano presente e futuro.
Difatti, il titolo della Conferenza permette di condensare un punto d’approdo comune tra gli interventi, ovvero la necessità di costruire un nuovo modello di persistenza antropica che ponga al centro la sostenibilità energetica e ambientale. Tuttavia, tale rinnovamento, per essere attuato, richiede una messa in causa della società nel suo insieme o, meglio, della rappresentazione fondativa con cui viene interpretato il presente rapporto tra natura e artificio, umano e macchina, energia e sistema produttivo, alimentazione e consumo.
- Mitologie e simple narratives
Proprio a partire da tali dualità, o meglio, dalla messa in causa di determinate rappresentazioni con cui interpretare i fenomeni, è possibile citare l’intervento del Professor Piergiorgio Donatelli.
La relazione di Donatelli si è occupata di problematizzare, dal punto di vista sociologico, lo statuto etico dell’Intelligenza Artificiale. Secondo Donatelli, l’IA è a tutti gli effetti una infrastruttura sociale che, seppur dotata di un’autonomia decisionale, viene venduta e rappresentata come prodotto a disposizione dell’utente.
Tale rappresentazione o, meglio, per usare un’espressione di Donatelli, mitologizzazione del prodotto, trova la propria costituzione e diramazione nella Weltanschauung neoliberale che, astraendo il fenomeno dell’IA dalla propria cornice storico-politica, ne oscura e neutralizza l’aspetto decisivo: la ritrascrittura ontologica e relazionale della società.
Ed è su questa possibile esclusione dell’utente-cittadino da un approccio critico all’intelligenza artificiale che risultano annidate diverse questioni etico-politiche inerenti all’autonomous agency degli algoritmi, la sfiducia nelle capacità umane nel poter gestire lo sviluppo tecnologico, il ruolo della politica e del diritto circa l’anomico e opaco operato delle aziende Big Tech, la polarizzazione del dibattito sul tema della tecnica come male e della natura come bene.
A partire da tale quadro problematico, Donatelli sostiene che c’è bisogno di una nuova picture, una nuova immagine per rappresentare le interconnesse problematiche circa l’IA e slatentizzare il ruolo delle ICT in quanto infrastruttura sociale.
Una nuova picture che, a partire dal pianto etico-sociologico, non possa essere ricondotta e risolta nella fascinazione del discorso mitologico promosso dal marketing delle Big Tech e che possa svelare l’intima relazione tra prodotto digitale e consumatore-utente nell’attuale infantilizzazione del corpo politico in un’inedita transizione d’esistenza antropica.
L’intervento di Donatelli, mettendo in crisi una determinata modalità di rappresentazione e interpretazione di fenomeni, permette di contrassegnare un’epoca di transizione che, richiamando l’intervento del Dott. Steven Umbrello, resiste o, meglio, non è criticamente risolvibile nelle riduzioni delle simple narratives ascrivibili al technology determinsm e al design instrumentalism attraverso cui le aziende, secondo Umbrello, possono de-responsabilizzarsi circa le ricadute etiche e sociopolitiche dello sviluppo delle nuove tecnologie di IA. L’engineering ethics proposta da Umbrello, difatti, è costruita a partire da una interactional perspective tra umano e macchina entro cui la decisione etica deve esser già presa nella fase di design e di programmazione dell’IA.
Questo passaggio, nell’intersezione tra etica e design, investigando il sempre più intimo rapporto tra uomo-macchina e utente-ambiente, permette di ricostruire la circolarità dei temi di cui è andata componendosi la conferenza.
- Social Frame, Tecnosfera e Generazioni Future
Una circolarità incentrata sulla possibile transizione dell’odierno social frame in vista di un circuito virtuoso tra sostenibilità energetica, sviluppo di biotecnologie e consumo alimentare a ridotto impatto ambientale.
A tal proposito, richiamando il problema della rappresentazione entro cui andrebbero esaminati i fenomeni, il Professor Dario Padovan ha sostenuto la necessità di una narrazione critica che possa porsi come alternativa alla narrazione tecnocentrica che, secondo Padovan, si fonda su una visione magica dei sistemi tecnici in quanto panacea di tutti i mali, primo fra tutti quello dell’odierno cambiamento climatico.
La posizione sostenuta da Padovan, in tale ottica, mira ad una trasformazione culturale, sociale, politica dell’umano e della tecnosfera, ovvero, ad una rimodulazione del rapporto tra natura e società che ponga come primi obiettivi etici la risoluzione della disuguaglianza sociale e della corruzione morale sistemica causata dalla mitologia della tecnica.
Parallelamente alla questione della sostenibilità della tecnosfera trattata da Padovan, inoltre, è possibile trovare punti di continuità tra la relazione del Professor Antonio Marzocchella nell’esaminare la possibilità dell’utilizzo del butanolo come biocarburante sostitutivo per le macchine; l’intervento del Professor Antonello Astarita nel ricostruire la storia del manifacturing evidenziando i benefit eco-ambientali nelle possibilità di sviluppo della green manifacturing; la tesi del ruralismo debole[1] sostenuta dal Dott. Matteo Cresti rispetto alle problematiche inerenti all’etica dell’agricoltura e la proposta del Professor Marco Tamborini di riflettere filosoficamente sulle cosiddette tecnologie bio-ispirate, che promettono soluzioni tecnologiche eco-compatibili e forieri di processi environment friendly.
All’interno di questo circuito critico-problematico sul tema della sostenibilità energetico-alimentare e ambientale risultano collocabili gli interventi inerenti alle prospettive esistenziali delle presenti e future generazioni.
Ad esempio, l’intervento della Professoressa Tiziana Andina ha sostenuto l’ipotesi di una riorganizzazione ontologica della società in vista di un’azione transgenerazionale che, facendo perno sul concetto di chain of generations, permetta una sostenibilità ambientale ed economico-sociale per le generazioni future.
O ancora, gli interventi del Dott. Luca Stroppa e della Dott.ssa Petronella Randell hanno esaminato il rischio della messa al mondo di nuove vite nella cornice esistenziale del climate change, in particolare, attraverso il confronto tra una ethics of risk imposition e una prospettiva di axiological strong longtermism.
- Nel segno della carne: la semiotica alimentare
Infine, la chiusura del cerchio di cui è andata componendosi la Conferenza, nell’intersezione tra sviluppo di biotecnologie, sostenibilità ambientale e consumo energetico, ha riguardato il tema della carne coltivata e delle proteine alternative esaminato dal prof. Alessandro Bertero e dalla Dott.ssa Seren Kell, della biosemiotica sviluppata dal Dott. Francesco Buscemi e dalla Professoressa Simona Stano, dell’etica dell’imitazione riguardante le meat alternatives elaborata dal Professor Fabio Bacchini e della psicologia del consumatore analizzata dalla Professoressa Barbara Loera, e, con particolare riferimento all’entomofagia, dalla Dott.ssa Valentino Merlino e dalla Professoressa Alessandra Jacomuzzi.
Quest’ultima sezione di interventi, esaminando il sottile rapporto che intercorre tra l’impatto ambientale derivante dal consumo della carne e l’ideologia alimentare su cui si fonda lo stretto rapporto tra consumatore e carne, permette di restituire la questione cardine della Conferenza, ovvero, la messa in causa dell’attuale immaginario sociale che, nella propria circolarità viziosa e insostenibile dal punto di vista ecologico, affonda le proprie trame costitutive in una mitologia del consumo su cui è fondata non solo l’immagine dell’umano e il proprio principio d’individuazione ma, soprattutto, una naturalizzazione dello stato vigente. Uno stato vigente che, se non criticamente decostruito dal punto di vista logico-filosofico ed etico-scientifico, non permetterà il rinnovamento della società umana necessario a rendere sostenibile il futuro di Sapiens.
In chiusura, quindi, riprendendo l’interpretazione biosemiotica secondo cui il rapporto tra consumatore e carne non riguarderebbe esclusivamente una questione di fabbisogno energetico dell’umano ma un bisogno di soddisfare socialmente una storica e specifica richiesta di significazione, è possibile ripercorrere l’intelaiatura dei diciannove interventi nel loro mettere in causa le mitologie e le simple narratives tipiche dell’attuale dibattito sul rapporto tra umano-tecnica-natura e la necessità di riformulare l’odierno Social Frame in vista di una circolarità virtuosa tra tecnosfera e ambiente. Una circolarità virtuosa che permetta alle generazioni future una condizione d’esistenza eticamente accettabile ma, soprattutto, ecologicamente sostenibile attraverso una riformulazione del rapporto tra natura, umano e macchine.
[1] L’espressione allude alla possibilità di prendere le distanze da forme di ripiegamento tradizionaliste tipiche del ruralismo forte, à la Wendell Berry, riconoscendo, nel contempo, l’importanza della conservazione di specifici modelli di vita, portatori di valori ritenuti moralmente apprezzabili.