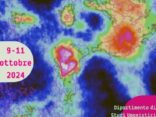Autore
- La Terra e il Globo
- Una Terra senza luoghi
- Sinbad e Moby Dick
- Improbabili paesaggi cosmici
↓ download pdf
S&F_n. 32_2024
Abstract
The Melancholy of the Earth: Crisis of Representation and Illusions of Immediacy
The article begins with the idea that we have now reached the end of the modern regime of representation, but this does not signify either the advent of the era of simulacra or the arrival in a paradise of happy immediacy; the contemporary hybrid space — simultaneously unrepresentable and to be consumed — does not allow for easy enthusiasm. Not preceded by any representation, the world presents itself in tragic or evanescent forms, which further pertain to the surface, and unexpectedly reintroduces boundary logics and sovereign geometries that many had too hastily deemed no longer plausible.
- La Terra e il Globo
In un passaggio oramai noto de Il nomos della terra, Carl Schmitt ci tiene a puntualizzare come il concetto di Occidente – veicolato dalle amministrazioni statunitensi a partire dalla formulazione della Dottrina Monroe del 1823 – sia un’espressione sostanzialmente e polemicamente antieuropea e, proprio per questo motivo, di conseguenza, né puramente geografica e neutrale né in grado di dare vita a un autentico ordine globale, perché intrinsecamente ambigua e pericolosamente liquida[1]. In aggiunta, il giurista di Plettenberg ricorda come lo stesso concetto di Occidente – che gli Usa rivendicano quale proprio locus o sfera politico-spaziale –, non può in verità avere la medesima ratio e la medesima forza del concetto geografico di Polo, che rappresenta invece un terminus intrinsecamente localizzante e spazialmente inequivocabile, perché «abbiamo un Polo Nord e un Polo Sud, ma non un Polo Est e un Polo Ovest della terra»[2]. In questo modo l’Alaska e la Nuova Zelanda, l’Islanda, la Groenlandia e le Hawaii sono sempre Occidente, tutte allo stesso titolo.
Al di là dell’aspetto ideologico che pesa dietro questo tipo di contrapposizione Occidente/Europa, e al di là dei suoi utilizzi politici, ritengo che questa riflessione rappresenti – sebbene per Schmitt non si sia data in questi termini – il momento in cui emerge, al livello del pensiero, la diversità radicale che insiste tra il concetto di Terra e quello di Globo – termini antitetici – il cui uso simultaneo è uno dei segni della crisi dell’epoca moderna e del suo spazio. Ci troviamo infatti di fronte all’ambiguità di non sapere se parliamo della Terra – e dunque siamo ancora in un regime moderno della rappresentazione piana – o parliamo del globo, e allora siamo al di là di tale paradigma. Ragionare nei termini di Occidente significa richiamarsi a una sfera occidentale quale posizione stabile e riconoscibile su una mappa classica che ha l’Europa al centro e, rispettivamente, il continente asiatico a oriente e quello americano a occidente; allora dietro il concetto di Occidente così inteso si cela un logos cartografico, propriamente moderno, pienamente all’opera nella lettura che Hegel fa del cammino dello Spirito – che segue una traiettoria spaziale fissata su una mappa – e che va come il sole da est verso ovest, in un movimento orizzontale, ignorando l’Africa[3]. La questione è che, allo stesso tempo – e in modo più o meno confuso –, il concetto di emisfero occidentale presenta anche una logica che non è ascrivibile al dominio cartografico, ma si situa oltre esso. Se si ragiona infatti secondo una logica che sostituisce il globo alla terra – cioè non secondo la riduzione cartografica del mondo – l’Occidente non può più essere un punto preciso chiaramente localizzabile, ma diviene una frontiera liquida che si sposta così come ruota l’astro sul quale viviamo: diviene cioè questione ideologica valida universalmente, in assenza di pertinenze spaziali.
Cosa significa infatti Occidente se ci si orienta secondo una logica del globo e non della carta? Che prima o poi si finisce a “oriente” per poi ritornare nuovamente al punto di partenza. La rotondità della sfera terraquea presenta infatti il fenomeno secondo cui allontanarsi da un punto significa allo stesso tempo avvicinarsi a esso, per cui, letteralmente, si fa il giro. Detto in altri termini, l’espressione Occidente contiene in sé la contraddizione di essere sostanzialmente pensata dentro uno sguardo cartografico, ma effettivamente operante secondo una logica globale e circolare. È concetto gemello alla merce: è prodotta in un luogo ma circola sulla superficie liscia e curva della sfera in ogni direzione. In questo senso si potrebbe dire, più o meno schmittianamente, che tale concetto non ordina perché è intrinsecamente ambiguo e de-spazializzato, perché non si è deciso in quale senso lo si utilizza, e dunque può pericolosamente funzionare in ogni modo: può essere espansivo e contenitivo, identitario e universalistico. Diviene in questo modo, piuttosto, un concetto polemico ad altissima intensità performativa: tutti possono in via potenziale divenire Occidente ben al di là della posizione che una regione occupa sulla mappa. Ancora di più, per qualche anno dopo la caduta dell’impero sovietico tutto il globo è stato virtualmente pensato come Occidente, e sarebbe stata solo una questione di tempo per permettere l’inevitabile allineamento di tutti al modello liberale e democratico[4]. In questo modo tale espressione assume una curvatura semantica per cui non si è più di fronte alle Abendlandes di cui scriveva Oswald Spengler, ma a qualcosa che indica allo stesso tempo una zona su una carta geografica che però pensa se stessa come punto a partire dal quale proiettare un’azione globale che arriva dovunque per tornare su se stessa.
Il discorso che qui voglio condurre non è però legato alla questione relativa a cosa sia l’Occidente, ma è far notare come l’emergere di tale concetto significa un cortocircuito generale della moderna razionalità politica e dunque dei suoi spazi, per il fatto che tale termine si presenta quale mostro ancipite appartenente a due ordini semantici che rispondono a logiche del tutto differenti: il globo e la Terra, la rotondità e il piano, che ambiguamente e contraddittoriamente coesistono
- Una Terra senza luoghi
In un testo dal titolo Le conseguenze della modernità, Anthony Giddens ha scritto che la modernità politica e filosofica è sostanzialmente legata al progressivo svuotamento dei luoghi, intesi nella loro accezione più o meno classica di loci – tridimensionali e ricchi di qualità naturali – sostituiti dallo «sviluppo dello spazio vuoto» quale pura estensione[5]. In altre parole, ciò che determina il cambiamento radicale, ciò che segna cioè il passaggio dal mondo pre-moderno al mondo moderno, si situa al livello dello spazio che, a partire dal Seicento, viene pensato secondo le modalità proprie della rivoluzione scientifica galileana, e dunque viene inteso come continuo, omogeneo e non anisotropo. Con l’epoca barocca inizia la grande rappresentazione del mondo – come per il Theatrum Orbis Terrarum di Ortelio e Blaeu –, che offre agli occhi di un osservatore un’immagine della totalità del pianeta terra grazie alla sua riduzione bidimensionale, dietro cui funziona una logica secondo cui lo spazio è indipendente da qualsiasi regione o luogo empiricamente esistente. Non può essere l’incontro col fuori a dirci il mondo; il mondo diviene la sua stessa rappresentazione. Negli ultimi anni sono stati i geografi più e meglio dei filosofi a descrivere tale movimento, e in Italia, su tutti, i lavori di Franco Farinelli.
Niklas Luhmann ha scritto, a proposito di ciò, che lo Stato moderno westfaliano deriva dagli atlanti, è figlio di essi e della loro immagine, e si pensa dunque come un Io a partire dallo specchio, come Narciso: ha bisogno di vedersi per costituirsi come unità che esiste. Non sarebbe stato possibile realizzare alcuno Stato se questo non fosse stato primariamente visibile nelle vesti di una figura ordinata e disposta perfettamente su una mappa geografica[6]. In altri termini, ciò vuol dire che con l’epoca moderna il mondo qualitativamente connotato secondo la sostanza naturale dei luoghi e delle regioni – inteso in senso aristotelico –, cede il passo a una natura violenta e vuota da ordinare secondo una razionalità di cui è titolare il soggetto, che, in quanto sovrano, proietta e costruisce al posto della rotondità tridimensionale un ordo rationis in temporalibus geometrico e piano, di derivazione cartografica. A questo punto, quando ci si interroga sul logos moderno, si dovrebbe probabilmente prendere maggiormente in considerazione la sua derivazione dal disegno e non solo dal discorso, dalla visione e non solo dalla parola, perché è l’immagine – e in questo senso l’immagine cartografica – che ha offerto le coordinate in grado di far mettere tra parentesi la struttura ricorsiva e ciclica del racconto – soprattutto teologico e conflittuale – slanciando invece la figura perimetrata e riconoscibile degli spazi sovrani pacificati. È dall’incubo dell’inganno diffuso foriero di violenza che Cartesio crea un sistema ordinato di rapporti e distanze, che sono l’immagine della relazione metrica quantificabile che gli enti hanno gli uni rispetto agli altri disposti su un piano liscio e individuabili secondo coordinate.
La Terra squadernata sotto i nostri occhi, tracciata su un atlante, diviene il paradigma ordinante, l’immagine allo stesso tempo costruita e naturale che funge da modello per la costruzione delle società umane, secondo logiche euclidee e tolemaiche, ovvero “razionali” e lineari. È il motivo per il quale Carl Schmitt può scrivere che col moderno nascono le grandi linee globali: le rayas e le amity lines tracciate sul mondo come puro spazio cartografico in grado di conferire ordine al globo. La sfera viene sussunta nella carta e le linee azzerano l’impossibile rotondità del globo.
Dopo Hobbes razionalizzare le società umane ha significato credere di poter costruire la convivenza umana a partire dal trascendentale della tavola, secondo una standardizzazione generalizzata condotta more geometrico, che permette al Leviatano di funzionare dopo una preliminare preparazione del campo, reso libero da tutte le asperità e deformazioni.
Tutta la contrapposizione frontale che il filosofo inglese impianta a partire dalla separazione radicale tra stato di natura e stato civile, giace, si potrebbe dire, sulla volontà di sostituire uno spazio ideale e astratto – e pertanto ordinato – al caos violento dell’esistenza naturale che è il contrario dell’omogeneità sovrano-cartografica. In questo senso la razionalità politica moderna può essere letta come il tentativo di dispiegare orizzontalmente una ragione affascinata dal disegno e dal suo incanto ordinante. Non è il racconto dei profeti, sempre caotico e fumoso, ciò a cui si deve credere, ma bisogna credere alle mappe, e questo perché per il mondo moderno vale sommamente la massima di Berkeley: solo ciò che viene percepito è. Gli uomini credono agli occhi e non alle parole; in questo caso: una mappa non concede ambiguità, ma si presenta immediatamente come unità ordinata che rende visibile qualcosa, e dunque non è mero oggetto tra gli oggetti, ma oggetto d’eccezione costruito dalla matematica, dalla trigonometria, e dunque verità e non immagine fantasmatica. Guardare una mappa non è percepire il mondo coi sensi, ma comprendere la Terra matematizzata grazie allo sguardo, perché la linea che traccia il mondo non appartiene al mondo, ma lo rende visibile trasformandolo in Terra.
La natura è vuota di ordine e non predispone ad alcuna razionalità né ad alcuna convivenza pacifica – così come non si predispone a un abbraccio che la comprende e la chiude nella sua interezza –, ai sensi corporei il mondo non è visibile nella sua rotondità, per cui si rende necessario sostituirlo con un’immagine statica che ha una sola faccia, a portata di occhi, priva di ambiguità e che dunque si presenta come intrinsecamente normativa: la Terra[7].
Se è vero che per Hobbes esistono una lex e uno ius naturale è anche vero che questi non predispongono alcun piano normativo utile all’edificazione delle società umane: tra natura e uomo c’è un abisso, c’è un salto e non una continuità: l’invisibile caotico del mondo deve divenire il visibile concreto della Terra.
Questo vuol dire che il dio mortale, cioè lo Stato, non appartiene alla struttura naturale dell’essere, ma è macchina artificiale: machina machinarum. Non bisogna però neanche pensare che in Hobbes il rapporto tra materia e forma sia lo stesso che c’è tra materia e spirito, perché in questo il filosofo inglese è un materialista assoluto. Lo Stato non cala dall’alto, ma sorge invece dal basso, è materia organizzata in una modalità tale da rappresentare la più alta espressione della capacità creativa dell’uomo, situandosi al pari dell’opera d’arte per antonomasia[8]. Lo Stato è una macchina che può sorgere e dominare nel momento in cui il mondo è diventato un’enorme piano privo di striature. Con Hobbes giunge infine al pensiero l’idea che la logica cartografica deve poter dispiegare la propria potenza performativa e fungere da paradigma per la soggettività politica, e questo vuol dire, in via definitiva, realizzare una spazializzazione, intesa come procedimento che, a partire dal vuoto lasciato da Dio, riduce il globo a spazio liscio – liberato dai luoghi – sul quale tagliare sovranamente porzioni da gestire e amministrare. Realizzare la razionalità significa dunque ordinare gli spazi secondo una logica di sottrazione del dato naturale: spazializzare significa de-territorializzare, proiettare il globo sulle due dimensioni[9].
In questo senso è il tempo a sfumare, e tutto ciò che si dà sotto il sole non è altro che pensato a partire dall’equivalenza radicale: così come i segni si equivalgono sulla mappa, così i luoghi sono ridotti all’equivalenza di nomi privati di ogni ambiguità, che non possono più fluttuare liberamente[10], per cui nel moderno l’aspetto metamorfico cede il passo alla misurazione che fissa e chiude in rapporti quantificabili.
Fondare lo spazio moderno è stato dunque preliminarmente un’operazione di de-territorializzazione, nel senso letterale, e cioè nella misura in cui il territorio è stato letteralmente tolto di mezzo – e con esso è stato annullato il suo carattere di luogo sul quale si esercita naturalmente un terrore (da terrēre) – per fare largo all’idealità dello spazio inteso nella sua accezione di pura estensione omogenea e dequalificata, «spazio vuoto» che necessita di un sovrano per essere organizzato. La società feudale e cetuale emanazione vivente del luogo si sgretola con l’avanzare della geometrizzazione.
- Sinbad e Moby Dick
Il territorio si è dunque dovuto uniformare alle esigenze della carta, ai diktat del modello cartografico, e chiaramente tale operazione più che essere giudicata andrebbe riconsegnata alla propria complessità, così come alla propria ratio storica, il che vuol dire alla propria contingenza più che alla sua necessità. In questo senso infatti – sebbene lo sguardo cartografico esista perlomeno dal primo disegno della Terra fatto da Anassimandro[11] –, è ancora più vero che quella della carta smette di essere una tra le tante fonti per divenire il “paradigma operativo” solo con l’età moderna, quando di fatto il cartografo diviene prima il geografo del re, e poi il braccio destro del sovrano politico, come per la Rivoluzione francese[12]. Il piano d’immanenza è la carta sulla quale è scritta tutta la storia della sovranità politica moderna, fino all’Unione sovietica: ultimo tentativo estremo e disperato di pensare tutto a partire dal piano.
Questo è il motivo per cui la tesi della precessione dei simulacri sostenuta da Jean Baudrillard[13] – il quale ritiene che la post-modernità sia nei fatti caratterizzata dalla sostituzione della realtà col suo modello –, non tiene conto del fatto che ciò di cui parla è esattamente la ratio più autentica del mondo moderno, per cui se mai si possa parlare di post-moderno non sarebbe questo il suo proprio, ma andrebbe ricercato altrove, e nello specifico proprio nella fine di tale relazione immagine/realtà e nella fine del regime della rappresentazione. Rispetto a ciò sembra più avanzato il discorso di Kafka, dell’incommensurabile che appare ne Il castello, dove un agrimensore di fatto non può più misurare, non può più ridurre all’immagine geometrica ciò che di fatto è divenuto abnorme e irrappresentabile; il mondo non può più proiettarsi nella Terra, ma sfugge ad ogni rappresentazione che voglia fissarne il profilo.
Cosa avviene allora alla fine del XX secolo, momento in cui, come scrive Franco Farinelli, la ragione cartografica declina?
Ernst Jünger in Foglie e pietre paragona la situazione dell’uomo del proprio tempo a quella di Sinbad il marinaio, che durante la sua prima notte di viaggio, fermatosi a riposare su un’isola coi propri compagni e acceso un fuoco, scopre che in verità l’isola è un grande pesce che se ne stava lì immobile da tempo immemore, e che adesso, infastidito dalla presenza degli uomini si lascia andare nelle profondità per scomparire[14]. Il racconto può essere preso come una metafora perfetta del Leviatano e della sua fine, il mostro marino biblico preso da Hobbes come immagine per riferirsi allo Stato – quale forza che non conosce pari e non riconosce superiori, ma che tutto organizza a partire dalla propria immane potenza di “simulare la terra” – che in ultimo non può che rivelarsi per quello che è: un mortale, che a un certo momento deve inabissarsi lasciando l’uomo in balia del mare. Il retrocedere di logiche cartografiche cammina di pari passo con la crisi dello Stato moderno e con la fine del dominio della superficie, il che vorrebbe dire per Jünger che l’uomo si ritroverebbe di colpo sguarnito di fronte al ripresentarsi di una situazione d’insicurezza radicale, perché ciò che irrompe è uno svelarsi degli abissi e delle profondità, così come delle forze elementari per le quali non si danno mappe e accomodamenti. È l’epoca dei Titani che incatenati un tempo nelle profondità telluriche tornano a scalzare l’uomo borghese per fare spazio a nuove forme di eroismo che non permettono più di stare al mondo secondo l’illusione ottica della rappresentazione[15]. È il sogno della rivincita di Ctonia contro Gaia.
Peter Sloterdijk in L’ultima sfera, ha dato invece una lettura differente, che anzi potrebbe dirsi antitetica rispetto a quella data da Jünger. La grande metafora non sarebbe quella di Sinbad e dell’isola-pesce ma quella di Achab, il grande cacciatore di Moby Dick, della balena bianca e rotonda al cospetto della quale tutto retrocede nell’impossibilità, come un «universo paralizzato» di fronte a una terra incognita che non è appropriabile in virtù di nessun atto e nessuna ragione[16]. Il bianco liscio del cetaceo è descritto da Melville, secondo Sloterdijk, per dire il naufragio di ogni fenomenicità: è una carta bianca e accecante ma tonda e tridimensionale, potremmo chiamarla una mappa-globo mostruosa e incomprensibile che ruota su se stessa, levigata e inaccessibile, senza poter significare niente. Se il mondo è il biancore accecante di un cetaceo che rotola non ha allora più senso pensare a una direzione – né per sé né per le cose del mondo –, perché si è condannati a girare in tondo, ad andare a vuoto, a fare la ronda su uno spazio che è liscio e viscoso, bianco e privo di strutture significative: è l’immagine dell’inferno. Per Sloterdijk con Moby Dick si svela anche il naufragio, da un lato, di ogni possibile esistenzialismo, perché se il mondo è oggi il naufragio di ogni contenitore protettivo allora l’inferno non sono banalmente gli altri – come sosteneva Sartre – ma è il fuori, ovvero vivere nell’indifferenza dell’«inferno bianco» inaccessibile del mondo, per il quale non può più darsi alcuna sfera protettiva[17]. Questo vuol dire anche, da un altro lato, la fine di ogni ipotesi di contropiano e di ogni immediatezza, perché la crisi del regime cartografico della rappresentazione non spalanca le porte del mondo salvato dall’immanenza – grande illusione moderna –, ma produce un’esteriorità generale disperata e inabitabile che moltiplica e allo stesso tempo nevroticamente rifiuta le mediazioni; come nell’opera dell’artista Michael Ranger che, lavorando sulla celebre foto scattata da Armstrong ad Aldrin sulla superficie lunare, fa risaltare il riflesso della visiera del casco di Aldrin che in questo modo produce un rimando infinito di sguardi circolari tra sé, Armostrong la superficie lunare e il vuoto nero del cosmo.
- Improbabili paesaggi cosmici
Ha scritto Denis Cosgrove che l’uomo è andato sulla Luna ma ciò che ha prodotto è stata «un’immagine alterata della terra»[18], la stessa che scattata dall’occhio di Lunar Orbiter I aveva spaventato Heidegger, perché alla fine la metafisica giungeva con la sua potenza riduttiva a presentare il pianeta in immagine come un astro errante, come un ente pienamente a disposizione dell’uomo[19]. La Terra vista dalla Luna sembrava una nave nel mare nero del cosmo, sradicata e vestita del suo mantello luminoso al cospetto dell’assenza di colore più totale e tetra che la circondava da ogni lato: «non è più la Terra quella sulla quale oggi l’uomo vive»[20]. Ma il regime dell’Entortung spinto alla sua massima intensità, che ha atterrito Heidegger, non ha invece scoraggiato il miliardario Jeff Bezos dal lanciare il programma di turismo spaziale «Blue Origin», che al prezzo di 28 Milioni di dollari permette a miliardari interessati di varcare la linea di Kámrán e ammirare il paesaggio cosmico da una navicella in orbita. In questo modo, la Terra – come un animale malinconicamente addomesticato –, si offre alla vista in uno zoo cosmico, mostrando anche questa volta una sola faccia, quella di un cerchio desolato il cui dentro è un fuori. Non più i luoghi più esotici ridotti a consumo instagrammabile, ma direttamente la Terra nel suo complesso diviene godimento dei desideri del soggetto-consumatore.
Cosa resta allora dopo la carta e dunque dopo la crisi novecentesca? Se l’identità è una tragedia moderna che si è realizzata in termini geometrici e matematici, che cos’è l’epoca della post-identità? È forse l’epoca della «genericità» così come si domanda Rem Koolhaas[21]? L’architetto nato a Rotterdam, con un piglio profondamente critico se non pessimista, osserva come il mondo contemporaneo sia nei fatti dominato da una spazialità indistinguibile, che corrisponde a una deriva della modernità e delle sue logiche organizzative, di cui la dimensione attuale non rappresenta né la sua sostituzione né il suo superamento, ma la sua ingestibile confusione. In questo senso, come per lo sradicamento heideggeriano «compiuto» della terra, il contemporaneo diviene deriva, ma a differenza che per Heidegger, per Koolhaas è l’estinzione del sogno moderno di razionalità a segnare la nascita di uno spazio che va alla deriva, sotto la spinta dell’accumulazione e della genericità. C’è dunque qui, in qualche misura, la sopravvivenza della nostalgia del sogno illuminista, perché, in questo senso, la fine del regime cartografico e con esso la fine delle disconnessioni moderne non hanno portato la democratizzazione radicale degli spazi, ma la loro metamorfosi in ambienti distrattivi, che sono nei fatti un deragliare ingestibile della modernità. Secondo tale lettura, dove declina la gerarchia non cresce l’immanenza felice ma l’accumulo, e con esso l’assenza generalizzata di senso. Pertanto, negli ammassi ibridi e patinati delle nuove metropoli – che non sono più città ma vaga genericità da consumare – incombe «un nebuloso impero di indistinzione che confonde l’alto e il basso, il pubblico e il privato, il diritto e il ricurvo, il sazio e l’affamato per offrire un ininterrotto patchwork di ciò che è perennemente disarticolato»[22]. David Harvey, da marxista – e dunque da tutt’altra prospettiva – in La crisi della modernità aveva fatto notare come il fenomeno che segna «il serio ridimensionamento del potere dei singoli Stati»[23] si accompagna a un ritorno dell’ideale di luogo come risposta rigida al mutamento abnorme prodotto dall’«accumulazione flessibile»[24]. Le due posizioni possono essere distanti ma invece si toccano, perché anche per Harvey la questione diventa l’accumulo che soppianta ogni possibilità del piano. Accumulare è produrre una forma in perenne stato di incompiutezza, che si sottrae a qualsiasi finalità e cresce su se stessa refrattaria allo schema: ogni nuova aggiunta non funziona secondo una struttura, ma si aggrega come pezzo, in un rapporto ibrido col resto.
In relazione a ciò, se Merleau-Ponty sostiene che il corpo è la chiave di accesso allo spazio, ci si potrebbe domandare: cosa struttura invece un corpo? Quali desideri lo colonizzano e ne influenzano gravemente la postura? Perché troppo non può un corpo, e da esso, probabilmente, troppo ci si aspetta. La fine della rappresentazione moderna non significa l’epoca del corpo riscoperto. David Harvey ha scritto che la crisi della modernità è accumulo disorganizzato al quale si accompagnano «i personaggi più piatti nei paesaggi più piatti resi nel modo più piatto»[25], come nel film Paris, Texas di Wim Wenders. Peter Sloterdijk in un lavoro del 2022, più o meno in modo analogo – anche se pensando la genesi della civiltà moderna a partire dalla sfera e non dalla tavola –, sostiene che il colore del nostro tempo sia il grigio, allo stesso tempo indice di infinita mediazione e di informe mescolanza[26], così come il contemporaneo è segnato da «accumuli di punti eccentrici autoreferenziali»[27] che definisce schiume. Stando a tali letture, seppur da prospettive molto differenti, l’immagine del One World liscio e immanente non produce nomadismi felici – né la banale figura del turista né quella tragica dei migranti né l’abnorme senza volto del terrorista dicono questo – e mentre nevroticamente logiche confinarie e militari si riprendono il loro posto, l’irregolarità del geoide terrestre delude, e l’uomo ancora sta «nell’umiliazione sublunare»[28]. Lo spazio liscio dell’economia riconfigura nuove disconnessioni, e la politica torna a reclamare in forme rinnovate la propria spazialità frammentata, nel ritorno di fantasmi cartografici a sovranità dispiegata – troppo entusiasticamente quanto irrealisticamente messi da parte – potenziati oggi dai sistemi satellitari globali che fasciano il pianeta e aiutano i missili a raggiungere obiettivi sensibili disseminati sul corpo del mondo, i governi a spingere in avanti le forme di controllo, e i software a viaggiare sui canali virtuali verso luoghi-bersaglio senza alcuna storia o significato. Il cortocircuito tra la sfera e la mappa pare oramai realizzato: la circolarità e il controllo si fondono, l’orbita e l’immagine riscrivono una superficialità spettrale: piana, ubiqua, abbracciante e claustrofobicamente esposta all’aperto.
La Terra, alla fine del regime cartografico, non può più neanche darsi nell’estatica dimensione del paesaggio come redenzione dopo la sua riduzione a cadavere misurabile – perché questa era la massima espressione del tempo borghese in cui il soggetto incontrava il residuo di mondo che sfuggiva alle mappe, come con grande chiarezza spiega Farinelli[29]. Probabilmente perché la frantumazione della soggettività – salutata da molti come il trionfale ingresso nel tempo dell’immediatezza dionisiaca – non permette invece, al contrario, alcuna mediazione col fuori se non attraverso l’ipermediazione coatta e nevrotica dei dispositivi tecnologici, delle immagini, come in un infinito gioco di specchi, in cui prevale un regime ibrido, dello zoom-in e dello zoom-out, del tridimensionale e del bidimensionale, della carta e del globo, del dentro e fuori la mappa, dell’immagine e del suo fantasmatico resto, dell’abbracciante e del taglio.
Come sostanzialmente scriveva l’epistemologo britannico Toulmin – anche se non esattamente in questi termini – l’uomo necessita continuamente di rinaturalizzare, ovvero di provare a riannodare in qualche modo il nesso tra cosmo e polis, in modo da poter iscrivere le società umane in un quadro più ampio e naturale, che riesca a tenere tutto assieme[30]. Quale misura può allora oggi contenere la Terra nel tempo in cui la sua rappresentazione cede? Quale legame si può riannodare con l’altro e col fuori nel tempo dell’immanenza sfinita, dell’agognata e impossibile immediatezza, quando tutto pare trasformarsi o in un fuori vetrinizzato[31], o nel «teologicamente estremo»[32] oppure in una nuova cartografia del dominio, allo stesso tempo fissa e liquida, mobile e granitica: navi portaerei che setacciano gli oceani, oleodotti e rotte di nuovi schiavi che tracciano le nuove arterie globali, frontiere e muri che tornano a dividere e il deserto che avanza?
La crisi della rappresentazione significa la sua caduta nell’abnorme del cosmogramma piano-sferico piatto e multidimensionale, nell’ibridazione mostruosa dei regimi. Dietro
la bidimensionalità della tavola e della mappa c’è stata senz’altro una coazione controllante: la necessità di comprimere il complesso nello schematizzabile, in modo da rendere la totalità del mondo a portata di mano, secondo principi di ordine. E certo questa coazione è intimamente legata alla volontà di dominio, di conoscenza oggettiva, di progresso e di potere sull’ambiente e sul mondo, che ha significato anche desiderio di controllare la morte e il caos. Dietro la sfera, tuttavia, potremmo trovare invece un impulso di segno opposto, la coazione avvolgente o coazione inclusiva, o Ge-Häuse nel linguaggio di Sloterdijk. La sfera incarna in questo senso l’idea di un mondo che contiene e protegge, che non fugge in avanti, non si proietta secondo la fuga delle linee che aprono spazi ulteriori, perché è invece un ambiente che abbraccia l’uomo in una totalità, in un utero, alle cui spalle si muove l’idea che venire al mondo è sempre un venire in un chiuso in relazione, ma che proprio per questo si apre all’inquietante problema del fuori. «La globalizzazione o sferopoiesi in grande è l’avvenimento fondante del pensiero europeo»[33], stando alle parole di Sloterdijk l’esigenza sottesa alla sfera non è di dominio e controllo, ma di appartenenza e immersione, è esperienza fusionale col grembo e con l’insieme, è la circolarità che si oppone alla linea, con tutto ciò che questo sogno di unità immunitaria comporta. Ma oggi, in un tempo che non ammette più rappresentazioni bidimensionali (Farinelli) e non conosce più sfere (Sloterdijk), e sta invece nell’avvenuta ibridazione indecidibile di entrambe – nella de-rappresentazione irrapresentabile così come nella iperverità dell’immagine –, cosa questo significhi è ancora tutto da pensare. Perché tale ibrido – assieme dogmatico e metamorfico, riduttivo e smisurato – cela le logiche costitutive e operazionali dell’Occidente-mondo dopo l’avvenuta provincializzazione dell’Europa.
[1] C. Schmitt, Il nomos della terra (1950), tr. it. Adelphi, Milano 2011, pp. 368 ss.
[2] Ibid., p. 374.
[3] G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia (1837), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2021, pp. 70 ss.
[4] Tesi sostenuta da F. Fukuyama in La fine della storia e l’ultimo uomo (1992), tr. it. Utet, Torino 2020, pp. 381 ss.
[5] A. Giddens, Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo (1990), tr. it. Il Mulino, Bologna 1994.
[6] N. Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modern Gesellschaft, Band 3, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, p. 109.
[7] Cfr., F. Farinelli, L’invenzione della Terra, Sellerio editore, Palermo 2016, p. 130.
[8] Cfr., C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes (1938) in Id., Scritti su Thomas Hobbes, tr. it. Giuffrè, Milano 1986, pp. 89 ss.
[9] F. Farinelli ritorna più volte sulla centralità della proiezione quale operazione, compiuta dal soggetto, di traduzione delle tre dimensioni sulle due dimensioni della tavola. Si rimanda a: F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino 2009; F. Farinelli, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino 2003.
[10] Cfr., A. Ricci, La geografia dell’incertezza. Crisi di un modello e della sua rappresentazione in età moderna, Exorma, Roma 2018, p. 25.
[11] F. Farinelli, L’invenzione della Terra, cit., pp. 44-47.
[12] Il geografo italiano Franco Farinelli sostiene invece la tesi che il logos “occidentale” sia tout-court quello della tavola, perché già nel Libro della Genesi dell’Antico Testamento si dice che «Dio aleggiava sulla superficie delle acque», per cui fin da sempre il mondo è già pensato come Terra, come superficie a due dimensioni. Cfr., F. Farinelli, L’invenzione della Terra, cit., pp. 18-24.
[13] J. Baudrillard, Simulacros e simulação (1981), tr. pt. Relógio d’Água, Lisboa 1991, p. 8.
[14] E. Jünger, Foglie e pietre (1934), tr. it. Adelphi, Milano 1997, p. 141.
[15] Su questo si rimanda a: A. Gnoli - F. Volpi, I prossimi Titani. Conversazioni con Ernst Jünger, Adelphi, Milano 1997.
[16] P. Sloterdijk, L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione (1999), tr. it. Carocci editore, Roma 2002, p. 122.
[17] Ibid., p. 123.
[18] D. Cosgrove, Apollo’s Eye. A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 2003, p. 257.
[19] M. Heidegger, L’intervista con «Der Spiegel» in Risposta. A colloquio con Martin Heidegger (1976), tr. it. Guida, Napoli 1992, pp. 122-123.
[20] Ibid., p. 123.
[21] R. Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento radicale dello spazio urbano (2001), tr. it. Quodlibet, Macerata 2006, p. 27.
[22] Ibid., p. 66.
[23] D. Harvey, La crisi della modernità. Riflessioni sulle origini del presente (1989), tr. it. Net, Milano 2002, p. 373.
[24] Ibid.
[25] Ibid., p. 425.
[26] P. Sloterdijk, Grigio. Il colore della contemporaneità, tr. it. Marsilio, Venezia 2023.
[27] Id., Sfere II. Globi (1999), tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 122.
[28] Id., L’ultima sfera…, cit., p. 15.
[29] Cfr., F. Farinelli, L’invenzione della Terra, cit., p. 143.
[30] S. E. Toulmin, Cosmopolis. La nascita, la crisi e il futuro della modernità (1990), tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2022.
[31] Concetto presente nel testo di V. Codeluppi, Ipermondo. Dieci chiavi per capire il presente, Laterza, Roma-Bari 2012.
[32] Espressione utilizzata da Carlo Galli per inquadrare il fenomeno del terrorismo islamico a partire dal Settembre 2001, e più precisamente per indicare la mutazione del partigiano tellurico in forme di terrorismo fluttuante e nichilistico prive di misura. In C. Galli, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 25.
[33] P. Sloterdijk, Sfere…, cit., p. 38.