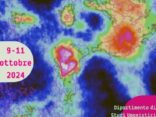Autore
- Introduzione
- La capacità localizzatrice delle cose
- Il dispositivo come «cosa»?
- Dalla dimensionalità del mondo alla bidimensionalità dell’immagine-mondo
- È legittimo definire «altrove» l’ulteriorità spaziale costituentesi con il digitale?
- Le forme di localizzazione nella virtualità: delocalizzazione o dislocazione?
↓ download pdf
S&F_n. 32_2024
Abstract
Devices and the Possibility of Opening Habitable Spaces: A Reflection Inspired by Heidegger's "Things"
This paper aims to thematize the redefinition of the dynamics of location implied in the use of digital devices. We will start from a particular conception of entities, understood as “things,” a reading that reconnects entities to their capacity to constitute places to be inhabited. We will first clarify the link that ontologically holds things and places together, in light of which we will ask whether a technological device can be understood as a “thing”. This clarification will lead us to the difference between the dimensionality of the world and the two-dimensionality of its image, which the user enjoys through devices. We will understand, then, what kind of horizon devices are capable of presentifying, asking whether in fact they lead the experience to an “elsewhere,” in light of the current narrative on the topic, which interprets from this hermeneutic category- “elsewhere” -the space made possible by the digital. This path will construct an answer to the question about the dynamics of localization, which may be, in the case of digital devices, de-localizing, dis-locating or dislocating into a delocalization.
- Introduzione
L’esperienza di ciò che chiamiamo «luogo» ha subìto un notevole processo di ridefinizione alla luce della digitalizzazione. Per «luogo» in genere si intende uno spazio determinato, dotato di una propria specificità, che lo distingue dallo spazio più generalmente inteso.
Attualmente lo sviluppo tecnologico ci consente di svolgere azioni in qualsiasi posto fisico, ridefinendo – e restringendo – l’importanza del luogo[1]. Il luogo perde il suo senso[2] poiché non è più determinante per svolgere alcune attività:
La possibilità di trascendere i confini dei luoghi in cui ci troviamo, che definisce un nuovo potere che sembra appartenerci, porta con sé anche la progressiva perdita del significato proprio di luogo. Venendo a mancare un luogo proprio per la connessione nell’ambiente digitale, si perde anche il senso della specificità dei luoghi in cui siamo[3].
Il valore stesso del luogo «si neutralizza»[4]: l’ambiente digitale può essere legittimamente definito «luogo improprio»[5] in contrapposizione alla “appropriatezza” dei luoghi dell’esperienza fisica.
Il fenomeno della «crisi del luogo» ci sollecita a riflettere sugli enti che ci consentono di stare nella virtualità, a prescindere dal posto occupato nella realtà fisica. Disporre di un dispositivo digitale ci consente, infatti, di non muoverci di un passo pur svolgendo azioni di per sé dislocanti.
Eppure, nonostante tale capacità, che amplia lo spazio dell’esperienza umana, resta comunque necessario approfondire il nesso tra i luoghi e gli enti che ci permettono di abitarli. Non è in gioco soltanto una crisi del luogo come istanza che localizza in un certo spazio. Piuttosto, è in gioco la costituzione stessa dei luoghi a partire dagli enti con cui abbiamo continuamente a che fare, dal momento che essi sono profondamente cambiati, soprattutto nelle possibilità a essi intrinseche.
A riconnettere gli enti e una certa capacità localizzatrice può essere il concetto di «cosa» heideggerianamente inteso, secondo una lettura che attribuisce agli enti la qualità ontologica di istituire luoghi da abitare[6]. Alla luce della presente peculiarità ontologica delle cose, di cosa sono capaci, invece, i dispositivi, in quanto enti che ci consentono di svolgere la nostra esperienza senza che sia necessario essere in un determinato luogo?
- La capacità localizzatrice delle cose
La lettura heideggeriana della «cosa» pone anzitutto al centro la relazione che essa può instaurare con il mondo: la cosa non è compresa anzitutto come ente che si trova nel mondo, bensì come quell’ente che ha la capacità di dischiudere un mondo, di far sì che il mondo accada come mondo. La cosa fa sì che il mondo accada per il fatto che tale ente, quando compreso come cosa, riesce a esercitare una forza localizzatrice: le cose hanno la peculiarità di aprire dei luoghi a partire da cui abitare il mondo.
Partiamo da un esempio particolarmente adatto per comprendere la presente capacità localizzatrice, quello del ponte[7]. Il ponte modifica la configurazione di una terra già traversata da un fiume, generando un luogo inedito, di passaggio, di sosta, di riunione. Il ponte allora genera, a partire da se stesso, un nuovo luogo. Nel proprio sorgere in quel punto, il ponte ha fatto spazio perché nascesse un luogo che prima non esisteva affatto:
Il luogo non esiste già prima del ponte. Certo, anche prima che il ponte ci sia, esistono lungo il fiume numerosi spazi che possono essere occupati da qualcosa. Uno di essi diventa a un certo punto un luogo, e ciò in virtù del ponte. Sicché il ponte non viene a porsi in un luogo che c’è già, ma il luogo si origina solo a partire dal ponte[8].
Ulteriormente esemplificative possono essere le costruzioni materane delle chiese rupestri. Si tratta, in questo caso, di costruzioni che nascono nella roccia a partire da uno scavo a essa interno. Si cesella la terra, nella sua durezza, facendo spazio perché nascano luoghi, per lo più di culto, laddove non c’era nemmeno uno spazio. In tal caso, la costruzione della cosa fa spazio perché nasca un luogo.
La costruzione del ponte, così come quella delle chiese rupestri, ha fatto sì che nascesse un luogo determinato: in tal senso, la cosa inverte il proprio rapporto con il luogo, poiché non è la cosa a essere costruita in un certo luogo, bensì il luogo a sorgere a partire dalla cosa.
Implicato nella presente dinamica di risemantizzazione del luogo è anche lo spazio, che diventa un «posto reso libero […], qualcosa di sgomberato, liberato»[9]. Lo spazio si concepisce alla luce del luogo, in quanto ciò che si configura a partire dai luoghi che, dalle cose, nascono: «a partire da questo posto si determinano le località e le vie in virtù delle quali uno spazio si ordina e dispone»[10]. Lo sviluppo delle cose non fa che riconfigurare lo spazio che, allora, non è determinante per i luoghi, bensì è determinato da essi:
Le cose che, in tal modo, sono dei luoghi sono le sole che di volta in volta accordano degli spazi. […] Gli spazi ricevono la loro essenza non dallo spazio, ma dai luoghi[11].
Il «fare spazio» a partire da cui si interpreta lo spazio, è da intendersi proprio alla luce dei luoghi: lo spazio non è più determinato in termini di estensione, bensì a partire dal proprio accadere, dalla propria «attività di spazializzare»[12], che si realizza nel modo del «rilasciare i luoghi»[13]: «la scala discendente» che in genere va «dallo spazio alla cosa viene così capovolta»[14].
Nella rielaborazione del rapporto tra cose e luoghi si gioca la possibilità del mondo stesso: quando la cosa dischiude un luogo, si instaura una apertura presso cui l’uomo può abitare il mondo. Abitare non significa essere semplicemente in uno spazio, occupandolo, bensì stare in uno spazio in modo tale da esserne costituiti[15]. Che le cose aprano luoghi da abitare, allora, vuol dire che esse consentono di attuare la presente relazione costitutiva, di comprendersi e condursi nel mondo come parte integrante di esso, in quanto parte costituente e costituita di esso. Il mondo non è allora uno spazio in cui siamo collocati, ma la circostanza da cui siamo strutturati, in quanto «essere-nel-mondo». Ciò contesta una posizione assunta da Luciano Floridi, che scrive: «interagiamo sempre di più con il mondo e con le nostre tecnologie tramite le ICT, e queste sono le tecnologie che possono e tendono a interagire con se stesse in modo invisibile»[16]. Sebbene sia legittima la posizione di Floridi, egli riconosce soltanto questo tipo di relazione con il mondo, descritta in termini di «interazione». Piuttosto, riteniamo necessario rivendicare la costitutività del mondo per l’individuo che siamo, tale per cui siamo fatti del mondo che abitiamo, non ne siamo soltanto gli ospiti. Questa specificazione, che di fatto radicalizza la posizione dell’uomo nel cosmo – proprio nel senso che mette le radici dell’uomo nel mondo stesso – serve a sottolineare che gli spazi presso cui interagiamo sono ben oltre il “dove” del nostro sussistere, essi sono il “dove” da cui si struttura il nostro essere[17].
Lo spazio che si apre non va inteso in termini di estensione, bensì come la realizzazione di un’apertura a partire da cui l’uomo può stare nel mondo nella propria relazione costitutiva con esso: a partire dalla cosa, l’uomo si localizza nel mondo abitandolo[18]. Non è un caso che, quando Heidegger tematizza la cosa e la propria peculiarità di costituire luoghi, sottolinei la capacità intrinseca di far sì che il mondo accada come mondo, qualificandolo secondo una struttura che si può definire dimensionale. Il mondo diventa la situazione dell’uomo come circostanza di cui egli stesso è parte, dal momento che viene iscritto nella sua struttura, come uno dei poli che la costituisce[19]. È la dimensionalità del mondo ciò che si apre nei luoghi costituiti dalle cose. Le cose sono propriamente ciò a partire da cui l’individuo si può relazionare al mondo nella propria complessità, in quanto ciò che lo circonda, nella propria eccedenza. L’esperienza delle cose è l’aprire di un luogo che è tale perché permette di collocare, localizzare colui che esperisce la cosa in un rapporto al mondo nel proprio carattere di essere-mondo, come eccedenza rispetto a ciò che del mondo esperiamo e in cui quotidianamente ci “imbattiamo”, che sono gli enti. Le cose aprono i luoghi, che ci localizzano in un rapporto con la circostanza. «Le cose […] adunano» gli elementi che strutturano il mondo, facendo spazio per questa «unità originaria»[20].
Le cose trattengono presso di sé il quadrato dei quattro. […] L’unitario quadrato di cielo e terra, mortali e divini, immanente all’essenza delle cose in quanto cose, noi lo chiamiamo: il mondo. […] Queste, nel loro essere e operare come cose, dispiegano il mondo: nel mondo esse stanno, e in questo loro stare al mondo è la loro realtà e la loro durata. Le cose, in quanto sono e operano come tali, portano a compimento il mondo. […] Esse generano il mondo[21].
Heidegger non parla di orizzonte per indicare il mondo che le cose generano, bensì preferisce il termine «dimensione»[22]: tale preferenza è tutt’altro che una precisazione stilistica; essa costituisce un’indicazione ontologica fondamentale per comprendere che tipo di mondo si apre a partire dalle cose. La dimensione, definita anche «frammezzo»[23], indica propriamente la porzione del suo abitare. L’uomo accade fra, nel bel mezzo del mondo, in una dimensione che non va pensata come estensione di uno spazio, «quale generalmente lo si rappresenta»[24]. Al contrario, l’estensione di uno spazio è possibile in virtù della più originaria dimensione presso cui abitiamo. Il frammezzo è «il luogo proprio del suo abitare»[25].
La cosa, dunque, gode della peculiarità di localizzarci nel bel mezzo del mondo, nel mondo che si può intendere adesso come frammezzo.
- Il dispositivo come «cosa»?
Alla luce della presente determinazione ontologica degli enti come cose, anche i dispositivi tecnologici potrebbero essere annoverati come cose, per la propria caratteristica di concedere spazio a luoghi inediti: la scrittura del codice diventerebbe una rimodulazione dello scavare nella roccia che ha permesso la nascita delle chiese materane. In effetti, nuovi spazi di incontro, di associazione, di lavoro si sono sviluppati, sebbene in un rapporto di differenza rispetto a quelli reali, in quanto virtuali. Come insegna Pierre Levy, il virtuale non è in opposizione al reale, bensì all’attuale. La virtualità è una modalità diversa della realtà[26].
Rispetto all’effettiva capacità di ampliamento degli spazi d’interazione, sembra che i dispositivi ci aiutino a disporre il mondo per disporne meglio: sembrano un modo ulteriore per gestire il nostro orizzonte mondano. La stessa radice del termine «dispositivo», disporre, rientra nella sfera semantica dell’organizzare nel senso di un gestire seguendo un certo principio organizzativo. Il dispositivo rielabora il mondo che accade, riconfigurandolo nel proprio aspetto.
Secondo l’interpretazione di Giorgio Agamben, in virtù della radice nel termine latino di dispositio, il dispositivo si riconnette al Gestell heideggeriano:
Quando Heidegger, in Die Technik und die Kehre (La tecnica e la svolta), scrive che Ge-stell, significa comunemente “apparato” (Gerät), ma che egli intende con questo termine “il raccogliersi di quel (dis)porre (Stellen), che (dis)pone dell’uomo, cioè esige da lui lo svelamento del reale sul modo dell’ordinare (Bestellen), la prossimità di questo termine con la dispositio dei teologi e con i dispositivi di Foucault[27] è evidente. Comune a tutti questi termini è il rimando a una oikonomia, cioè a un insieme di prassi, di saperi, di misure, di istituzioni in cui scopo è di gestire, governare, controllare e orientare in un senso che si pretende utile i comportamenti, i gesti e i pensieri degli uomini[28].
In linea con questa interpretazione è anche quella di Byung-Chul Han, che si occupa di un dispositivo in particolare, protagonista indiscusso tra i dispositivi, lo smartphone:
Lo smartphone è un “impianto” nel senso heideggeriano del termine Ge-Stell, poiché racchiude in sé quale essenza della tecnica tutte le forme del rendere disponibile: ordinare, immaginare, creare. Il prossimo passo di civiltà si spingerà oltre la trasformazione del mondo in immagini. Consisterà nel creare il mondo, cioè una realtà iperreale, partendo dalle immagini[29].
L’elemento che emerge a partire dalle presenti letture è proprio quello del disporre, in un senso simile alla pratica di porre in scaffali. Questo accostamento tematico è indicato, in realtà, dallo stesso termine tedesco Gestell, che nell’uso corrente vuol dire proprio «struttura», «scaffale». E in effetti, nell’atto della disposizione, il mondo viene ristrutturato, messo in scaffali, secondo una certa logica.
Un ente quale è il dispositivo, allora, rientra nella sfera della gestione del mondo, nella sfera del fare umano, che si occupa di “addomesticare” il proprio ambiente. L’addomesticazione indica quell’azione laboriosa che rende casa il proprio ambiente di locazione. Per questo aspetto, i dispositivi sono enti estremamente abili: che l’uomo possa esperire il mondo attraverso l’uso dello smartphone rende il mondo domesticato, di una domesticazione che si realizza in termini di disponibilità.
Il costante digitare e strisciare delle dita sullo smartphone è un gesto quasi liturgico con effetti ponderosi sul nostro rapporto col mondo. Le informazioni che non m’interessano vengono scacciate alla svelta. I contenuti che mi piacciono vengono invece zoomati con due dita. Ho tutto il mondo in pugno. Il mondo deve orientarsi interamente verso di me. […] Digitando come un pazzo, sottometto il mondo ai miei bisogni. Il mondo mi dà l’impressione di una totale disponibilità nell’apparenza digitale[30].
Lo smartphone diventa mezzo, ma in modo diverso, dal momento che non è più ciò che si utilizza per svolgere un certo fine, bensì il medium per esperire il mondo in quanto tale, in un modo tuttavia peculiare:
Lo smartphone fa il mondo, cioè se ne impadronisce creandolo in forma d’immagine. L’obiettivo fotografico e lo schermo diventano quindi elementi centrali dello smartphone in quanto formano la trasformazione in immagini del mondo[31].
Emerge con evidenza un rapporto ben diverso tra dispositivo e mondo rispetto a quello precedentemente analizzato tra cosa e mondo. Se la cosa fa sì che il mondo accada, il dispositivo lo riordina per far sì che l’utente ne usufruisca. Il dispositivo riordina il mondo, la cosa lascia spazio perché accada. Secondo questo processo di ricostruzione ordinata del mondo, esso diventa, visto per mezzo dello smartphone, immagine del mondo:
Lo smartphone si differenzia dal classico cellulare poiché non è solo un telefono, ma prima di tutto un medium iconico e informativo. Il mondo diventa completamente accessibile e consumabile nel momento in cui viene oggettivato in forma d’immagine[32].
- Dalla dimensionalità del mondo alla bidimensionalità dell’immagine-mondo
Descrivere l’esperienza del mondo in digitale in termini di «immagine del mondo» esige una specificazione, dal momento che lo statuto ontologico dell’immagine digitale è profondamente diverso rispetto a quello della comune rappresentazione.
Le immagini, infatti, sono diventate, come il teorico dei media Vilém Flusser[33] le definisce, tecno-immagini, poiché nascono dalla “costruzione tecnica”. L’immagine del mondo che si profila sullo schermo è, infatti, risultato di una computazione algoritmica che ha calcolato il modo in cui il mondo dovrà apparire, rielaborando quanto della realtà materiale ha ricevuto. Sebbene si mostrino come le immagini tradizionali, in virtù della propria bidimensionalità, le immagini digitali sono profondamente diverse. Muta, infatti, il processo di costruzione: «l’immagine tecnica non è altro che espressione visibile di un testo nascosto e invisibile che informa il computer»[34]. Le immagini digitali, in virtù della propria origine algoritmica, si inseriscono – rivoluzionandola – in una «guerra culturale»[35] che tiene immagini e testo schierati l’uno dinanzi alla trincea dell’altro. La netta, oltre che tradizionale, contrapposizione tra immagine e testo entra in crisi con l’avvento delle immagini digitali, che si sviluppano a partire dalla compenetrazione del testo scritto dal programmatore e dell’immagine. Del resto, il mestiere del programmatore consiste proprio nella scrittura dei programmi, che richiede la conoscenza di molteplici linguaggi di programmazione, linguaggi che nel caso specifico sono di tipo computazionale. Nonostante, tuttavia, tale legame, gli studi sul digitale scontano un impianto perlopiù imagocentrico[36], secondo il quale la digitalizzazione avrebbe condotto alla vittoria dell’immagine sulla scrittura. In questa direzione, infatti, ci si riferisce spesso al cambiamento implicito nel digitale come iconic turn[37], proprio per sottolineare la vittoria dell’iconico sul testuale. L’immagine digitale ha, piuttosto, una struttura ancipite[38], che la rende ontologicamente differente dall’immagine come rappresentazione.
Esse (le immagini digitali) si offrono alla percezione umana come forme visibili, in modo simile a quanto avviene per tutte le altre immagini artificiali, ma da un punto di vista ontologico non sono riducibili a questa manifestazione, perché non è possibile distinguerle dai processi computazionali che le originano materialmente grazie al lavoro che un programma (software) compie in una specifica macchina (hardware)[39].
Ciò vuol dire che «ciò che ci appare la diretta traduzione della scrittura in immagine è in realtà l’esito di molteplici processi che sfuggono totalmente all’utente medio»[40]. Oltre al rischio degli esiti apocalittici[41] di una lettura contrappositiva, risulta evidente il limite dell’impostazione imagocentrica perché non coglie, e non restituisce, il duplice spessore dell’immagine digitale, che rientra rispettivamente nell’iconico/visuale e nel testuale. Piuttosto, la scrittura informatica
permette di trasformare i concetti più astratti come gli algoritmi in immagini e rappresentazioni, attuando una vera e propria inversione di paradigma: mentre l’immagine classica è visione/riproduzione di un oggetto, l’immagine tecnica deriva da una computazione di concetti[42].
Il superamento di una lettura imagocentrica delle immagini digitali consente di mettere in luce il carattere “dispositivo” connaturato in esse. L’immagine che del mondo viene restituita è molto più logica di quanto non possa sembrare, poiché essa non è altro che la risultante di una organizzazione logica del mondo, che de facto ha perso la propria dimensionalità, per essere compreso e vissuto nella propria bi-dimensionalità. Una bi-dimensionalità che non permette tanto di localizzarsi presso il mondo come circostanza vissuta; piuttosto consente di usufruire di un mondo colto nel proprio ordinamento. Le immagini digitali sono dunque l’interfaccia – ulteriore concetto protagonista della risemantizzazione dell’immagine in quanto immagine digitale - a partire da cui l’utente esperisce l’immagine del mondo, da intendersi, d’ora innanzi, come «tecno-immagine».
Le ICT modificano l’essenza stessa della realtà, perché la adattano alla loro modalità di funzionamento. E per quanto ci riguarda, le loro interfacce digitali operano come porte attraverso le quali noi entriamo e ne diventiamo parte integrante[43].
Il termine ha un duplice senso: l’interfaccia è tanto ciò che l’utente utilizza, fattivamente, nella propria interazione con il mondo digitale, è il punto di contatto, ma è anche e soprattutto l’aspetto che quel mondo assume per colui che lo utilizza. Gli è propria, infatti, la duplicità: per interfaccia si intende tanto l’hardware che permette l’accesso al mondo digitale, l’infrastruttura, tanto il software programmato sull’hardware che dà un certo aspetto al mondo digitale. L’interfaccia è, allora, l’alterità con cui l’uomo, che diventa utente, interagisce. Ciò nel senso che essa costituisce sia la consistenza materiale, la superficie del contatto, ma anche l’altro dell’interazione: una faccia guarda all’utente, mentre l’altra riconnette quel volto all’infrastruttura che la rende possibile.
L’interfaccia, intesa come ciò che costituisce il volto che il mondo assume, si specifica, non a caso, come «interfaccia grafica»:
come una scacchiera, che organizza in una griglia il suo mondo di torri e cavalli, di pedoni e di alfieri che è il suo campo di gioco, così anche l’interfaccia del computer ha il suo campo di azioni, gerarchie di file, luoghi in cui andare e distanze relative tra diversi punti di interesse[44].
La costruzione dell’interfaccia è fondativa per comprendere come il mondo venga rimodulato in digitale. Ci sostiene, in questo, ancora una volta la nozione di «tecno-immagine» che mette in luce in modo preciso la connessione tra l’immagine e la sua costruzione tecnica: si tratta, in effetti, di una riscrittura del mondo in termini algoritmici. La bidimensionalità della «tecno-immagine» garantisce il mondo al proprio utente, che però è un mondo ri-calcolato: «facciamo esperienza di un mondo che è sotto controllo. […] A prescindere da ciò che viene rappresentato, l’interfaccia gli fornisce un’immagine e una forma»[45].
Risulta chiaro, nella compenetrazione di immagine e scrittura, in che senso si possa parlare degli apparati materiali come dispositivi, alla luce della determinazione concettuale che abbiamo fornito in precedenza. Il duplice aspetto dell’immagine digitale ci permette di comprendere meglio gli stessi apparati materiali che ne permettono la fruizione, di cui gli schermi non sono soltanto «superfici di mostrazione»[46], ma quell’interfaccia che permette alla macchina e l’utente di interagire.
Che la fruizione in digitale possa accadere soltanto attraverso tecno-immagini costituisce il limite per i dispositivi di attivare processi di localizzazione.
Se i luoghi sono compresi a partire dalla propria capacità localizzatrice, allora bisogna capire se gli spazi che il digitale apre siano comprensibili come luoghi. Se le cose localizzano presso una circostanza in cui risuona l’appartenenza a essa, appare evidente che i dispositivi non riescono nel presente intento. Ciò dal momento che, prima di aprire spazi di significazione umana – capacità di cui in effetti godono – essi hanno da ordinare il mondo, da gestirne l’eccedenza. Le cose hanno il privilegio ontologico di costituire un’apertura significante con il mondo: esse ci collocano presso il mondo come orizzonte cui apparteniamo, da cui siamo costituiti, ma in cui non siamo centro. Quando la cosa si esperisce come cosa, si comprende il mondo nella propria struttura dimensionale. Questa struttura, fortemente enigmatica nel pensiero heideggeriano, è in realtà una rimodulazione ontologica della posizione dell’uomo nel cosmo in quanto non centrato. Gli uomini sono parte di questa struttura pur non occupando alcuna posizione privilegiata. La cosa, allora, genera luoghi nel senso che localizza presso un mondo compreso nella propria dimensionalità. I luoghi che si aprono a partire dalle cose sono da intendersi, allora, come spazi a partire da cui esperire un rapporto con il mondo che non lo pone nelle mani dell’uomo, ma intorno a esso, come sua circostanza. Attraverso le cose, il mondo avvolge l’ente che siamo.
Invece, attraverso i dispositivi digitali il mondo entra, in effetti, nelle mani del proprio utente, che è molto più centrato di quanto non accada nel mondo come dimensione: è un mondo riscritto dall’uomo per l’uomo[47]. Del resto, l’elaborazione algoritmica dei contenuti dei social network, in virtù di cui utenti diversi possono consumare contenuti diversi a partire dalle informazioni fornite durante l’uso del dispositivo, pone fortemente in crisi la dimensionalità del mondo: si tratta di un forte processo di atomizzazione, che fornisce il mondo[48] a ognuno in virtù di se stesso, un mondo ricostruito ad personam. Dalla dimensionalità di un mondo avvolgente si passa alla bidimensionalità di un mondo oggettivato, facilmente fruibile.
- È legittimo definire «altrove» l’ulteriorità spaziale costituentesi con il digitale?
È tempo di domandarsi, allora, della fruibilità della categoria ermeneutica di «altrove» attraverso la quale si cerca di determinare lo spazio virtuale che i dispositivi aprono, dal momento che, in effetti, con la digitalizzazione, la realtà «assume nuovi confini»[49]. Tale ampliamento ci consente di parlare di un altro-dove nei termini di una nuova localizzazione? La virtualizzazione come «altrove» «riporta all’esperienza della vita quotidiana in cui l’off-line e l’on-line diventano indicatori di un qui e un là resi possibili dall’uso delle tecnologie informatiche»[50]: in questo senso, si tratterebbe della configurazione di un altro dove, che fa da scenario alla nostra esperienza. Le attuali tecnologie informatiche rendono disponibile una vicinanza virtuale a partire da una lontananza reale, dal momento che
l’attuale macchina calcolatrice non si limita a far di calcolo, non ci consegna soltanto risultati attendibili, ma disegna ambienti, costruisce spazi di relazione e ci porta altrove, creando nuove condizioni esistenziali[51].
Eppure, tale spostamento di confini, che motiva l’uso della categoria di «altrove», è anche ciò che la fa vacillare. Alla luce delle determinazioni spaziali di cui sono capaci i dispositivi digitali, che, come abbiamo visto, consentono di usufruire di tecno-immagini del mondo, sembra che la virtualizzazione dell’esperienza immetta ulteriormente nella realtà, senza alcuna trasposizione in un luogo altro. Se l’uso dei dispositivi è un ulteriore configurazione del modo in cui possiamo gestire il mondo, tale fruizione di mondo è un modo altro di vivere l’immanenza, quel «qui», sebbene secondo modalità e possibilità riviste. Sembra, infatti, che l’orizzonte di immanenza possa essere gestito diversamente, poiché ad ampliarsi sono le possibilità di trascendenza umana, che nel suo hic può esperire regimi di lontananza senza spostarsi «altrove»: non si tratta tanto di un trovarsi altrove, ma di trasporre l’altrove nel qui. Altrove sono le nuove zone di realtà di cui si fruisce nel proprio qui, che proprio in tal senso, risulta ampliato. Questo altrove disponibile inchioda al qui senza la necessità di essere altrove, rendendo superfluo il là da raggiungere.
Saturiamo la distanza con un simulacro di vicinanza[52]: «le nuove tecnologie hanno il duplice potere di “dilatare” in modo indefinito ciò che può diventare “presente” nella nostra giornata»[53]. Questo altrove non è da intendersi come una lontananza, bensì come una prossimità che ridefinisce – nel senso che ne ridisegna i confini –lo spazio dell’esperienza. La virtualità sembra riontologizzare il qui della nostra esperienza spaziale: il significato originario dello spazio si amplia perché si nebulizza quando immette nel proprio tessuto il fantasma della realtà[54]. Pensare l’orizzonte digitale come un ampliamento del qui, e non come un altrove, permette di cogliere un aspetto fondamentale: l’interazione tra questo nuovo orizzonte e quello che abbiamo sempre vissuto, mostra che siamo innanzi a una riconfigurazione del mondo in virtù dell’interazione con questo nuovo spazio di immanenza. Si ristruttura la trascendenza nel mondo: si amplia lo spazio di immanenza nella sua gestibilità. I dispositivi digitali costituiscono nuovi modi in cui continuiamo a occuparci dell’immanenza saputa che siamo, ma non costituiscono un modo per abitarla. Gli enti tecnologici non aprono luoghi da abitare, in tal senso, ma moltiplicano gli oggetti di esperienza. Questo perché non si abita propriamente quel luogo, perché esso non è quel modo di dare significazione alla propria circostanza, risuonando in essa. Non è un modo per abitare più propriamente la circostanza, bensì un modo per gestirla meglio, per rendere disponibile e vicino quanto lontano, ma senza stabilire una relazione di prossimità costitutiva.
L’idea dell’interazione con il mondo che richiama Luciano Floridi non fa che confermare la presente interpretazione di una tecnologia che non fa sì che il mondo si abiti, ma che si interagisca sempre meglio con esso. Piuttosto, riteniamo fondamentale considerare il mondo come circostanza secondo un’accezione che sottolinea la sua caratura costituente.
Non un mondo che sta di fronte, ma una dimensione presso cui mettere radici – perché gettati in essa.
- Le forme di localizzazione nella virtualità: delocalizzazione o dislocazione?
Emerge, allora, da questo tipo di riflessione che l’uso dei dispositivi comporti una dis-locazione nella de-localizzazione.
L’esperienza, in effetti, si svolge in spazi inediti, sebbene non perché il dispositivo abbia aperto nuovi luoghi, piuttosto perché costituisce una nuova possibilità spaziale, ma che è incapace di spazializzarsi, se per tale azione si intende la capacità di costruire luoghi da abitare. Siamo dinanzi, allora, a un ampliamento, ma non alla costituzione di luoghi ulteriori.
Resta urgente la necessità di riflettere sulla differenza. I dispositivi rientrano in un orizzonte di organizzazione del mondo, che si rifà al piano della gestione e del controllo, ma non dell’abitare.
Il mondo in digitale resta un mondo vero-simile, poiché ri-scritto, ri-formulato. Il rapporto tra il mondo vero e quello verosimile non è escludente, né oppositivo, ma integrativo: l’attuale gestione del mondo va pensata accanto alla sua abitabilità, come approfondimento e perfezionamento di quella mediazione con il mondo – che la tecnica è – senza la quale l’umano non sarebbe ciò che è.
La disposizione del mondo, la sua domesticazione è parte fondamentale del nostro abitare, ma non l’unica. Il mondo ha bisogno, ancora, di rilucere nella propria indisponibilità[55] al controllo.
[1] «Tradizionalmente, gli individui erano isolati non solo fisicamente, ma anche emotivamente e psicologicamente, da locali, edifici e quartieri. Oggi, la delimitazione fisica degli spazi ha meno importanza perché l’informazione può attraversare le pareti e percorrere lunghe distanze a grande velocità. Di conseguenza, il dove ci si trova è sempre meno legato alle proprie conoscenze ed esperienze. I media elettronici hanno modificato il significato del tempo e dello spazio nell’interazione sociale» (J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comportamento sociale (1986), tr. it. Baskerville, Bologna 1993, p. 4).
[2] È ben nota la nozione di Marc Augé di «non luogo», utile per caratterizzare molteplici spazi «impropri», qualificati in particolare dal proprio anonimato, dalla mancanza di specificità. Si tratta di spazi privi di una identità e storicità propria. Sui «non luoghi» Augé riflette a partire da alcuni spazi tipicamente contemporanei, quali, ad esempio, i centri commerciali e gli aeroporti. Si veda M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità (1992), tr. it. Elèuthera, Milano 2009.
[3] A. Pessina, L’essere altrove. L’esperienza umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Mimesis, Milano 2023, p. 53.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Seguendo la genesi di tale interpretazione, è necessario ricordare la rielaborazione heideggeriana del concetto aristotelico di “luogo” come ciò che è definito dai confini di un corpo. Egli parte da un passo tratto dal IV libro della Fisica, in cui si cerca di specificare cosa siano τόπος e χώρα. Si veda M. Heidegger, Corpo e spazio. Osservazioni su arte-scultura-spazio, tr. it. Il melangolo, Genova 2000.
[7] M. Heidegger, Costruire abitare pensare (1951), in Id., Saggi e discorsi, tr. it. Mursia, Milano 20194, pp. 101-102.
[8] Ibid., pp. 102-103.
[9] Ibid.
[10] Ibid., p. 103.
[11] Ibid.
[12] V. Cesarone, Per una fenomenologia dell’abitare. Il pensiero di Martin Heidegger come oikosophia, Marietti, Genova-Milano 2008, p. 121.
[13] Ibid.
[14] Ibid., p. 123.
[15] In Essere e tempo, Heidegger tematizza la struttura dell’«in-essere» come costitutiva dell’«essere-nel-mondo», fondamentale per comprendere la differenza tra occupare uno spazio ed esserne costituiti. Si veda M. Heidegger, Essere e tempo (1927), tr. it. Longanesi, Milano 20083, §12, pp. 76-84.
[16] L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo (2014), tr. it. Cortina, Milano 2017, p. 44.
[17] Sulla costitutività del dove dell’esperienza, modulato in termini di paesaggio riflette anche V. Brugiatelli, Ermeneutica del paesaggio. Esistenza, interpretazione, racconto, Tangram, Trento 2020, dove, per es. alle pp. 100, 124-126, si parla di un’«etica del paesaggio» quale luogo dell’abitare e del «ben-essere» dell’uomo. Il testo argomenta l’inseparabilità di uomo e paesaggio alla luce della quale bisogna comprendere lo stare al mondo dell’uomo.
[18] «Il fare-spazio porta il libero, l’aperto per un insediarsi e un abitare dell’uomo. Il fare-spazio è, pensato in ciò che gli è proprio, libera donazione di luoghi […] Fare spazio conferisce la località che appresta di volta in volta un abitare» (M. Heidegger, L’arte e lo spazio (1969), tr. it. a cura di G. Vattimo, Il nuovo melangolo, Genova 2008, p. 19).
[19] La struttura cui si fa riferimento è quella del Geviert, tradotta con «quadratura». I poli in questione sono quattro: terra e cielo, divini e mortali. I riferimenti al concetto nel pensiero heideggeriano sono molteplici. Per ragioni di coerenza con il presente contributo, rimandiamo a M. Heidegger, La cosa (1950), in Id., Saggi e discorsi, cit, pp. 109-124.
[20] M. Heidegger, Il linguaggio (1950), in Id., In cammino verso il linguaggio, tr. it. Mursia, Milano 20195, p. 35.
[21] Ibid.
[22] M. Heidegger, «…poeticamente abita l’uomo…» (1951), in Id., Saggi e discorsi, cit., p. 130. Si veda altresì M. Heidegger, Feldweg-Gespräche (1944/45), Klostermann, Frankfurt a.M. 1995, pp. 83, 85-105, 110-111, 115, 121-122, 139, 159 in cui distingue l’«orizzonte», concetto ancora trascendentale, dall’«aperto» e dalla «contrata».
[23] M. Heidegger, «…poeticamente abita l’uomo…» (1951), in Id., Saggi e discorsi, cit., p. 130.
[24] Ibid., p. 131.
[25] V. Cesarone, Per una fenomenologia dell’abitare…, p. 103.
[26] Pierre Levy riflette sui rapporti tra realtà e possibilità, attualità e virtualità, interpretando le quattro modalità dell’essere secondo le cause aristoteliche: la realizzazione (dal possibile al reale) è causa materiale poiché conferisce materia a una forma preesistente; la potenzializzazione (dal reale al possibile) è causa formale, poiché costituisce l’ordine e la forma a partire dalla quale si passerà poi alla realizzazione; l’attualizzazione è causa efficiente poiché la pratica artigiana che realizza un’opera è in sé atto creativo, gli artigiani non sono meri esecutori di competenze tecniche; la virtualizzazione, infine, è causa finale poiché costituisce il perché dell’operato stesso. Si veda P. Levy, Il virtuale (1995), tr. it. Cortina, Milano 1997, pp. 130-132.
[27] Giorgio Agamben sviluppa il proprio percorso speculativo sul dispositivo a partire dalla riflessione che prima Foucault aveva svolto.
[28] G. Agamben, Che cos’è un dispositivo, Nottetempo, Roma 2006, p. 19.
[29] B.-C. Han, Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale (2021), tr. it. Einaudi, Torino 2022, p. 31.
[30] Ibid., p. 28.
[31] Ibid., p. 30.
[32] Ibid.
[33] Vilém Flusser teorizza un modello storico per interpretare il progresso umano in termini di astrazione sempre maggiore dal concreto. Questo processo si compone di cinque stadi: il vivere concreto, la manipolazione, la mediazione immaginaria, la concettualizzazione, e quello del computare e calcolare. Si veda V. Flusser, Immagini. Come la tecnologia ha cambiato la nostra percezione del mondo (1985), tr. it. Fazi, Roma 2009.
[34] A. Li Vigni, La bellezza dei pixel, in «Il Sole 24 Ore», 22 novembre 2009, p. 36 (ultima consultazione il 9 settembre 2024).
[35] M. Carbone, G. Lingua, Antropologia degli schermi. Mostrare e nascondere, esporre e proteggere, Luiss University Press, Roma 2024, p. 64.
[36] Tale impostazione è fortemente contestata dal lavoro di Carbone e Lingua che intende specificamente criticare la presente interpretazione antitetica, fornendone una che garantisca e tenga conto della contaminazione tra testo e immagine. Si veda ibid.
[37] Il concetto è canonicamente tematizzato in W.J.T. Mitchell, Pictorial turn. Saggi di cultura visuale (1994), tr. it. Cortina, Milano 2017.
[38] Sul carattere ancipite riflette anche Luciano Floridi, sebbene a partire dal concetto di interfaccia: «oggi, (Giano) è il nostro dio delle interfacce e presiede tutte le tecnologie digitali, che sono, per definizione, bifronti» (L. Floridi, La quarta rivoluzione…, cit., p. 37).
[39] M. Carbone, G. Lingua, Antropologia degli schermi…, cit., p. 86.
[40] Ibid., p. 90.
[41] Ibid., p. 66.
[42] L. De Stefano, Dal mitogramma alla tecnoimmagine, in N. Russo, J. Mutchnick (a cura di), Immagine e memoria nell’era digitale, Mimesis, Milano-Udine 2020, p. 72.
[43] A. Pieretti, Oltre l’intelligenza artificiale, in «Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia», 2020, p. 260.
[44] M. Heim, Metafisica della realtà virtuale (1993), tr. it. Guida, Napoli 2014, p. 109.
[45] Ibid., p. 111.
[46] M. Carbone, G. Lingua, Antropologia degli schermi…, cit., p. 87.
[47] Durante la celebre conferenza tenuta a Brema nel 1949, Heidegger contrappone il mondo al Gestell in quanto ciò che non concede alla cosa di essere cosa, ridotta contestualmente a Bestand (qui tradotto con «risorsa»). Il Gestell impedisce l’irradiarsi del mondo a partire dalla cosa, tanto che Heidegger usa l’espressione «rifiuto del mondo». Si veda M. Heidegger, Conferenze di Brema e Friburgo (2005), tr. it. Adelphi, Milano 2002, pp. 71-73.
[48] Sull’idea di mondo a domicilio, si veda G. Anders, Il mondo fornito a domicilio, in Id., L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale (1963), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 97-123.
[49] A. Pessina, L’essere altrove…, cit., p. 11.
[50] Ibid., p. 15.
[51] Ibid., p. 28.
[52] Sulla vicinanza che non si realizza riducendo la distanza, riflette anche Heidegger, facendo riferimento proprio all’invenzione della radio e alla fruizione del film, si veda M. Heidegger, La cosa (1950), in Id., Saggi e discorsi, cit., p. 109.
[53] A. Pessina, L’essere altrove…, cit., p. 38.
[54] Sul concetto di «fantasma di realtà» si veda G. Anders, Il fantasma, in Id., L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., pp. 124-146.
[55] Sul concetto di «indisponibilità», si veda H. Rosa, Indisponibilità. All'origine della risonanza (2018), tr. it. Queriniana, Brescia 2024.