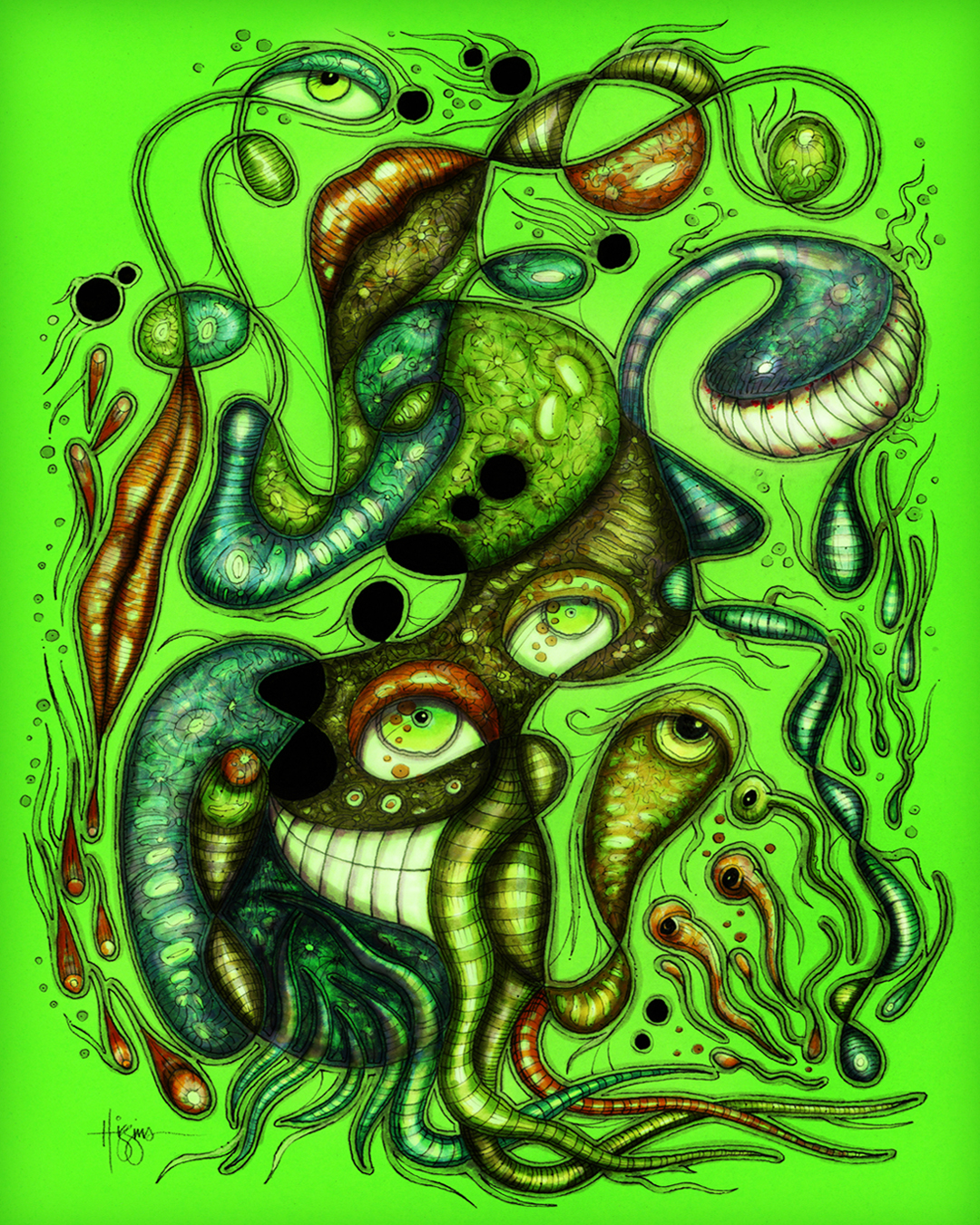Autore
Indice
- La disjunction thesis di Gray (1859): un approccio darwiniano alla botanica
- Il confronto Darwin/Gray sulla species question tra il 1855 e il 1859
- «La selezione naturale non è in disaccordo con la teologia naturale»: un’interpretazione «teistica» di The origin of species
- Gray sulla “teleologia” delle orchidee
- La variazione tra chance e design: Gray su The variation under domestication
↓ download pdf
S&F_n. 28_2022
Abstract
A river of beneficial variations: Asa Gray’s theistic evolution
This paper presents the american botanist Asa Gray’s «theistic evolution», founded on the idea of the compatibility between natural selection and natural theology, as it emerges from his writings on the darwinian themes and from his correspondence with Darwin. To the «orthodox presbyterian» Gray, the variations on which natural selection works, whose origin Darwin defined as «accidental», have been led «along beneficial lines» by God, the author of the design of nature.
- La disjunction thesis di Gray (1859): un approccio darwiniano alla botanica
Quasi un anno prima che il capolavoro darwiniano The origin of species vedesse la luce, nel gennaio del 1859, il botanico statunitense Asa Gray (1810-1888), docente di Harvard, presentava ai membri dell’American Academy of Arts and Sciences una relazione sulla connessione tra i caratteri della flora giapponese e quella del Nord-America orientale[1]. Gray illustrava questa connessione alla luce della sua disjunction thesis, che individuava i fattori naturali che determinano gli schemi della distribuzione botanica, schemi che, in quell’epoca, venivano generalmente spiegati attraverso la dottrina delle «creazioni speciali». A dispetto del titolo del suo contributo, che prometteva di trattare i «caratteri diagnostici di nuove specie di piante fenogame» e le «relazioni della flora giapponese con quella del Nord America», Gray chiarì al suo uditorio che era sua intenzione soffermarsi in particolare sul secondo argomento, e cioè sulla migrazione e sul cambiamento delle specie. Sfidando l’idea del ruolo di un Creatore nella distribuzione delle piante[2], Gray prendeva una chiara posizione all’interno del dibattito sulle interpretazioni dell’origine, della variazione e della distribuzione biogeografica noto come «species question» che si era imposto negli studi di storia naturale in Gran Bretagna fin dai primi decenni dell’Ottocento[3].
Gray presentava la tesi della relazione genetica delle specie in sostanziale continuità con la teoria darwiniana della selezione naturale. Quest’ultima gli era nota non soltanto in virtù del costante rapporto epistolare che intratteneva con Darwin già da alcuni anni, ma anche perché essa era stata resa fruibile da qualche mese grazie alla prima pubblicazione ufficiale sull’argomento che Darwin e Alfred Russel Wallace avevano presentato alla Linnean Society di Londra[4]. Il lavoro di Darwin e Wallace, accolto come “eretico” dai pochi studiosi che ne avevano intuito le implicazioni, soprattutto sul piano antropologico – innanzitutto, la necessità di una radicale ricollocazione dell’essere umano all’interno dell’universo naturale –, venne salutato invece da Gray come l’unico «tentativo scientifico» mai compiuto fino a quel momento per risolvere «la questione» se l’«effettiva associazione geografica di specie congeneriche o di altre specie strettamente imparentate, sia primordiale, e quindi al di là di ogni spiegazione scientifica, oppure se anch’essa possa rappresentare […] un effetto [di cause naturali]»[5]. Sulla base delle teorie di Darwin e Wallace, Gray ammetteva che le specie «strettamente imparentate» possono essere «i discendenti lineari di un ceppo primitivo, proprio come lo sono le razze domestiche», che «i limiti della variazione occasionale» sono «più ampi di ciò che si suppone», e che le «forme derivate, quando segregate, si possono costantemente riprodurre come i loro originali»[6].
Le osservazioni di Gray, in aperto contrasto con le dottrine creazioniste, lasciarono attonito l’uditorio dell’Academy, per lo più fedele a tali dottrine. Quel giorno, tra il pubblico, sedeva anche il principale bersaglio polemico di Gray: il più noto zoologo americano dell’epoca, nonché suo collega a Harvard, Louis Agassiz. Sostenitore di una teoria della «creazione multipla» che sintetizzava catastrofismo cuvieriano e morfologia idealistica, Agassiz – che Gray riteneva «teistico fino all’eccesso»[7] – era convinto che tutti i gruppi biologici siano uniti in una «connessione ideale» nella «mente del Creatore», e che il «piano di creazione» non sia l’effetto dell’«azione necessaria di leggi fisiche», bensì «la libera concezione dell’Intelletto Onnipotente, maturato nei suoi pensieri prima che si manifestasse in forme esterne tangibili»[8].
Anche Gray partiva, come Agassiz, da posizioni creazioniste. Nei primi anni Cinquanta dell’Ottocento si definiva un «orthodox presbyterian»[9]. Persuaso dell’esistenza di un «piano» in natura (nel quale rientravano anche le similitudini riscontrabili nella flora di zone geografiche distanti tra loro), egli rifiutava l’idea della trasformazione delle specie, ritenendo la species question una sorta di terra incognita per l’indagine scientifica[10], come dimostrano anche le sue critiche all’«ipotesi dello sviluppo» resa popolare dal giornalista scozzese Robert Chambers nel suo volume Vestiges of the natural history of creation, uscito anonimo nel 1844[11].
Gli scritti di Gray risalenti alla seconda metà degli anni Cinquanta, coevi all’inizio della corrispondenza con Darwin, testimoniano un significativo cambiamento di vedute. Pur rimanendo fedele all’idea della «creazione singola» – per la quale «piante e animali sono stati prodotti dal fiat dell’Onnipotente»[12] –, egli riteneva ora, sulle orme di Tommaso d’Aquino, che la creazione non escludesse «ciò che chiamiamo cause secondarie»[13], e ammetteva la possibilità di una «creazione intermedia», concepibile in termini «completamente teistici», in virtù della quale nuove specie possono prodursi anche senza l’intervento diretto del Creatore[14]. Tale concezione apriva le porte all’ipotesi dell’«origine derivativa delle specie»[15] e, dunque, a una possibile spiegazione dei fenomeni biologici in base alla teoria della selezione naturale.
- Il confronto Darwin/Gray sulla species question tra il 1855 e il 1859
Un primo, fugace incontro tra Darwin e Gray avvenne nel 1839 tramite un amico comune, il botanico Joseph Dalton Hooker. L’incontro non lasciò un ricordo vivido in nessuno dei due[16], mentre le cose andarono diversamente dodici anni più tardi, quando Gray giunse a Londra per visitare la Great Exhibition. Hooker approfittò dell’occasione per invitare entrambi i suoi amici a un lunch presso la sua casa di famiglia a Kew, quartiere alla periferia occidentale di Londra, dove suo padre William lavorava come direttore dei locali Royal Botanical Gardens[17]. Sotto la direzione di William Hooker l’orto botanico di Kew, che copriva una superficie di 130 ettari e comprendeva un Museum of economic botany e un herbarium in continua espansione, divenne il più celebre centro di esposizioni e studi botanici d’Inghilterra[18]. A pochi passi da questo eden della biodiversità botanica, nella villa degli Hooker[19], nacque il duraturo sodalizio tra Darwin e colui che sarebbe diventato, nel giro di pochi anni, il più grande divulgatore del darwinismo negli Stati Uniti d’America.
Dopo l’incontro a Kew il nome di Darwin cominciò a comparire con frequenza nella corrispondenza di Gray e Hooker[20]. Nel mese di marzo del ’55 Darwin, interessato a catalogare le «specie naturalizzate» degli Stati Uniti, chiese in prestito a Hooker uno dei manuali di botanica di Gray[21]. Nel corso del mese successivo, per sciogliere alcuni dubbi sulla terminologia impiegata da Gray in alcuni punti del suo volume, decise di scrivergli. Risale all’aprile del 1855 la prima lettera nella quale Darwin pose all’amico americano alcuni «quesiti botanici»[22], e che inaugura una corrispondenza che avrebbe coperto circa tre decenni, contando oltre trecento lettere. In queste lettere i temi fondamentali della species question che i due studiosi affrontano sono intrecciati saldamente a un’altra questione cruciale, ovvero se i processi evoluzionistici possano essere considerati il prodotto di un design divino.
A partire dal 1855 anche Gray entrò a far parte della cerchia di confidenti coi quali Darwin era solito confrontarsi in merito alle teorie che stava elaborando per il suo «big book on species», Natural selection, destinato a rimanere inedito fino al secolo successivo, e del quale The origin of species rappresenta una “sintesi”[23].
Darwin offrì a Gray il primo resoconto dettagliato delle sue teorie in una lettera del settembre 1857. Esito dei lunghi studi condotti sui cirripedi e sui piccioni, questo resoconto era ampiamente ispirato anche ai lavori di Gray sulla divergenza ecologica, la distribuzione delle piante e le statistiche comparative dell’incidenza di varietà e specie nei diversi generi[24].
Quando, intorno alla metà di giugno del 1858, Darwin ricevette una lettera dal giovane biogeografo gallese Alfred Russel Wallace, a quei tempi field researcher in Indonesia, non nascose la sua preoccupazione. La lettera conteneva un saggio sulla modificazione delle specie nel quale Wallace descriveva un meccanismo simile a quello della selezione naturale. Darwin temé immediatamente che le tesi del giovane collega sulla «tendenza delle varietà a separarsi indefinitamente dal tipo originario» potessero costituire una minaccia all’originalità delle sue scoperte. Queste ultime, infatti, seppure note a una cerchia ristretta di amici e corrispondenti, e pur essendo già organizzate in forma scritta nei celebri sketches del 1842 e del 1844[25], non figuravano ancora in alcuna pubblicazione ufficiale. Hooker e il geologo Charles Lyell, entrambi scienziati linneani ed entrambi testimoni del lavoro che Darwin stava compiendo da anni sulla species question, messi al corrente dell’accaduto, decisero di proporre alla Linnean Society, per la prima data disponibile – quella del primo luglio del ’58 – una presentazione dello scritto di Wallace e di un saggio nel quale Darwin avrebbe dovuto sintetizzare i risultati delle sue ricerche. Della nozione di divergenza, che Wallace discuteva nel suo saggio e che costituirà uno dei capisaldi de L’origine delle specie, non si trovava però traccia negli sketches di Darwin. Nel tentativo di rivendicare la piena autonomia del principio di divergenza darwiniano, e considerata l’imminenza della riunione della Linnean Society, si decise di accludere al saggio di Darwin l’unico testo scritto nel quale egli aveva descritto diffusamente questa nozione, e cioè il testo della lettera che aveva inviato a Gray nel settembre dell’anno precedente.
Il contenuto di questa lettera, che descriveva i «mezzi attraverso i quali la natura crea le sue specie»[26], aveva, a suo tempo, suscitato non poche perplessità in Gray[27]. Questi ne aveva condannato la logica «fortemente induttiva», mostrandosi, inoltre, scettico nei confronti del termine impiegato da Darwin per designare il principale agente dei processi della modificazione delle specie, la selezione naturale[28]. In queste critiche si scorgono le pietre fondative della sintesi che Gray avrebbe operato tra le dottrine darwiniane e l’argument from design, interpretando i processi evoluzionistici come lo svolgimento di un piano divino[29]. Per il botanico di Harvard la selezione naturale «non è in disaccordo con la teologia naturale», come recita significativamente il titolo di un suo pamphlet del 1861 che raccoglie le prime riflessioni in lui suscitate dalla lettura di The origin of species.
- «La selezione naturale non è in disaccordo con la teologia naturale»: un’interpretazione «teistica» di The origin of species
Gray lesse The origin of species poco dopo la sua pubblicazione, nel dicembre del ’59, mettendosi sollecitamente all’opera per divulgarne i contenuti. Dopo pochi mesi comparvero, anonime, sull’«American Journal of Science and Arts»[30] e sull’«Atlantic Monthly»[31], alcune sue recensioni del volume, che Darwin recepì con grande entusiasmo, al punto da ammettere la sua impressione che Gray conoscesse The origin quanto lui stesso[32].
Per Gray in The origin era implicita «una visione teistica della natura»[33], in base alla quale la storia della vita sulla terra può essere interpretata come il progetto di un Creatore che ha previsto tutte le possibilità fisiche di ogni minimo dettaglio del mondo, realizzando intenzionalmente gli adattamenti naturali che oggi abbiamo di fronte[34]. L’universo non poteva che essere stato «progettato», essendo «semplicemente inconcepibile» l’idea di un «universo fortuito»[35].
Darwin era consapevole dei problemi connessi a una concezione della natura come frutto del design di un «Dio benefico e onnipotente». In The origin aveva descritto “l’altro volto” della natura «splendente di gioia»[36], quello, cioè, che diviene manifesto nella lotta per l’esistenza[37], e sembrava addirittura aver proposto una visione ottimistica della lotta, scrivendo: «possiamo consolarci con la piena fiducia nel fatto che» essa «non è incessante, che non fa paura, che la morte in genere è veloce e che i vigorosi, i sani e i felici sopravvivono e si moltiplicano»[38]. Tuttavia – e pur ammettendo che le idee espresse in The origin non erano «necessariamente atee»[39] – egli riconosceva di essere «disorientato» dall’immagine del Creatore benevolo proposta da Gray:
non posso persuadermi che un Dio benefico e onnipotente abbia creato gli icneumonidi in virtù di un progetto, con l’espressa intenzione di farli nutrire all’interno dei corpi vivi dei bruchi […]. Non vedo alcuna necessità di credere che l’occhio sia stato progettato espressamente […]. Sono incline a guardare tutto ciò come il risultato di leggi progettate [designed laws], i cui dettagli, sia buoni che cattivi, sono lasciati all’operare di ciò che potremmo chiamare caso […]. Il fulmine uccide un uomo, sia egli buono o cattivo, in virtù dell’azione eccessivamente complessa di leggi naturali […] e io non vedo alcuna ragione del perché un uomo o un altro animale non possa essere stato originariamente prodotto da altre leggi; e che tutte queste leggi possano essere progettate espressamente da un Creatore onnisciente che prevede ogni evento e conseguenza futuri. Ma più ci penso, più mi sento disorientato[40].
Persuaso che il progetto divino abbracciasse sia gli aspetti «generali» che quelli «particolari» dell’universo[41], Gray insisteva, nelle sue recensioni, sulla «contraddizione» presente nella dottrina darwiniana: da un lato Darwin attribuiva alle leggi della natura un carattere «generale» e «progettato», mentre, dall’altro, negava che le conseguenze di queste leggi potessero essere concepite come parte di un design. I dettagli, i «particolari» della natura emergevano, insomma, come «conseguenze non progettate» [undesigned results] di leggi «progettate»[42]. Darwin tornò nuovamente sulla questione per dimostrare a Gray l’insostenibilità della teoria del design.
Ancora una parola – gli scrisse – sulle “leggi progettate” e i “risultati non progettati”. Se vedo un uccello che voglio mangiare, prendo il mio fucile e lo uccido, io lo faccio secondo un progetto [designedly]. Un brav’uomo innocente sta sotto un albero e viene ucciso da un fulmine. Voi pensate […] che Dio abbia ucciso quest’uomo intenzionalmente [designedly]? Se credete così, credete che, quando una rondine cattura un moscerino, Dio ha progettato che quella particolare rondine dovesse catturare quel particolare moscerino in quel particolare momento? Io credo che l'uomo e il moscerino siano nella stessa situazione. Se né la morte dell'uomo né quella del moscerino sono state progettate, non vedo alcuna valida ragione per credere che la loro prima nascita o produzione debbano necessariamente essere state progettate[43].
Pur mantenendo un atteggiamento di cauta epoché rispetto alla prospettiva teistica di Gray, fu Darwin stesso a premere affinché le recensioni comparse sull’«Atlantic Monthly» venissero pubblicate l’anno seguente – e a sue spese – in un piccolo volume dal titolo Natural selection not inconsistent with natural theology[44], di cui curò personalmente la distribuzione. Egli si attivò energicamente per promuoverlo: ne inserì una vistosa réclame nella terza edizione di The origin che intanto andava in stampa, ne spedì diverse copie ai suoi corrispondenti e si raccomandò a Hooker di diffonderlo in ogni modo possibile[45]. Considerato lo zelo di Darwin nel pubblicizzare il volume, e il suo riserbo sia sull’esserne stato il principale finanziatore, sia sul suo sostanziale disaccordo con le tesi di Gray, non risulta difficile credere che la sua sia stata una mossa abilmente studiata. Il suo scopo era, probabilmente, quello di avvicinare senza troppa ostilità a The origin anche il pubblico cristiano[46], influenzato negativamente dalle severe critiche che l’opera stava ricevendo da Agassiz, il quale l’aveva stigmatizzata, senza troppi giri di parole, come un «errore scientifico, falsa nei fatti, non scientifica nel metodo e tendenzialmente dannosa»[47].
Per conciliare la «nuova ipotesi dell’origine derivativa delle specie attuali» con le «cause finali e il design», Gray aveva ipotizzato che le variazioni organiche procedessero «lungo linee benefiche»:
fin quando le forme naturali […] ordinate e adattate suggeriscono un progetto, e almeno fin quando la causa fisica della variazione è totalmente ignota e misteriosa, dovremmo consigliare a Darwin di assumere, nella filosofia della sua ipotesi, che la variazione sia stata condotta lungo certe linee benefiche. I corsi d’acqua che scorrono su un piano inclinato per via della forza di gravità (ecco la controparte della selezione naturale) possono aver eroso i loro canali attuali col loro stesso flusso; tuttavia i loro corsi particolari possono essere stati assegnati, e, laddove si vede che formano linee d’irrigazione definite e utili in un modo che non è spiegabile in base alle leggi della gravitazione e della dinamica, dovremmo credere che quella distribuzione sia stata progettata[48].
Darwin aveva definito «due to chance» l’insorgenza delle variazioni organiche che dà avvio ai processi evolutivi[49], in relazione al fatto che ne ignoriamo le cause precise. Tale ammissione giocava, secondo Gray, proprio in favore dell’ipotesi del design. Per Gray il progetto divino – la cui prova è costituita dall’«adattamento allo scopo»[50] degli organismi – tocca ogni dettaglio dello sviluppo temporale del mondo[51]. In esso, dunque, nulla è lasciato al «caso», e men che meno le variazioni. Ma se si ammette che queste ultime seguono delle «linee benefiche» stabilite ab origine, e che quindi sono un mezzo per gli scopi che il Creatore realizza attraverso le leggi dell’evoluzione[52], gli organismi appaiono, in qualche modo, “predestinati” ai loro adattamenti attuali. A tale proposito è stato osservato che, con l’analogia dei corsi d’acqua, Gray introduce nella sua teoria alcuni elementi propri della dottrina calvinista, presentando la creazione delle specie come una sorta di dottrina della «predestinazione naturale»[53].
Nel IV capitolo di The origin of species Darwin aveva chiarito l’inconciliabilità del criterio utilitaristico in base al quale opera la selezione naturale con qualsivoglia visione provvidenzialistica: il processo selettivo non può essere concepito come parte di un progetto volto a favorire e beneficare tutte le specie, dal momento che implica competizione, dolore ed estinzione[54]. Le argomentazioni di Gray, dunque, non potevano che apparirgli problematiche, poiché riguardavano questioni per lui totalmente estranee all’«ambito dell’intelletto umano»[55] quali il rapporto tra necessità e libero arbitrio, l’origine del male in relazione all’onniscienza divina[56] e la predestinazione[57].
Pochi mesi dopo la pubblicazione di Natural selection not inconsistent with natural theology, Darwin confessò a Lyell il suo disappunto nei confronti dell’analogia dei corsi d’acqua di Gray, ammettendo che lo spirito col quale quest’ultimo affrontava la species question gli richiamava alla mente «lo stadio teologico della scienza» descritto da Comte[58].
- Gray sulla “teleologia” delle orchidee
Sul finire del 1861 Darwin scrisse a Gray di trovare «incredibilmente assurdo» credere che un’orchidea «sia stata creata come la vediamo oggi», poiché ogni sua parte rivela una complessa stratificazione di modificazioni[59]. Nel corso dei suoi studi sulla fecondazione delle orchidee, Darwin era rimasto colpito dal fatto che gli «stratagemmi» [contrivances] mediante i quali le orchidee assicurano la propria sopravvivenza si erano prodotti attraverso molte modalità alternative. Esito di questi studi, uscì, nel maggio del 1862, On the various contrivances by which british and foreign orchids are fertilized by insect[60], sulla simbiosi delle orchidee, i loro co-adattamenti e gli insetti da cui vengono fecondate[61]. Darwin dimostrava che le parti di cui queste piante sono composte sono il risultato di un lungo processo contingente. Egli aveva scoperto non solo l’intima relazione tra la struttura della pianta e i suoi specifici insetti impollinatori, ma anche che ogni specie presenta delle piccole variazioni il cui scopo è quello di favorire l’attrazione, l’ingresso e l’uscita di questi insetti: gli organi fondamentali dell’orchidea sono mutati nel tempo per servire nuove funzioni[62], e quelli che possono apparire dettagli strutturali insignificanti, sono, in realtà, i mezzi rivelatisi più utili alla sopravvivenza della pianta[63].
Oltre alla sua rilevanza sul piano scientifico e metodologico, il volume sulle orchidee assumeva anche un importante significato filosofico. L’analisi dei «meravigliosi stratagemmi» [beautiful contrivances[64]] attraverso i quali le orchidee vengono fecondate sferrava un duro colpo alla nozione di teleologia nel mondo organico. Svelando che la natura aveva raggiunto «lo stesso scopo generale» – la fecondazione delle orchidee – mediante un’«ampia diversità di strutture»[65], essa indicava che le specie non possono essere il prodotto di un design intelligente: un Dio con un progetto avrebbe creato immediatamente degli adattamenti perfetti anziché rimaneggiarli in continuazione nel corso del tempo[66].
Nel generalizzare il principio dei riadattamenti, affermando che quasi ogni parte di ciascun essere vivente è servita, in tempi passati, ad altri scopi, Darwin usava un linguaggio «radicalmente alternativo»[67] rispetto a quello della teleologia. Quando si riferiva alle idee di scopo [purpose] delle strutture delle orchidee, o impiegava il termine «contrivances» caro alla tradizione della teologia naturale[68], egli si richiamava, sì, al campo semantico della teleologia, ma si trattava, chiaramente, di una «teleologia senza design»[69]. Affermare che un organo possiede una certa funzione – serve a un dato scopo – non equivale a dire che questa funzione presupponga un’«intenzione»[70], cioè che il suo scopo sia stato stabilito prima della sua stessa esistenza. Lo «scopo» delle strutture descritte da Darwin rappresenta, al contrario, un processo aperto fondato sull’insorgenza di variabili non prevedibili[71]. Tuttavia, la spiegazione “teleologica” delle funzioni delle strutture modificate delle orchidee spinse molti lettori del volume a ritenere che in esso si alludesse a una teoria del design. Tra questi anche Gray, il quale, convinto che dietro gli «stratagemmi» delle orchidee si stagliasse proprio quell’«intelligent designer» che il naturalista negava[72], pubblicò due recensioni dell’opera tra il luglio e l’ottobre del 1862[73]. Il professore di Harvard esprimeva la sua gratitudine a Darwin per aver «riportato delle considerazioni teleologiche nella botanica»[74]. Con i suoi studi sulle orchidee, Darwin era diventato, ai suoi occhi, l’indiscutibile campione del connubio tra teologia naturale e scienze della natura[75].
- La variazione tra chance e design: Gray su The variation under domestication
Pur avendo più volte ribadito il suo «disorientamento» di fronte alle implicazioni delle ipotesi di Gray, Darwin non ebbe mai dubbi riguardo al fatto che il botanico si sbagliasse nel supporre che ogni singola variazione fosse stata progettata[76]. Per lui questa supposizione non teneva minimamente in conto di «quale sterminato campo di variabilità non progettata è a disposizione della selezione naturale perché se ne appropri a ogni scopo utile per ciascuna creatura»[77]. All’esplorazione di questo «campo sterminato» Darwin si dedicò negli anni compresi tra la pubblicazione del volume sulle orchidee e il 1868, anno in cui le sue nuove ricerche videro la luce in The variation of animals and plants under domestication[78], che, con le sue meticolose analisi del fenomeno della variazione allo stato domestico, si presentava come un fondamentale complemento delle dottrine di The origin. Se l’intento principale dell’opera era quello di documentare la “plasmabilità” delle specie, uno dei suoi ulteriori obiettivi fu senz’altro quello di dimostrare l’erroneità della teoria di Gray sull’orientamento delle variazioni[79]: il capitolo conclusivo di The variation può essere considerato una reductio ad absurdum di questa teoria[80].
Qui Darwin scrive, parafrasando gli scritti di Gray su The origin of species: «difficilmente possiamo abbracciare la convinzione del professor Asa Gray “che la variazione è stata condotta lungo certe linee benefiche”»[81]. Secondo Darwin supporre che «ogni variazione organica sia stata preordinata dal principio di tutti i tempi», farebbe apparire «superflue leggi di natura» tutti i meccanismi che muovono i processi evolutivi, dalla plasticità degli organismi che porta alle deviazioni di struttura fino al «potere ridondante della riproduzione, che conduce alla lotta per l’esistenza e, di conseguenza, alla selezione naturale»[82]. Se, infatti, il Creatore conosce in anticipo quale delle variazioni verrà selezionata in ogni situazione possibile, se ha già “predestinato” le variazioni al loro specifico adattamento, e se, quindi, queste ultime si presentano come le soluzioni “già adeguate” ab ovo alle richieste dell’ambiente (piuttosto che come la gamma di probabilità biologiche sulle quali interviene successivamente la selezione naturale)[83], il criterio esplicativo della selezione finirebbe con l’apparire superfluo.
Darwin respinge, inoltre, l’idea di Gray che il carattere «accidentale» delle variazioni comprometta la teoria della selezione naturale. Egli propone la metafora di un architetto «costretto a fabbricare un edificio con pietre non tagliate, cadute da un precipizio»[84] per spiegare che «come, nella costruzione di un edificio, le sole pietre o i soli mattoni servono a poco senza l’arte del costruttore, così, nella produzione di nuove razze, la selezione è stata la forza direttiva»[85], anche se la sua «azione dipende da ciò che, nella nostra ignoranza, chiamiamo variabilità spontanea o accidentale»[86].
La metafora dell’edificio di pietre pone l’accento sul fatto che i processi che originano i materiali da costruzione (le pietre, le variazioni) e quelli che hanno a che fare con l’uso che l’architetto (o la selezione) fa di questi materiali, sono processi del tutto slegati tra loro. A chi sostiene, come fa Gray, che la teoria della selezione naturale è fallace perché fondata sul «caso», Darwin chiarisce, innanzitutto, che l’«accidentalità» delle variazioni non si può definire tale in senso stretto. Definendo infatti «accidentali», «spontanee» o «casuali» le variazioni, si indica soltanto il fatto che ignoriamo la «causa di ciascuna differenza individuale nella struttura di ciascun essere»[87], e non s’intende certo che le variazioni sfuggono in assoluto a delle leggi naturali. Le variazioni, come le forme cangianti delle pietre, «sono determinate da leggi fisse e immutabili; ma esse non hanno alcuna relazione con la struttura vivente [the living structure] che si costruisce lentamente attraverso il potere della selezione, sia essa naturale o artificiale»[88].
Chiarendo che le variazioni cui la sua teoria si riferiva non sono «casuali» in un senso assoluto come le intendeva invece Gray, il quale, in forza di tale assolutizzazione, aveva espresso l’aut aut «la natura è risultato o del progetto o del caso»[89], Darwin faceva cadere proprio questa rigida alternativa che il botanico americano aveva posto alla base delle sue teorie. Egli richiamava l’attenzione su un altro tipo di accidentalità, che definiva «accidentalità in senso stretto»[90], e che riguarda non le cause delle variazioni, bensì il loro scopo, cioè l’uso che ne farà la selezione: è questa tipologia di «caso» a costituire la controparte effettiva dell’ipotesi del design. Appare evidente, infatti, che l’uso di un dato materiale debba essere strettamente «accidentale»: è difficile ipotizzare che Dio abbia assegnato quella forma precisa a quella precisa pietra in vista dell’uso che ne farà l’architetto (o che abbia predisposto quella precisa variazione individuale in quel preciso individuo in vista dell’uso che ne farà la selezione)[91].
Si può sostenere a ragion veduta che il Creatore ha ordinato intenzionalmente […] che certi frammenti di roccia dovessero assumere certe forme in modo che il costruttore potesse innalzare il suo edificio? E […] si può sostenere con maggiore probabilità che egli ha ordinato in modo speciale per l’allevatore ciascuna delle innumerevoli variazioni dei nostri animali domestici e delle nostre piante […]? Egli ha ordinato che il gozzo e le penne della coda del piccione variassero affinché l’appassionato potesse produrre le sue razze bizzarre di gozzuti e pavoncelli?[92].
Non è logico supporre che un creatore onnisciente abbia progettato intenzionalmente le variazioni che creano gli splendidi adattamenti che vediamo in natura, e abbia poi abbandonato tutte le altre (come quelle tramite cui l’allevatore crea un piccione gozzuto) in balìa del caso. Le osservazioni di Darwin toccavano i punti nevralgici dell’ipotesi della compatibilità tra selezione naturale e teologia naturale. Si ripresentava la questione dell’uomo colpito dal fulmine e del moscerino catturato da una rondine: la riflessione sui «dettagli» del progetto divino conduce inevitabilmente verso i territori impervi della predestinazione e del libero arbitrio, nei quali Darwin ribadiva, ancora una volta, di non volersi addentrare[93].
Quando, nel 1868, la rivista «Nation» chiese a Gray di pubblicare una recensione del nuovo volume di Darwin, il botanico riservò per esso un giudizio entusiastico[94]. Tuttavia, egli non era rimasto insensibile alle obiezioni che l’amico gli aveva mosso. A esse rispose, innanzitutto, che l’ipotesi del design non faceva apparire «superflue leggi di natura» le forze che producono la selezione naturale, in quanto «“la sopravvivenza del più adatto”, l’“eccellente coordinazione” e tutto l’armonioso adattamento e la diversità che osserviamo» derivavano, per lui, proprio da quelle forze[95]. Egli contestava, inoltre, la metafora dell’architetto, sostenendo che la selezione naturale non avrebbe dovuto essere rappresentata come un architetto che «sceglie» le pietre per costruire il proprio edificio, dal momento che Darwin aveva escluso dall’azione della selezione naturale qualsiasi forma di design[96].
Poco dopo la pubblicazione della recensione di Gray, Darwin gli scrisse che l’apparente contraddizione della «scelta» dell’architetto derivava dal fatto di non aver sottolineato a sufficienza la distinzione tra selezione naturale e selezione artificiale all’interno della sua metafora. Ciò che aveva voluto affermare con la sua immagine, puntualizzava, era che «in riferimento alla predeterminazione, qualunque cosa valga per la formazione di un colombo gozzuto vale nella formazione delle specie naturali del piccione» e che se si verificano soltanto «le variazioni esatte [quelle «progettate»] e nessun’altra, la selezione sarebbe superflua»[97].
Queste sono tra le ultime battute che i due studiosi si scambiarono sulla possibilità della conciliazione tra selezione naturale e design. Era ormai evidente che tale possibilità, auspicata da Gray, non sarebbe mai stata accolta da Darwin. Nella sua replica Gray ammise:
per quanto riguarda la conclusione del mio articolo […] si vede chiaramente che ero stato messo sulla difensiva da un vostro riferimento a una mia vecchia osservazione azzardata. Trovo la vostra argomentazione della casa di pietre sostanzialmente incontrastabile (perché la nozione di progetto, dopotutto, deve riposare principalmente sulla fede […]): così, tutto ciò che potei fare fu trovare un punto di vulnerabilità nel modo in cui era stata elaborata, sparare il mio piccolo colpo e scappare via nel fumo. Naturalmente comprendo il vostro ragionamento alla perfezione e ne avverto tutto il peso[98].
[1] A. Gray, Diagnostic characters of new species of phaenogamous plants, collected in Japan by Charles Wright, botanist of the U.S. North Pacific exploring expedition with observations upon the relations of the Japanese flora to that of North America, and of other parts of the Northern temperate zone, in «Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences», VI, 1859, pp. 377-452.
[2] Cfr. K-C. Hung, The place that “offers the greatest interest”: Northeast Asia and the making of Asa Gray’s disjunction thesis, in «Harvard Papers in Botany», XV, 2010, pp. 231-276, p. 232.
[3] Cfr. K.W. Hermann, Shrinking from the brink: Asa Gray and the challenge of Darwinism, 1853-1868 (Dissertazione PhD), Kent State University, Kent, OH, 1999 (consultabile al link http://asagrayandcharlesdarwin.com/assets/hermann/), p. 30.
[4] C. Darwin - A. R. Wallace, On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection, in «Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology», III, 1858, pp. 45-62.
[5] A. Gray, op. cit., p. 443.
[6] Ibid.
[7] A. Gray, Darwiniana. Essays and reviews pertaining to Darwinism, D. Appleton & Co, New York 1876.
[8] J.L.R. Agassiz, Contribution to the natural history of the United States (vol. I), Little, Brown & Co - Truebner & Co, Boston - London 1857, p. 9.
[9] J.L. Gray (a cura di), The letters of Asa Gray, 2 voll., Houghton - Mofflin & Co, Boston 1893-1894, vol. II, p. 396.
[10] K-C. Hung, op. cit., p. 243.
[11] Cfr. A. Gray, Explanations. A sequel to Vestiges of the natural history of creation, in «North American Review», LXIII, 1846, pp. 465 ss. Sulle Vestiges of the natural history of creation (John Churchill, London 1844) di R. Chambers si veda J. Secord, Victorian sensation: the extraordinary publication, reception, and secret authorship of Vestiges of the natural history of creation, The University of Chicago Press, Chicago - London 2000.
[12] A. Gray, Darwin and his reviewers, in «Atlantic monthly», VI, 1860, pp. 406-442, p. 406.
[13] Ibid.
[14] Id., Natural science and religion: two lectures delivered to the Theological School of Yale College, Scribners, New York 1880, p. 71. Cfr. A. Maurer, Darwin, Thomists, and secondary causality, in «The Review of Metaphysics», LVII, 2004, pp. 491-514, e J. G. Lennox, The Darwin/Gray correspondence 1857-1869: an intelligent discussion about chance and design, in «Perspectives on Science», XVIII, 2010, pp. 456-479, pp. 459 ss.
[15] Cfr. A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 414.
[16] Cfr. D.M. Porter, On the road to the Origin with Darwin, Hooker, and Gray, in «Journal of the History of Biology», XXVI, 1993, pp. 1-38, p. 9.
[17] Cfr. A. H. Dupree, Asa Gray. American botanist, friend of Darwin, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1988, p. 81 e p. 192; cfr. J.L. Gray (a cura di), The letters of Asa Gray, cit., vol. I, p. 117 e p. 380.
[18] Per la storia dei Kew Gardens si veda L. Parker - K. Ross-Jones, The story of Kew Gardens in photographs, Arcturus Publishing Limited, London 2013.
[19] Cfr. L. Huxley (a cura di), Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker, Macmillan, 2 voll., London 1900, vol. I, p. 170.
[20] D. M. Porter, op. cit., p. 12.
[21] Cfr. F.H. Burkhardt et al. (a cura di), The correspondence of Charles Darwin, Cambridge University Press, Cambridge 1985-, voll.- (d’ora in poi CCD), vol. V, p. 279. Darwin chiede a Hooker il Manual of the botany of the United States di Gray (1848).
[22] CCD, vol. V, p. 322 (lettera del 25 aprile 1855).
[23] C. Darwin, Natural selection, being the second part of his big species book written from 1856 to 1858, R. C. Stauffer, Cambridge 1975.
[24] Cfr. J. Browne, Asa Gray and Charles Darwin: corresponding naturalists, in «Harvard Papers in Botany», XV, 2010, pp. 209-220, p. 212.
[25] F. Darwin (a cura di), The foundations of The origin of species. Two essays written in 1842 and 1844, Cambridge University Press, Cambridge 1909.
[26] CCD, vol. VI, p. 446.
[27] Cfr. P.J. Bowler, Darwin deleted. Imagining a world without Darwin, The University of Chicago Press, Chicago 2013, p. 315.
[28] Le critiche di Gray si deducono dalla lettera di Darwin a Gray del 29 novembre 1857, cfr. CCD, vol. VI, p. 492.
[29] P.J. Bowler, op. cit., p. 14.
[30] A. Gray, [Review of] Darwin’s theory on the origin of species by means of natural selection, in «American Journal of Science and Arts», XXIX, 1860, pp. 153-184.
[31] Id., Darwin on the Origin of species, in «Atlantic monthly», VI, 1860, pp. 109-116 e pp. 229-239; e Id., Darwin and his…, cit.
[32] Cfr. CCD, vol. VIII, p. 106 (lettera del 24 febbraio 1860) e CCD, vol. VIII, p. 298 (lettera del 22 luglio 1860).
[33] A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 412.
[34] S. Thorvaldsen - P. Øhrstrøm, Darwin’s perplexing paradox: intelligent design in nature, in «Perspectives in Biology and Medicine», LVI, 2013, pp. 78-98, p. 83.
[35] A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 416.
[36] C. Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, John Murray, London 1859, p. 79.
[37] Cfr. ibid., p. 62.
[38] Ibid., p. 79.
[39] CCD, vol. VIII, p. 224 (lettera del 22 maggio 1860).
[40] Ibid.
[41] Cfr. A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 409.
[42] Cfr. ibid., pp. 413 ss.
[43] CCD, vol. VIII, p. 275 (lettera del 3 luglio 1860).
[44] A. Gray, Natural selection not inconsistent with natural theology. A free examination of Darwin’s treatise on the origin of species, and of its American reviewers, Truebner & Co, London - Ticknor and Fields, Boston 1861.
[45] Cfr. J. Browne, Charles Darwin. The power of place (volume II of A biography), A. A. Knopf, New York 2002, p. 155.
[46] Cfr. K.W. Hermann, op. cit., pp. 452-454.
[47] J.L.R. Agassiz, [Review of] On the origin of species, in «American Journal of Science and Arts», XXX, 1860, pp. 142-154, p. 154.
[48] A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 414.
[49] C. Darwin, On the origin…, cit., p. 131; cfr., anche ibid., p. 82 e p. 213.
[50] A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 415.
[51] Cfr. S. Thorvaldsen - P. Øhrstrøm, op. cit., p. 87.
[52] Ibid.
[53] Cfr. ibid., p. 92. Cfr. anche B. Sollereder, The Darwin–Gray Exchange, in «Theology and Science», VIII, 2010, pp. 417-432.
[54] Cfr. P. Casini, Darwin e la disputa sulla creazione, Il Mulino, Bologna 2009, p. 102.
[55] Ibid., p. 106 (lettera del 24 febbraio 1860).
[56] Cfr. CCD, vol. VIII, p. 106 (lettera del 24 febbraio 1860).
[57] Cfr. ibid., p. 161 (lettera del 15 aprile 1860).
[58] Ibid., vol. IX, p. 227 (lettera di Darwin a Charles Lyell dell’1 agosto 1861).
[59] Ibid., p. 302 (lettera successiva all’11 ottobre 1861).
[60] C. Darwin, On the various contrivances by which british and foreign orchids are fertilized by insects, and the good effects of intercrossing, John Murray, London 1862.
[61] M.T. Ghiselin, Darwin. A reader’s guide, California Academy of Sciences, San Francisco 2009, p. 23.
[62] Cfr. K. W. Hermann, op. cit., p. 479.
[63] Cfr. ibid., p. 478.
[64] C. Darwin, On the various…, cit., p. 2.
[65] Ibid., p. 286.
[66] Cfr. Hermann, op. cit., p. 489.
[67] T. Pievani, Introduzione a Darwin, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 124.
[68] Cfr. K. W. Hermann, op. cit., p. 477.
[69] Cfr. S. Thorvaldsen - P. Øhrstrøm, op. cit., p. 89.
[70] Cfr. K. W. Hermann, op. cit., p. 490.
[71] B. H. Weber, Design and its discontents, in «Synthese», CLXXVIII, 2011, pp. 271-289, p. 285.
[72] Cfr. CCD, vol. X, p. 292 (lettera del 2-3 luglio 1862).
[73] A. Gray, [Review of] On the various contrivances by which orchids are fertilized by insects, in «American Journal of science and arts, LXXXIV, 1862, pp. 138-144, e Id., Fertilization of orchids through the agency of insects, ibid., pp. 420-429.
[74] Id., Fertilization…, cit., p. 428.
[75] Cfr. ibid., pp. 428-429.
[76] Cfr. CCD, vol. IX, p. 267 (lettera del 17 settembre 1861).
[77] Ibid., p. 162 (lettera del 5 giugno 1861).
[78] C. Darwin, The variation of animals and plants under domestication, 2 voll., John Murray, London 1868.
[79] A. Desmond - J. R. Moore, Darwin (1991), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 627.
[80] Cfr. M.T. Ghiselin, op. cit., p. 34.
[81] C. Darwin, The variation…, cit., vol. II, p. 432.
[82] Ibid.
[83]Cfr. A. La Vergata, Darwin e il caso (articolo online: https://www.spiweb.it/search/darwin+e+il%caso), 2009.
[84] C. Darwin, The variation…, cit., vol. II, pp. 248-249.
[85] Ibid., vol. I, p. 224.
[86] Ibid., vol. II, pp. 248.
[87] Ibid., p. 431.
[88] Ibid., pp. 248-249.
[89] A. Gray, Darwin and his…, cit., p. 415.
[90] C. Darwin, The variation…, cit., vol. II, p. 431.
[91] Cfr. K.W. Hermann, op. cit., p. 552.
[92] C. Darwin, The variation…, cit., vol. II, p.431.
[93] Ibid., p. 432.
[94] Cfr. A. Gray, Review of Variation, in «Nation», VI, 1868, pp. 234-236.
[95] Ibid., p. 236.
[96] Ibid., p. 235.
[97] CCD, vol. XVI, p. 479 (lettera dell’8 maggio 1868).
[98] Ibid., p. 537 (lettera del 25 maggio 1868).