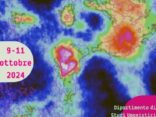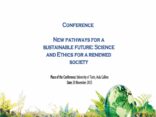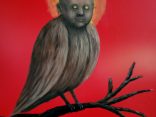Autore
Indice
1. Introduzione
2. Corpo e linguaggio
3. Spazio e movimento
4.Intersoggettività tra evento e memoria: Polemos ed Eros
↓ download pdf
S&F_n. 27_2022
Abstract
Inescapable body: texture and suspension between the self and the world
This paper tries to present the discussion that took place in the International Conference “Merleau-Ponty: Revenir à la Perception”. For this purpose, I have divided the different questions that made up the debate in three macro-thematic areas: body and language, space and movement, intersubjectivity between event and memory. Every macro-area is naturally linked with the others and tries to deliver the actuality of Merleau-Ponty’s thought starting from the analyses proposed during the conference.
Riflessioni sul Convegno Internazionale: “Merleau-Ponty: ritornare alla percezione /Merleau-Ponty:revenir à la perception” - Università degli Studi di Napoli Federico II, 8-9-10 Giugno 2022
- Introduzione
Per tentare di restituire, sottoforma di testimonianza, l’esperienza del convegno internazionale “Merleau-Ponty: Ritornare alla percezione”, tenutosi a Napoli, in Aula Aliotta, dall’otto al dieci giugno, non posso che partire dall’enorme piacere che mi ha accompagnato. E questo per diversi motivi.
Per iniziare, la possibilità di essere fisicamente presente in uno spazio di discussione, tra una costellazione di ricercatori che nel loro vicendevole rapportarsi hanno incarnato quel che per me risulta essere il fondamento e il fine dell’università: incontro, dialogo, crescita nel confronto continuo di saperi.
In secondo luogo – e questo sarà anche motivo di scelta metodologica per la traduzione dell’esperienza – il convegno, strutturato in quattro panel, ha disegnato traiettorie teorico-speculative che nel loro intrecciarsi rendono praticamente impossibile restituire una completa ed esauriente tessitura dei contenuti proposti. Pertanto, scartando l’ipotesi di una cronistoria che nel migliore dei casi risulterebbe forma metodologica inappropriata per l’oggetto in questione, tenterò di inseguire le tematiche affrontate attraverso tre macro-aree, confessando l’impossibilità materiale di una completa restituzione dell’esperienza. Tutto ciò, a mo’ di conferma del tema stesso del convegno: la percezione che, nel suo esser vissuta da un corpo proprio, non troverà mai pace in una definitiva traduzione positivistica bensì, aprendo alla relazione con l’altro, non potrà che ritornare a “bussare” in vista di nuova immersione esistenziale.
Infine, non posso negare la gioia dell’aver incontrato e conosciuto nuove persone che ancora una volta confermano l’impossibilità di far ricerca se non a partire dalla relazione umana stessa in quanto motivo fondante e fondativo di ogni possibile circuito di confronto.
- Corpo e Linguaggio
Aderendo al metodo fenomenologico, in quanto approccio filosofico che ricolloca le essenze nella fatticità dell’esistenza, partirò dalla prima macro-area tematica: l’intreccio tra il concetto di corpo e il concetto di linguaggio in Merleau-Ponty.
Difatti, all’interno dell’architettonica merleau-pontyana, tale intreccio risulta essere il più fecondo per inquadrare il peculiare approccio fenomenologico del pensatore francese e al contempo il versante più delicato.
In vista di un superamento del dualismo cartesiano in cui l’atteggiamento riflessivo vorrebbe separare il soggetto dall’oggetto e il corpo da se stesso, neutralizzando l’ambiguità dell’esistenza, Merleau-Ponty ci dice che «l’oscurità si propaga per l’intero mondo percepito», poiché l’unico modo di conoscere il mondo è vivere il dramma unico che l’io in quanto corpo è.
Il corpo è sempre altro da ciò che è, mai chiuso e mai superato nell’intreccio tra natura e cultura, sessualità e libertà. L’esperienza del corpo proprio è ciò che tiene l’uomo nel tessuto del mondo in quanto non vi è distinzione ultima ma reciproca interrelazione: «il mio corpo proprio è abbozzo provvisorio del mio essere totale».
Nella comprensione dell’uomo nel mondo (che è sempre già là e al contempo messo tra parentesi attraverso il momento dell’epochè fenomenologica) nel ritorno alle cose stesse, vi è la sconfessione di ogni scienza riduzionistico-deterministica. Nel ritorno al mondo anteriore alla conoscenza, la percezione è il corpo vissuto attraverso il quale dallo sfondo si staccano figure, in cui la situazione è l’ambiente proprio dell’umano.
La riflessione, non ritirandosi dal mondo ma attraversandolo, non aspira all’unità della coscienza come fondamento originario in vista di una manomissione degli enti. La presa di distanza dalle cose permette la trascendenza nel rilevare il mondo nella sua paradossalità. Da qui lo stupore, il thaumazein in quanto colpo originario dato dalla percezione del problema.
La percezione, quindi, è possibilità d’accesso al tessuto del mondo di cui il soggetto stesso è parte, tutt’uno con l’oggetto. Lo sguardo, quindi, a cui apre la fenomenologia è l’intenzionalità fungente in quanto unità naturale e ante-predicativa del mondo. Il mondo fenomenologico non è essere puro ma senso che traspare nell’interazione tra i corpi vissuti. Su questo punto è possibile menzionare l’intervento di Antonino Bondi – in quanto espressione di una rilettura semiotica di Merleau-Ponty tra strutturalismo e fenomenologia – che propone una ricostruzione del modello di strutturazione di senso secondo l’ipotesi semiogenetica.
L’uomo è immerso e, al contempo, tessuto del mondo che lo circonda, in quanto la costruzione di significato è intimamente vissuta, i segni-oggetto sono una pulsazione vibrante nella dinamicità soggetto-mondo. Vi è una tensione costante tra la determinatezza degli oggetti e l’indeterminatezza del contesto umano. Il concetto centrale adoperato da Bondi è stato il concetto di motivo e la relazione di motivazione fra corpo, espressione e mondo. Nella continua ritrascrizione ontologico-artificiale tra uomo e mondo vi sono delle trame intenzionali e dei progetti anticipativi che caratterizzano la prassi. La motivazione governa le relazioni percettive e semiotiche fra soggetto e mondo, consentendo di pensare insieme i flussi esperienziali e le forme che s’inanellano in concatenamenti di senso multipli. In una tale ottica, la motivazione descrive una varietà di rapporti che governano i processi di formazione delle esperienze di senso e focalizza le tensioni fra l’indeterminazione delle formazioni allo stato nascente e la loro partecipazione alla costruzione di unità di formato superiore. I motivi costituiscono il modo in cui le forme sorgono da uno sfondo, iscrivendosi in sistemi di valori e significazioni. La motivazione, allora, altro non è che la storia delle riprese che riposa su alcune identità rese temporaneamente stabili, vale a dire i segni in quanto traccia d’iscrizione (mitica, immaginaria, etc.), che danno vita a forme di identità narrativa.
Non a caso il concetto stesso di motivazione, soprattutto nell’incompiuto Le visible et l’invisible, trova riflesso nello scomparire, nell’andare verso l’altro nella trasfigurazione di senso della metafora, nell’iconologia e musicologia.
Percezione-visione-intenzione conformano e alimentano quella dimensione caotica, quel tourbillon nella spazialità avvolgente da cui fluisce il fronte ecosemiotico umano nell’intreccio tra cose del mondo e forme soggettive, o meglio, quell’oscurità che inerisce l’intero mondo percepito di cui parla Merleau-Ponty.
Il fenomeno si dispiega nella relazione con il motivante, la realtà non è causa originaria ma flusso, pluralità di senso, presa del corpo in un campo motivato. Il linguaggio non è referenziale ma intelaiatura socio-emotiva, la percezione è originariamente semiotica.
Su tale versante si ricollega l’intervento di Paolo Missiroli sulla riflessione antropologica contenuta nella Fenomenologia della percezione attraverso le nozioni di apertura ed espressione. Secondo tale prospettiva, Merleau-Ponty supererebbe la concezione inizio-novecentesca dell’uomo in quanto essere manchevole, consegnato alla “sprovvedutezza morfologica” nella polarizzazione del negativo psico-fisico. Il riferimento principale per questa rilettura merleau-pontyana risulta essere la psicologia della Gestalt: l’uomo si risolve nell’espressione e al contempo è espressione di un qualcosa, di un silenzio primordiale che viene spezzato dalla voce, dal gesto espressivo che non può esser ricondotto a una sommatoria facente capo a un totale, ma la forma stessa del gesto sonoro è più del totale traducibile in segni. Da questo punto di vista, la questione del negativo e della distanza può trovare la propria declinazione in una concezione d’esistenza che trova nel paesaggio del mondo quell’inoggettivabile di cui il corpo stesso è espressione ultima e mai ultimata nel movimento di “sfuggimento” del soggetto da se stesso.
L’alterità, quindi, tanto nel/del corpo, tanto nel/del linguaggio, non viene sottomessa in quanto negativo fondamento della risoluzione ma riporta alla riflessione in quanto mistero del mondo, in un “movimento di meditazione infinita” per riprendere le parole dello stesso Merleau-Ponty.
La percezione, pertanto, non è somma di sensazioni discrete ma struttura. Il testo del mondo esterno è squarciato e ricostituito di volta in volta nella coscienza intenzionale, nelle forme, nei gesti e nei segni. L’esperienza sensibile, quindi, «è un processo vitale tanto quanto la procreazione», così come scritto nella Phénoménologie de la perception.
L’unità del mondo non è costruita per associazione ma è condizione di percezione. Ogni sentire è comunicazione vitale con il mondo, tessuto intenzionale. Il primo atto filosofico, allora, consiste nel ritornare al mondo vissuto al di qua dell’oggetto: io-altro-mondo, ecco il campo fenomenico. L’immediato è la struttura in cui soggetto e oggetto sono tutt’uno. Il corpo è veicolo primo di rapporto al mondo, al contempo ciò che più è proprio e ciò che incarna l’irriducibilità del patto costitutivo tra il visibile e l’invisibile, le zone d’ombra da cui emerge ogni determinazione mai definitiva.
- Spazio e Movimento
A questo punto è possibile affrontare la seconda macro-area tematica.
La spazialità, così come concepita da Merleau-Ponty, è reciproca flessione dello schema corporeo nell’unità spazio-temporale del corpo proprio come termine terzo sospeso tra figura e sfondo. La significazione è data dal corpo nel rimando tra sensibilità e significato, struttura e forma, fisiologia e psicologia. Il corpo è nucleo significante, nodo tra esistenza ed essenza, tra io e mondo.
Il filosofo francese, sulla scia della prospettiva inaugurata da Kant nella correlazione tra fenomeno e condizioni di manifestazione, dà primato alla relazione per arrivare all’immediato, in una circolarità che nel partire dalla fatticità vi ritorna decostruendo i due approcci apparentemente antitetici di razionalismo ed empirismo. In una tale ottica, la conoscenza non è altro che emergenza e oblio tra sfondi e figure: è l’orizzonte indeterminato ad assicurare le identità.
Nella struttura oggetto-orizzonte la temporalità è flusso, rete, melodia, in cui vi è un unico momento: la durata. Non c’è successione riorganizzativa di causa ed effetto secondo linearità.
Il problema sta nell’unità relazionale, vi è un avvilupparsi reciproco tra io e mondo, la significazione è immanente al sensibile che va a significare, così come lo spazio è intreccio continuo al movimento.
L’analisi della parola e dell’espressione, che ci fa riconoscere la natura enigmatica del corpo proprio in cui l’umano è connaturato all’artificio originario della potenza originaria da cui deriva, è essa stessa movimento fonetico. Strutturazione simultanea di corpo, emozione ed espressione, spazio e tempo. Il mondo linguistico e intersoggettivo non è distinto dal mondo, è il mondo stesso, ciò che lo tiene insieme è il movimento. L’intenzione significante, come il corpo, è una mancanza che cerca di colmarsi al pari del gesto e del movimento che cerca l’equilibrio perduto del silenzio primordiale.
Lo schema corporeo, quindi, è l’unità spaziale e temporale, l’unità senso-motoria del corpo. Non è il semplice risultato delle associazioni stabilite nell’esperienza ma una presa di coscienza della postura nel mondo intersensoriale, una “forma” ancora una volta nel senso della Gestaltpsychologie. Lo schema corporeo è dinamico poiché sempre in situazione. Il corpo è il terzo termine sottinteso tra figura e sfondo attraverso cui il movimento fonda lo spazio, così come indicato da Prisca Amoroso. La simultaneità mondo-io trova nell’infanzia quella correlazione confusa tra sfondo e figure, quel contatto ingenuo, in cui il corpo risulta inaggirabile. Come a dire che ogni successiva fase socio-pedagogico-culturale interposta tra l’indistinto mondo-io e la significazione non potrà che portar con sé quell’irriducibile che il corpo stesso incarna.
Su questo punto è possibile riprendere le parole di Andrea Pace Giannotta in merito alla co-emergenza di corpo e mondo nell’ontologia della carne concepita da Merleau-Ponty. Difatti, ne Il visibile e l’invisibile, il filosofo francese approda a una concezione del carattere fenomenico della percezione al di là dell’alternativa tra internalismo ed esternalismo. Secondo tale analisi, al cuore del processo percettivo vi è una dimensione qualitativa che precede la distinzione tra soggettività e oggettività e che, piuttosto, si colloca alla base della loro genesi comune. Merleau-Ponty individua la carne come dimensione ontologica fondamentale che è all’origine dell’intreccio chiasmatico tra soggetto e oggetto, interno ed esterno, mente e mondo, spazio e movimento. Ogni metafisica della sostanza viene messa in scacco da una metafisica della corporeità, o meglio da una filosofia del processo, in cui la percezione rifluisce in un rimando di eventi e flussi di qualità non discrete, avvicinandosi alla teoria del monismo neutrale.
- Intersoggettività tra Evento e Memoria: Polemos ed Eros
In quest’ultima sezione il focus verterà sul confluire intersoggetivo tra corpo proprio e corpo altrui, o meglio, tra l’originario tessuto che inerisce il corpo al mondo, l’io al non-io, l’individuo alla società e in ultimo, l’amante all’amato. I concetti di polemos ed eros, riflettendosi nella questione di evento e memoria, riemergono, nel loro inscindibile legame, in quanto punto di raccordo delle riflessioni di cui è andato componendosi il convegno. Su questo versante, non è un caso che il paragrafo conclusivo della Fenomenologia della percezione sia proprio intitolato “la libertà”.
Per Merleau-Ponty ogni uomo, immergendosi nel mondo, assume la propria situazione in cui il concetto stesso di libertà è impigliato “nelle contraddizioni dell’impegno”.
Ed è proprio in questa sovrapposizione tra impegno e libertà che va a inserirsi l’intervento di Chiara Palermo su «la memoria del corpo: percezione e storia in Merleau-Ponty e Kader Attia».
La dimensione sociale e politica del corpo vissuto trova nella ferita e nella deformazione fisica proposta da alcune opere di Kader Attia la propria materializzazione. L’artista, infatti, sembra adoperare i materiali e le tecniche produttive in vista di una terapia circa la memoria collettiva della coscienza occidentale, non volendo tradire il rimosso psichico che contraddistingue l’individuo cosiddetto civilizzato. In Kader Attia la riparazione è fuoriuscita dal regno animale. Il corpo vissuto del sociale è la storia in quanto attestato di reciproca fallibilità, tanto del corpo proprio quanto dell’impegno. Il divenire che si manifesta nel turbinio della storia, per riprendere un’espressione benjaminiana, non può accettare la propria condizione al pari dei soggetti affetti dalla sindrome dell’arto fantasma. In tal senso, Merleau-Ponty, rifiutando una visione idealistica della storia, non può che toccare con mano l’esperienza della clinica, in quanto storia materiale e resoconto dei traumi scanditi dall’esistenza.
La storia clinica allora, in quanto riflesso della storia occidentale, risulta nient’altro che confessione di un passato che non decide a farsi tale, ma a ripetersi e proliferare in quanto eterno presente.
Su questo tema si riallaccia l’intervento di Gael Caignard circa le riflessioni di Merleau-Ponty sulla storia e “le piège de l’événement”.
Il filosofo francese, difatti, prendendo le distanze dall’approccio engagé di stampo sartriano, tentò di disinnescare la trappola dell’evento alimentata dall’estrema vicinanza tra la percezione dell’evento storico e il dibattito conseguente. Il nesso tra funzione percettiva e riflessione, nell’ottica merleau-pontiniana, è intimamente legato. L’estrema visibilità dell’evento ne nasconde la fatticità, l’essenza. In tal senso, in continuità con le analisi di Merleau-Ponty, eventi come l’11 Settembre o la pandemia di SARS-CoV-2 ci restituiscono la problematicità del riflettere la storia nell’eccesso di prossimità all’evento, seppur nell’ossimoro di una distanza incolmabile: eco ultima del corpo vissuto nella propria sospensione tra evento e memoria.
Proprio a partire da questa sospensione, l’intervento di Salvatore Prinzi tenta di restituire Merleau-Ponty al proprio vissuto biografico, scandito dalle due Guerre mondiali, la resistenza francese, la Guerra fredda e la decolonizzazione. La guerra, difatti, ha occupato un posto dirimente nello sviluppo delle riflessioni del pensatore francese che, come accennato, spingono in direzione di una filosofia della coesistenza che faccia i conti con le contraddizioni dell’impegno. La libertà, al pari del corpo vissuto, non può essere una sommatoria di organi/azioni ma una struttura di inerenza al mondo, così come la società non può essere spartizione di campi dualisticamente intesi così come vorrebbe ogni propaganda bellica.
Infine, sempre in un’ottica di superamento del dualismo cartesiano, che tutt’oggi si ripercuote tanto sul campo di guerra tanto negli ambiti di ricerca universitari, mi trovo “obbligato” a concludere su quello che è il più scivoloso dei temi, oltre che il più singolarmente vissuto: l’eros. Accentratore di energie sociali e sublimazione in senso freudiano, il rapporto amoroso risulta ciò che più interessa la dimensione sociale nel proprio legame tra singolarità. L’individuo, in vista di un riconoscimento mai sazio, poiché senza fondamento, sembrerebbe vivere la propria esperienza amorosa in un intraducibile che egli stesso riconosce. O meglio, un inoggettivabile che spererebbe di non oggettivare mai fino in fondo.
Riprendendo l’intervento di Andrea Nicolini, quindi, è possibile ritrovare nella letteratura, e in special modo in Marcel Proust, la forma estetica che più si avvicina al concetto di “carne viva nell’invisibile” così come concepito da Merleau-Ponty.
L’esistenza individuale è rifrazione singolare del mondo verso se stesso. L’altro, l’amato, è l’invisibile in quanto piega del visibile enigmatico. Ed è proprio questo volto, il volto dell’amato, in cui la letteratura esplora la prossimità vertiginosa con l’essere secondo il senso merleau-pontyano: un volto, al contempo fatto di carne e di forme, che nel proprio ritornare sempre non torna mai.
Con la letteratura si tratta di trafiggere la carne in un logos selvaggio: contingenza e scontro. L’amato è immanenza della pelle e, al contempo, trascendenza dell’amore. Il volto continua a sfuggire nella menzogna della memoria in quanto riflesso dell’amore. Finché il corpo proprio è vissuto nell’altro, l’amato in quanto oggetto non può che corrispondersi al soggetto, in un’evanescenza ontologica che permette l’abbandono dell’evento, e quindi dello spazio, e della memoria, e quindi del tempo. È sulla carne del pensiero, ossia sulla co-implicazione di pensiero ed emozione, che la filosofia troppo spesso ha disertato rispetto alla letteratura.
Le cose, quindi, agli occhi di Merleau-Ponty si presentano irrecusabili. Tanto la persona amata quanto gli schiavi della catena di montaggio occidentale, tanto l’altro dal corpo vissuto quanto il corpo vissuto stesso nella propria irriducibile alterità.
La libertà non può che volersi nell’uscita dalla singolarità.
La filosofia non ha altra funzione che riportarci alle cose stesse, nella loro fatticità. “L’uomo non è che un nodo di relazioni, solo le relazioni contano per l’uomo”.
Commozione, molteplicità intersoggettiva, divenire altro del corpo: riparare le ferite nella contingenza della storia singolare e collettiva, carne e dispersione. Il corpo è un’assenza, una dimensione di fuga, movimento di coesistenza e mai sommatoria di funzioni chiamate organi. La percezione, allora, consegnandoci alla pluralità irriducibile, ci conferma nella resistenza dell’oggetto a ogni determinazione tramite l’assoluto inaggirabile: il corpo.