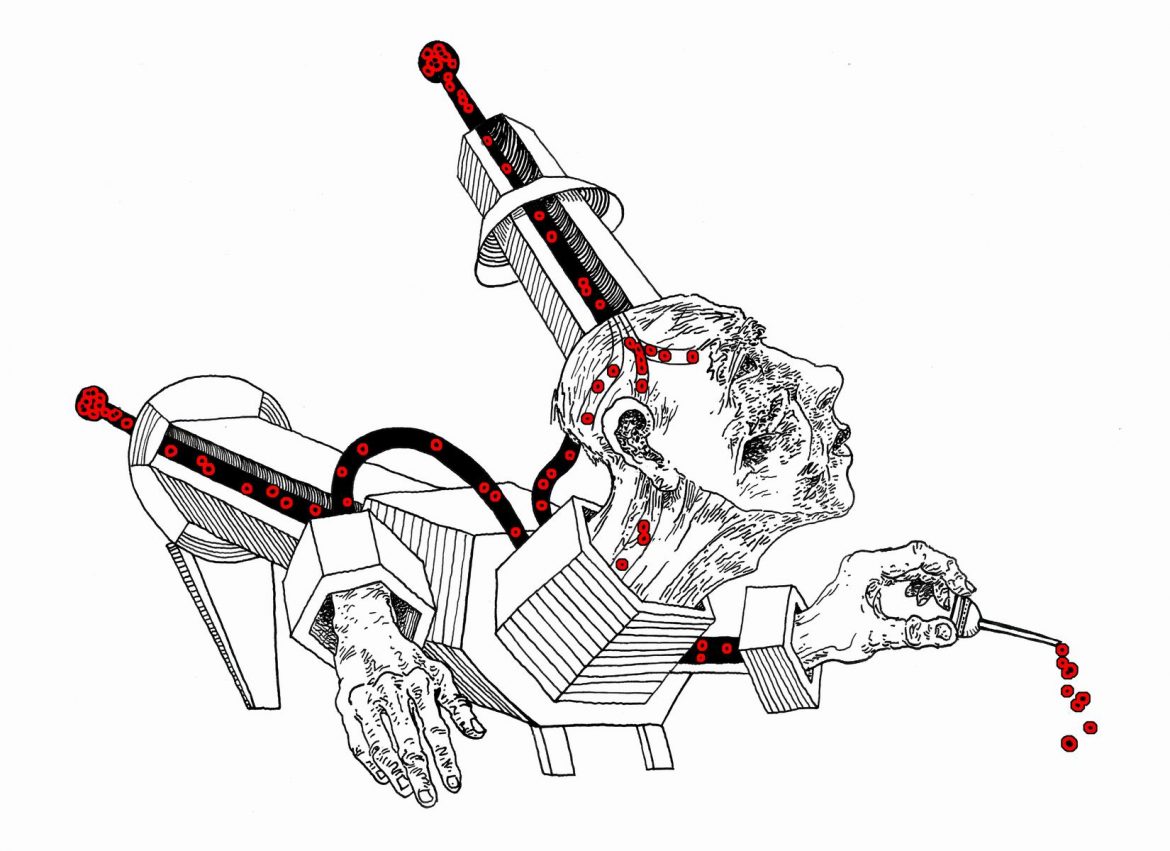Autore
Indice
Abstract
Conversation on Today. Science, Philosophy and Politics for difficult Times
This interview seeks to highlight some of the main characteristics of the new pandemic world, besides the main contradictions the philosophical thought runs into in this difficult time. Between a political world which is unable to react and the scientific world which is usually moved by political aims, this work tries to understand if there is any room for a role of a long range philosophical thought, which is able to defend its clarity prerogatives but it is also able to speak with other disciplines which seem increasingly deafer.
S&F: Professor Zhok, in primis la ringrazio, personalmente e a nome di tutta la redazione di S&F, per aver accettato di rispondere a qualche domanda riguardo il nostro tempo. È un piacere ospitarla in questo spazio.
Partirei in maniera abbastanza ampia, entrando però nel vivo della discussione. Tema: la pandemia da Covid-19.
Vede una “grande trasformazione” in atto nella società occidentale, un “Great Reset”? Pensa ci sia un rapporto tra il modello estrattivista delle economie capitaliste, la logorante antropologia ultra-competitiva del neoliberismo reale e gli eventi cui assistiamo ormai sfiniti dal gennaio 2020? È corretto forse parlare di sindemia biologico-sociale?
A.Z.: Vista la complessità della domanda provo a rispondere schematicamente, e, chiedo scusa in anticipo, in modo necessariamente parziale.
Non credo che la pandemia, che plausibilmente si esaurirà nei suoi principali effetti sanitari nell’anno in corso, sarà in grado di creare significativi mutamenti di costume. Il maggior impatto sociale si avrà nel processo di spostamento di alcune attività lavorative in remoto, spostamento che era già una tendenza in atto, ma che subirà un’accelerazione.
L’impatto più potente invece credo che si avrà a livello geopolitico, su tre piani.
Il primo, quello per noi italiani più visibile, concerne il cambiamento avvenuto nell’Unione Europea con riferimento alla gestione finanziaria dell’eurozona. Fino alla pandemia la linea dominante, alimentata prevalentemente dalla Germania, era stata quella di utilizzare politicamente senza remore la leva dei debiti pubblici per imporre un modello di sviluppo tutto orientato alle esportazioni. Questo modello, votato a ottenere crescita economica attraverso una bilancia commerciale in costante attivo, dava benefici ai paesi più competitivi, ma creava tensioni con gli USA e obbligava a un forte contenimento del monte salari nell’eurozona. Questo modello dipende naturalmente da una scelta politica, non da qualche ferrea legge economica; esso è ciò che motivava le politiche austeritarie imposte fino a inizio 2020. Il modello esigeva inflazione minima, per avere una valuta stabile negli scambi internazionali, contenimento della spesa in deficit (anche per investimenti), compressione delle condizioni del lavoro (sia a livello di diritti sociali che sul piano salariale). L’idea è che la riduzione dei consumi all’interno viene più che compensata dall’aumento delle esportazioni. Fino a un anno fa aderire a questo modello, monetarista e mercantilista, corrispondeva all’europeismo reale (in concreto, al netto di ogni illusione). Ogni pretesa di spesa pubblica, incluse le operazioni anticicliche, era subordinata a controlli centrali draconiani, che utilizzavano il ricatto dello “spread”, fatto passare per puro gioco dei “mercati”, estraneo alle facoltà di controllo della finanza pubblica. Si diceva (e ancora oggi c’è chi insiste con questa leggenda) che le politiche troppo espansive fossero inesorabilmente punite dai “mercati” (il cosiddetto “vincolo esterno”). In verità la minaccia rappresentata dagli “umori dei mercati” poteva essere esercitata soltanto in presenza di una BCE accondiscendente, visto che era in suo potere sterilizzare qualunque esplosione dei tassi di interesse sul debito. Questa verità – ideologicamente negata a lungo – aveva cominciato a fare breccia con il “Whatever it takes” di Draghi, che aveva spento immediatamente ogni speculazione sui tassi di interesse. Con la pandemia questa verità si è affermata in un modo che, per quanto vi si faccia resistenza, difficilmente potrà essere ancora negata: una volta che la BCE ha manifestato l’intenzione di fornire tutta la liquidità necessaria, ogni eventuale iniziativa speculativa era spenta sul nascere, permettendo le politiche espansive di cui si aveva bisogno. Tali politiche, che prima erano politicamente invise ai detentori di capitale in quanto consentivano un ampiamento della spesa pubblica e del perimetro dello Stato, hanno ricevuto legittimazione politica come reazione alla pandemia.
Può essere interessante notare che il rapporto tra debito pubblico e Pil odierno della Francia (120%) è lo stesso che aveva l’Italia nel 2011, quando ci fu il devastante attacco speculativo che molti ricordano, e che portò al governo tecnico di Mario Monti, ma è anche lo stesso rapporto che aveva la Grecia nel 2009, quando iniziò la loro drammatica crisi debitoria, che ha di fatto messo il paese all’incanto. Chiunque qualche anno fa avesse osato dire pubblicamente che un rapporto debito pubblico / Pil al 158% (come quello italiano attuale) sarebbe stato perfettamente sostenibile, in presenza di adeguate politiche della BCE, sarebbe stato messo alla berlina e tacciato di irresponsabilità, follia, analfabetismo funzionale o il cielo sa cos’altro. Tutto questo castello ideologico è andato in fiamme nel momento in cui il Covid ha fatto crescere simultaneamente l’onda debitoria in tutti i paesi. Il gioco ricattatorio precedente ha perso di plausibilità perché non era più possibile additare di volta in volta un singolo paese come “peccatore finanziario” da punire, assoggettandone le politiche con richieste austeritarie e pressioni sulle condizioni del lavoro.
Che questo evento rappresenti un mutamento duraturo, in cui la BCE (contrariamente al suo statuto) esca dal paradigma monetarista e adotti un paradigma keynesiano, è una possibilità, tutt’altro che una certezza. Se dovesse accadere, tuttavia, saremmo di fronte a un evento geopolitico di grande rilevanza, che rimetterebbe l’Europa al centro dello scenario politico internazionale, da dove le politiche miopi degli ultimi vent’anni l’avevano tolta.
Il secondo grande cambiamento indotto dal Covid è stato il blocco della marea montante della globalizzazione economica. La pandemia ha portato a consapevolezza l’iperestensione delle catene di produzione internazionale creatasi con il processo di globalizzazione degli ultimi tre decenni. Il Covid ha esplicitato in maniera plastica i rischi abbinati a tale divisione del lavoro planetaria, e ha segnalato che si è probabilmente arrivati a un punto dove ulteriori passi in questa direzione presentano più costi che benefici. In quest’ottica la spinta globalista relativamente alla produzione dovrebbe uscirne moderata, anche se non credo che assisteremo a una significativa inversione del processo, con un accorciamento delle catene di produzione e un ritorno in patria di produzioni delocalizzate. Diciamo che in tal caso il Covid rappresenterà una presa di coscienza di un limite che era già latente, ma che non aveva ancora incontrato un controesempio sufficientemente potente da modificare gli atteggiamenti di fondo.
Il terzo grande cambiamento è legato ai rapporti di forza internazionali. Dalla vicenda del Covid la Cina emerge sullo scacchiere internazionale come nuovo protagonista mondiale, che ha mostrato rispetto agli USA, l’attuale potenza egemone, di avere maggiori capacità di controllo sia interno che internazionale, maggiore solidità, maggiore capacità di ripresa. Gli USA, al netto della loro perdurante supremazia militare, hanno mostrato profonde crepe interne, e una ridotta capacità di leadership internazionale. La Cina si profila con sempre maggior chiarezza come la principale “storia di successo” di un modello di sviluppo differente da quello liberale, e questo rappresenta sul piano simbolico una minaccia mortale alla narrazione neoliberale, che fa coincidere potenza economica, politica e militare con il paradigma liberal-liberista. È per questo motivo che la Cina è, e sarà sempre di più, il bersaglio privilegiato dei principali media occidentali, filoatlantici.
Questi tre slittamenti (crisi del paradigma neoliberale e monetarista nell’UE, crisi del processo di globalizzazione economica, e crisi della leadership americana) non sono naturalmente “causati” dalla pandemia. La pandemia è però un’occasione che li porta prepotentemente alla luce. Essi sono solo alcuni segni macroscopici di una crisi della modernità liberale (occidentale) che è in movimento da tempo e che presenta numerosi altri aspetti che non sono stati toccati dall’evento pandemico (ad esempio la crisi ecologica). Che questa crisi rappresenti però l’avvio di un superamento del modello è tutto da vedere.
S&F: Tra i grandi dibattiti del nostro tempo pandemico sospeso il presunto scontro tra “no vax” e “sì vax” appassiona molto i media. Secondo lei esiste un legame tra disagio socio-politico e creazione di sacche di resistenza alla ragione scientifica? Mi spiego: sappiamo bene come i media mainstream avallino una quasi perfetta congruenza tra ignoranza/marginalità/disturbi psicotici/complottismo/no vax; ora, siamo davvero in un’epoca di crescente irrazionalismo, o vediamo invece all’opera il solito manicheismo pubblicitario, totalmente incapace di spiegare la complessità dei fenomeni? L’interpretazione mediatica della scienza non prescinde mai dal creare partizioni sottilmente politicizzate, trasformando ogni tipo di dibattito in una divisione tra illuminati e “popolino” e interpretando ogni dubbio come oltraggio di lesa maestà al parere degli “esperti”. Mi chiedo e le chiedo: non è proprio un’interpretazione “religiosa” della scienza – che da ricerca di verità parziali assume caratteri quasi sacrali – a creare le condizioni per un rigetto della stessa? Non è questo un modo per ricreare nuovi e pericolosissimi “apparati di verità ufficiali”? Polarizzandosi su categorie ingigantite ad hoc si vogliono forse creare i presupposti per impedire un dibattito realmente democratico sui punti oscuri del rapporto tra scienza e società?
A.Z.: Il tema dei vaccini anti-Covid, e delle reazioni dell’opinione pubblica, fa vedere in trasparenza un problema epocale, molto complesso, che va ben al di là della questione vaccinale. In una società che si voglia democratica un’attenta cura dell’educazione e dell’informazione sono precondizioni per il suo funzionamento ordinario. Il mondo contemporaneo, sottoposto a potenti accelerazioni tecnologiche e alle interazioni geopolitiche della globalizzazione, è di interpretazione persino più complessa che in passato. Per poter sperare di avere un discorso pubblico all’altezza dei problemi, bisognerebbe poter contare su un livello di formazione e informazione elevato. Ma, come tutti gli indicatori ci mostrano, negli ultimi quattro decenni siamo in una fase di contrazione sia nella qualità della formazione pubblica, sia nella qualità dell’informazione (e nel suo accesso di massa).
In questo quadro si verificano due fenomeni. Da un lato la percezione dell’inaffidabilità della pubblica informazione è esplosa. Anche in passato i grandi media privati e il servizio pubblico erano sempre stati “orientati” su certi temi (ad esempio in termini di anticomunismo e filoatlantismo), ma a quell’orientamento ideologico e definito (in qualche modo, previsto), si è aggiunta dagli anni ‘80 la spinta di mercato alla “vendita” del prodotto informativo. Questo processo, lungi dal qualificare l’offerta, ha trasformato l’informazione in intrattenimento (infotainment). Questa tendenza si alimenta attraverso una preferenza per il rilancio continuo di (presunti) scoop, per l’estremizzazione delle tesi e la loro spettacolarizzazione, volta al rinfocolamento di diatribe personali e duelli mediatici. Così, alle pressioni ideologiche di sostegno agli interessi del capitale (ovviamente presenti in apparati mediatici che richiedono capitali per funzionare), si è aggiunto il flusso delle contraddizioni estremizzate e delle iperboli a ruota libera. Questa forma di funzionamento dell’informazione è agli antipodi di ogni possibilità di fornire un’informazione affidabile, e l’informazione scientifica non fa eccezione. Così la scienza stessa finisce per essere identificata con il suo volto pubblicitario, come promotore di prodotti “investiti di autorità scientifica”. Non sono naturalmente i ricercatori che sobriamente e criticamente provano a perseguire il “scientificamente vero” a diventare protagonisti mediatici, ma personaggi borderline tra scienza e politica, o scienza e affari, che utilizzano il proprio credito scientifico come un randello per farsi largo e portare avanti le proprie agende.
Il livello formativo mediamente basso, e in diminuzione, dell’opinione pubblica ha fatto il resto, esacerbando il discredito simultaneo dell’informazione pubblica e della “scienza” che l’informazione pubblica veicola. Chi non ha basi per cercare risposte in autonomia, attraverso canali scientificamente accreditati, e per valutarle criticamente, finisce per limitarsi a cercare “fonti alternative” in quanto tali, assumendo che siano più credibili di quelle ufficiali, asservite a interessi opachi.
Questa dinamica crea un terreno in cui il discorso pubblico finisce per oscillare tra scientismo acritico e irrazionalismo (spesso con tratti complottisti).
Nel caso del tema vaccinale (tra altri) questa dinamica è esplosa in forma particolarmente cruda e pericolosa. L’informazione ufficiale si è fatta carico, in conformità con le finalità dello “sforzo bellico” in corso, di proclamare l’assoluta sicurezza de “i vaccini”, proprio in quanto tali, in quanto prodotto scientifico, minacciando di anatema chiunque sollevasse un rilievo. Ma siccome questa assolutezza è scientificamente insostenibile, e siccome la scienza ordinaria è consapevole della sua fallibilità e pronta a revisionare le proprie credenze, i momenti di cautela e revisione dei dati hanno finito per essere letti come smentite e confutazioni della pretesa “assolutezza” del vero scientifico. Così il fideismo scientista finisce per convertirsi facilmente in irrazionalismo antiscientifico, in una polarizzazione distruttiva.
In tutto ciò credo sia importante vedere come il problema di fondo non dipenda particolarmente dal piano dell’elaborazione intellettuale. Non è che non esistano scienziati non scientisti, tutt’altro. Per quanto si possa desiderare una maggiore consapevolezza epistemologica nelle fila di chi svolge ricerca scientifica in prima persona, tuttavia sono numerosissimi, probabilmente la maggioranza, quelli che hanno un senso corretto dell’impresa scientifica come processo instabile, soggetto a momenti interpretativi, e aperto a revisione. Il vero problema è rappresentato dall’informazione pubblica, che procedendo per estremizzazioni, funzionali a suscitare emozioni e incrementare le vendite (o l’audience), crea un quadro oscillante tra due irrazionalità, quella della scienza vista come nuova fede cui sottomettersi obbedienti, e quella della scienza vista come una sorta di “prodotto dell’Anticristo asservito a Mammona”.
S&F: Professore, nel suo densissimo lavoro Critica della ragione liberale (Meltemi, 2020) lei ricostruisce sapientemente la genesi e il ruolo della tecnoscienza nella maturazione e nella “presa del potere” da parte della ragione liberale nel corso degli ultimi secoli. Sempre consci della necessità di uno sguardo genealogico ma andando oltre, quali sono oggi, in età neoliberale, i caratteri principali della ricerca scientifica?
A.Z.: Anche questa è una domanda assai ambiziosa, cui provo a rispondere scegliendone un singolo aspetto, tutt’altro che esaustivo. Se dovessi dire qual è il principale rischio abbinato oggi all’evoluzione tecnoscientifica, direi che si tratta della scarsissima tematizzazione che ha il tema dell’impianto motivazionale, degli interessi che muovono l’azione scientifica.
Nella concezione che caratterizza la tecnoscienza moderna c’è una tendenza implicita a investirla di un carattere neutrale, da un lato subordinato all’idea della “purezza della ricerca” e dall’altro al fatto che sul piano tecnico si approntano semplicemente mezzi, strumenti, che poi starà ad altri decidere come adoperare. Entrambe queste linee interpretative sottraggono alla vista il fatto che l’attività scientifica è promossa da esseri umani sulla base di motivazioni specifiche, con interessi e scopi definiti. Ora, però, nel contesto contemporaneo dove la ricerca scientifica ha spesso bisogno di database, apparati sperimentali e/o computazionali imponenti, il tema del finanziamento della ricerca scientifica emerge in primo piano.
L’accesso a fondi adeguati è la modalità più semplice e diretta di esercitare un controllo diretto sugli orientamenti della ricerca, che quindi può ben dirsi “libera” nel senso che nessuno esplicitamente pone dei divieti intorno a quali temi siano indagabili e come, salvo essere spesso guidata in modo ferreo da una scelta a monte intorno a cosa sia finanziabile. Di fatto, quanto più una ricerca esige fondi specifici per poter essere svolta, tanto più essa risulta orientata a monte. E qui l’orientamento può essere esercitato da gruppi privati o da gruppi pubblici, entrambi di norma dominati da chiare aspettative intorno a cosa dovrebbe essere una “ricerca utile”. Se i finanziamenti privati garantiscono un “bias” favorevole alle grandi capitalizzazioni private, i finanziamenti pubblici – quando non sono sostegni dissimulati alla ricerca privata – spesso seguono gli orientamenti politicamente più spendibili e alla moda.
E, incidentalmente, tra gli orientamenti di ricerca che difficilmente vengono finanziati, ci sono proprio quelli che cercano di indagare l’impatto sulla ricerca dei desiderata dei finanziatori.
S&F: Le faccio una domanda un po’ corsara: lei crede che la maggioranza degli scienziati “duri” abbia consapevolezza dei presupposti e dei precipitati filosofici della ricerca scientifica? Non le chiedo certo una statistica, bensì piuttosto una riflessione sul modo in cui gli scienziati (categoria molto variegata, me ne rendo conto) presentano il loro stesso operato.
A.Z.: Difficile andare al di là di impressioni personali e aneddotiche. Mi è capitato qualche anno fa di essere invitato a discutere di una proposta teorica intorno alle proprietà emergenti da un nutrito gruppo di scienziati facenti capo alle università milanesi. In quell’occasione ero l’unico con una formazione non legata alle hard sciences e stavo proponendo considerazioni che andavano metodologicamente “contropelo” rispetto ad aspettative “scientiste”. Le mie aspettative erano di trovare un’atmosfera avversa, giacché le tesi che andavo esponendo sfidavano due capisaldi del naturalismo scientifico: si faceva spazio in modo sistematico alla correlazione soggetto-oggetto, e si criticava l’idea che una riduzione logica degli interi alla “meccanica” delle parti componenti potesse essere razionalmente giustificabile. Con mia sorpresa, e piacere, l’incontro non fu solo piacevole – il che potrebbe essere messo sul conto dell’umana cortesia degli anfitrioni – ma intellettualmente molto costruttivo. Con poche eccezioni, l’impressione che ebbi in quell’occasione fu di grande apertura, curiosità intellettuale e capacità critica di riflettere sulle proprie operazioni.
Certo, in quella circostanza c’è da mettere in conto la possibilità che l’alto livello di consapevolezza metodologica dell’organizzatore, il prof. Carlo Bottani del Politecnico di Milano, avesse operato da filtro selettivo, portando all’incontro prevalentemente scienziati con una solida formazione critica. Invero, se avessi dovuto basarmi su altri episodici scambi di opinione avuti con eminenti uomini di scienza – ad esempio Edoardo Boncinelli – le mie impressioni in merito sarebbero alquanto differenti.
In quella parte della “militanza scientifica” priva di consapevolezza critica si ritrovano sempre tre idee di fondo: l’idea che il mondo sia una specie di “oggetto totale” (obiettivismo), dove il soggetto sarebbe un oggetto accanto agli altri; l’idea che la verità scientifica sia una sorta di fotografia del mondo, destinata a divenire asintoticamente sempre più adeguata (adequazionismo); l’idea che le spiegazioni funzionali al livello delle parti siano di principio valide al livello dell’intero (riduzionismo). Tutti questi assunti sono trasferimenti sul piano ontologico di premesse metodologiche, e conducono in ultima istanza a una visione ontologica, e persino messianica, della scienza, vista come depositaria della Verità (scientismo). Nell’insieme dunque, non sono in grado di fare una stima quantitativa circa quale proporzione degli scienziati attivi abbia una consapevolezza della natura, del metodo, delle precondizioni delle operazioni scientifiche, al netto della mia positiva esperienza personale. La mia impressione, tuttavia, è che i danni dello scientismo siano prodotti solo in minima parte dagli scienziati operanti sul campo, mentre siano molto più frequentemente causati da chi se ne fa schermo per darsi autorevolezza: numerosi giornalisti, e ahimè, anche non pochi filosofi.
S&F: Ancora, rispetto alla santificazione di una disciplina come l’economia, la cui “scientificità” (spesso avvolta da una dogmaticità schiettamente funzionale allo status quo) è assai discutibile, quale ruolo “oppositivo” può avere il sapere filosofico? Il trionfo dell’economicismo è contendibile? Penso anche al dominio “mediatico” dell’economia, al modo in cui essa viene “divulgata” in maniera apparentemente neutrale divenendo così senso comune e restringendo sempre più il campo del “possibile”.
A.Z.: Questo tema per essere affrontato fondatamente avrebbe bisogno di un’ampia disamina di tipo storico che qui non posso richiamare. Chiedendo dunque venia per l’assertorietà forzosa, quel che mi sento di dire a valle di molte analisi pregresse è questo: la scienza economica confluita nella cosiddetta sintesi neoclassica ha al suo centro un nucleo prettamente ideologico di cui non ha di norma alcuna consapevolezza. Si tratta di una teoria che nasce come accompagnamento della nascita e del funzionamento dei moderni sistemi di mercato, e che trae la sua principale legittimazione da questo ruolo di supporto a uno specifico sistema sociale. L’economia neoclassica è “scienza del capitalismo” in un duplice senso: ha come suo oggetto di studio fondamentale le forme di scambio che caratterizzano lo sviluppo economico capitalista, ed è utilizzata da questo modello socioeconomico come suo implicito sostegno ideologico. Qui naturalmente per motivare queste tesi tranchant dovrei avere lo spazio per mostrare come le premesse di base dell’economia neoclassica, dagli assiomi della “scelta razionale” all’individualismo metodologico, sono originariamente compromesse con una visione dell’uomo e del valore integralmente interna alle forme sociali del capitalismo. Tutto ciò funziona a prescindere dalle intenzioni personali dei singoli economisti, che possono anche essere personalmente critici degli “abusi” del sistema, dei “difetti” delle teorie, dei “fallimenti del mercato”, e che tuttavia hanno grandi difficoltà a trovare strumenti di analisi che non siano già pregiudicati dall’assunto che questo sistema sia sostanzialmente privo di alternative.
Nei confronti dell’economia la filosofia ha un potenziale critico assai significativo, soprattutto sulla scorta del fatto che l’evoluzione neoclassica dell’economia nasce da decisioni epistemologiche discutibili e razionalmente refutabili, a partire dall’abbandono del paradigma storico e dalla sua sostituzione con un paradigma modellato sulle scienze della natura. Purtroppo ciò che ha preso il nome di “filosofia dell’economia” in area anglofona è di fatto un gioco analitico tutto interno al paradigma destoricizzato dell’economia neoclassica, e come tale dotato di uno scarsissimo potenziale critico.
Il ruolo egemonico dell’economia neoclassica, delle sue categorie e dei suoi alfieri chiaramente non dipende dall’autorevolezza scientifica o dal potere previsionale. In qualunque sfera che vada al di là delle dimensioni di un’azienda le capacità previsionali medie degli economisti non superano quelle del buonsenso informato, e talvolta non lo raggiungono neppure, in quanto l’inquadramento teorico spesso acceca rispetto alle esigenze di una visione d’insieme. Non siamo in una situazione minimamente paragonabile con quella delle scienze naturali come la fisica o la chimica, dove le capacità previsionali medie degli addetti ai lavori sono incomparabilmente superiori a quella degli outsider. Il ruolo culturalmente egemonico dell’economia è invece un ruolo di investitura politica, che eleva ad autorità una specifica forma di categorizzazione della società e delle interazioni umane. Per questo motivo la critica di natura epistemologica che la filosofia può esercitare è solo una parte del lavoro necessario per scalzare l’economicismo imperante sui media e nei dibattiti pubblici. L’altra metà inevitabilmente deve passare attraverso la sfera della critica pubblica, della divulgazione, della discussione politica.
S&F: Professore, la sua opera è un tentativo che oserei chiamare sistemico e sistematico (mi corregga se sbaglio) di fare filosofia: una ricerca coerente e unitaria, densa di ricadute ontologiche, epistemologiche e finanche, poi, etico-politiche. Un pensiero vivo e ambizioso.
Ora, domanda da un milione di dollari, le chiedo: qual è il ruolo della filosofia oggi? So che per rispondere bisognerebbe almeno definire preliminarmente “che cos’è filosofia” (senza ridurre il tutto ai giochi linguistici postmoderni che lei nella sua opera denuncia), ma a ogni modo, anche nel senso più generale possibile, essa può ancora essere (lo è mai stata?) pericolosa per quello che Marcuse, tra gli altri, chiamava il dominio? Può contribuire alla rigenerazione di una ragione politica sovrana? Siamo destinati a un mondo in cui la filosofia è ridotta alla mera chiacchiera, il pensiero “disturbante” è dibattito tra pochi (non che si possa negare che la filosofia abbia comunque delle caratteristiche strutturalmente “elitarie”) e, al massimo, il pensiero è inteso come sinonimo di “cultura”? Concludo: l’idea che “qualcuno” o “qualcosa” (anche tendenze anonime e ormai automatiche) vogliano “imbrigliare” la filosofia in quanto sapere pericoloso è semplicemente una fantasticheria che ci si può raccontare tra addetti ai lavori o è una reale tendenza in atto nella società del pensiero unico?
A.Z.: Provo a partire dalla fine. Esiste una filosofia come sapere “pericoloso” per il “potere costituito”, e che perciò può suscitare istanze repressive? Direi di sì, ma con numerose precisazioni. La filosofia come “materia” gestita dalle università di norma non rappresenta alcun pericolo per nessun apparato di potere. Gli studi filosofici sono un’arma potente, in quanto consentono di maneggiare grandi e ardite sintesi, di esercitare le potenzialità del linguaggio e delle categorie fino ai loro limiti estremi. Ma un’arma potente può essere brandita in modo imbelle, o anche dannoso per sé e per gli altri, se chi la brandisce non è all’altezza di ciò che maneggia.
Invero la cultura filosofica può essere utilizzata in molti modi che, lungi dal renderla pericolosa per le strutture di dominio, sfruttamento e prevaricazione, ne fanno un loro alimento e ausilio. Due sono le principali modalità con cui la cultura filosofica può porsi oggi come complice implicito delle forme di dominio correnti. La prima, meno colpevole, prende la forma del processo di frammentazione dell’oggetto filosofico in campi sempre più ristretti e astratti (come è avvenuto per la filosofia che ha tratto ispirazione dal modello delle scienze naturali). Questo processo neutralizza qualunque funzione pubblica del pensiero, abbandonando la dimensione sintetica e rendendola un’attività perfettamente innocua. La seconda tendenza è quella che ha luogo quando troviamo processi di sostituzione del rigore concettuale con una melassa di pseudoconcetti, dall’apparenza radicale ma in effetti comodamente collocati a metà strada tra il luogo comune e i “sentimenti privati” (questo è avvenuto per una significativa parte dell’eredità filosofica postmoderna). Questo secondo indirizzo è quello distintamente più dannoso perché si pretende spesso “politico” e “radicale”, salvo operare con una concettualità parolaia e nebulosa, refrattaria a qualunque plausibile contatto con la realtà. Questo approccio è distintamente più dannoso del precedente perché non si limita a lasciare il campo sguarnito, ma alimenta attivamente la confusione e la retorica nel discorso pubblico, mescolando ideologismi, opinioni comuni, rivendicazioni private e tutto ciò che la filosofia ha cercato tradizionalmente di tenere a catena corta.
Rispetto a queste tendenze l’esercizio filosofico autentico ha uno spazio di efficacia critica se accetta di pensare in modo “inattuale”, nel senso di Nietzsche, cioè di pensare contro il proprio tempo, a favore di un tempo venturo. Il pensiero filosofico è rilevante se percepisce e denuncia i limiti della visione dominante, e questo in qualunque momento si collochi e quale che sia la visione dominante. Un pensiero che si accoccoli nell’opinione prevalente, nella moda mediatica, nel sedicente buon senso comune è un pensiero inutile, complice, sterile, lontano da ciò che ha conferito senso alla filosofia dalle origini. Questo, beninteso, non significa affatto che gesticolazioni rivoluzionarie, pantomime ribelliste, o uno sterile gusto per il paradosso siano qualcosa di affine al senso dell’attività filosofica: si agisce in maniera filosoficamente critica, e dunque utile, se si scorgono i limiti della visione del mondo dominante dopo averla compresa dall’interno. Questo è, a mio avviso, il senso fondamentale dell’idea hegeliana della storia come “processo dialettico”: il “superamento” avviene comprendendo il passato e il presente, e poi scontrandosi con i loro limiti.
Questo modo di operare ha tuttavia bisogno non solo di studio, non solo di ingegno, ma anche di una buona dose di risolutezza, perché turbare sonni e digestioni altrui ha il suo costo. Per citare infine il mio amato Wittgenstein: “Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto, altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? Credo con il coraggio”.