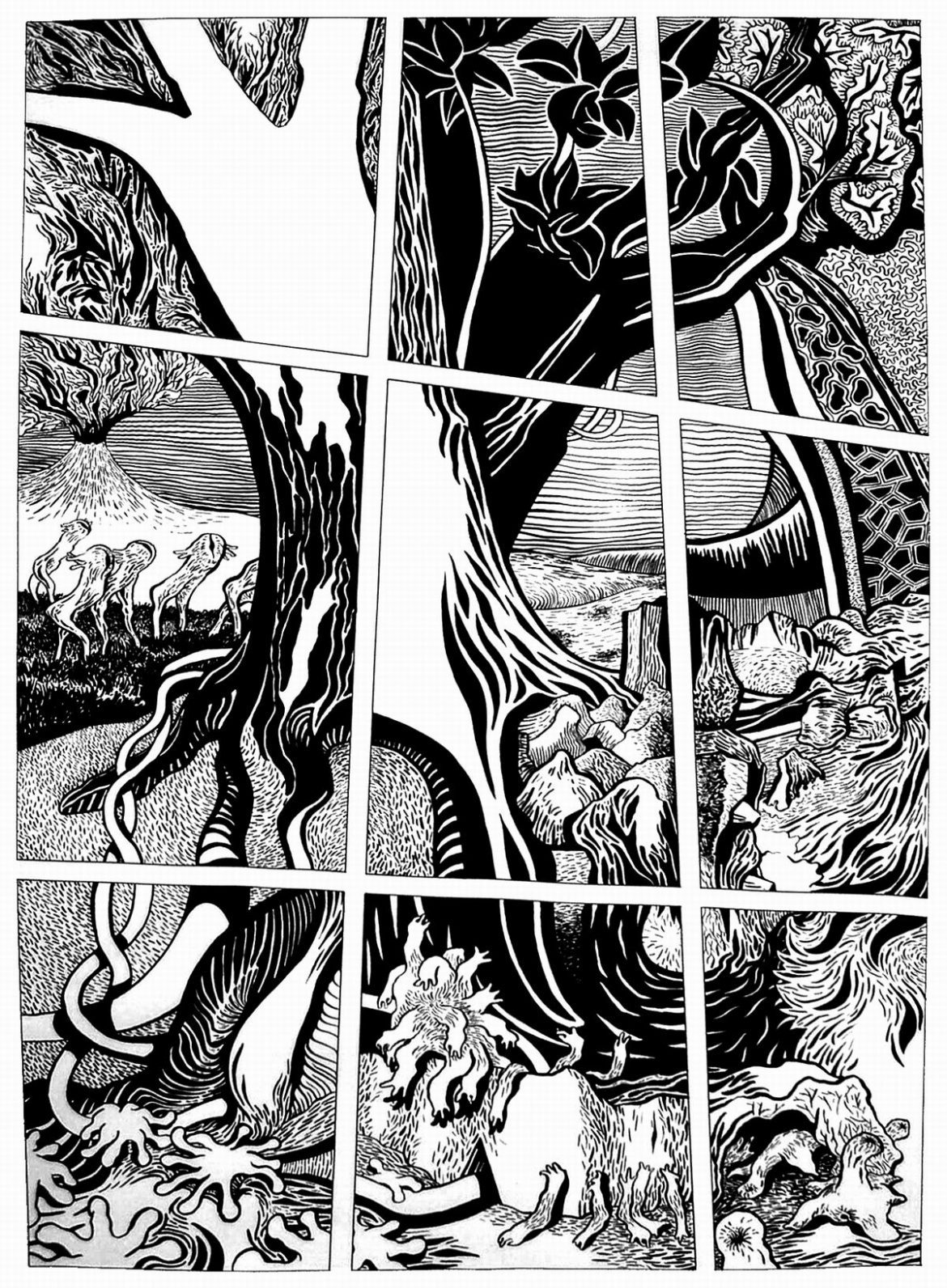Autore
Indice
- Comunicazione alla radice
- Rischio infodemia
- Comunicare per bene
- Cura o guerra
- L’ambiente che ci contiene
↓ download pdf
S&F_n. 25_2021
Abstract
Viral communication
Starting from the concept of infodemia, on which the WHO issued a global alert already in February 2020, we analyze the specific risks represented by information and communication. They are seen as risky by those who hold "power" (and/or knowledge) and are unwilling or unable to share knowledge. They are indeed risky due to misinformation and disinformation. They finally represent the heart of problem solving, if revisited and used in a participation/sharing/democracy key.
What must be analyzed to understand what it means to do proper information and communication without trivializing? In order to exercise communication that meets ethical requirements (linked to accountability and democracy), the following must be considered: fears, for oneself and for others; the perception of risk, at a collective and individual level; the problems of risk governance; the actors in the field.
A reflection on the place of COVID-19 in the environmental crisis makes us think about the possibility of taking charge as responsible and proactive actors, capable of acting by producing networks of meanings and positive actions.
1. Comunicazione alla radice
- La comunicazione è stata un elemento fondante dell’esistenza delle comunità umane fin dal loro costituirsi, ed è stata studiata dalle discipline più diverse, perché lo “scambio di informazioni” non riguarda solo la dimensione verbale e umana ma va dall’infinitamente piccolo delle cellule che per funzionare attivano scambi, all’immensamente grande dell’universo in movimento.La comunicazione è certo imprescindibile nella vita di ciascuno e in particolare nell’era che stiamo vivendo, l’Antropocene, che per parte della popolazione del mondo è diventata l’era della disintermediazione. Ciò significa che esiste la possibilità di comunicare senza quelle mediazioni che tradizionalmente sono stati i mass media (giornali, televisioni e radio). In un recente passato una vera e propria disciplina – l’agenda setting – studiava il modo in cui i media possono influenzare le priorità a livello dei governi fungendo da vero e proprio filtro della realtà per la comunità in generale: questi “equilibri” ampiamente studiati sono stati completamente sovvertiti, così come è successo per la comunicazione in generale.
Il più recente aggiornamento degli strumenti, dei fondamenti e delle logiche della comunicazione è avvenuto attorno agli anni Ottanta dello scorso secolo nel momento in cui, a partire dal mondo della cultura occidentale, si è diffuso l’accesso a internet, uno strumento a basso costo che ha offerto la possibilità di trasmettere grandi quantità di informazioni eliminando le distanze e comprimendo i tempi. La possibilità di un ulteriore salto verso il superamento del filtro dei mass media si è creata quando i fruitori stessi hanno cominciato ad avere la capacità di produrre da soli i propri contenuti e di diffonderli, utilizzando i social media.
È quindi cambiato il ruolo di lettura della realtà che tradizionalmente possedevano i media e apparentemente oggi ciascuno può comunicare con tutti; non solo, ma spesso i media tradizionali raccontano la realtà attraverso i social media, come in un gioco di specchi[1].
Non solo rimane importante interrogarsi ancora sul ruolo di filtro della realtà di questi strumenti, ma diventa oggi più complesso identificare le vie di costruzione delle conoscenze e di apprendimento dei fatti quotidiani – quando i fatti stessi diventano materia di aspra contesa, come spiega bene la teoria della scienza post-normale[2]. Dentro e attorno a un mondo di comunicatori disintermediati si stanno evolvendo le teorie, i diritti, i valori, le pratiche delle persone e delle comunità, con rilevanti implicazioni sociali, culturali, economiche e politiche[3].
2. Rischio infodemia
- In questo vortice è piombato il contagio globale del Covid-19, e l’infodemia che l’accompagna, che offre l’opportunità di riflettere in profondità sui meccanismi della comunicazione, della governance e dei loro impatti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha lanciato l’allarme infodemia il 2 febbraio 2020, più di un mese prima della dichiarazione ufficiale della pandemia (11 marzo 2020)[4].Il comunicato OMS dice letteralmente: «L'epidemia e la risposta al 2019-nCoV sono state accompagnate da una massiccia infodemia – una sovrabbondanza di informazioni – alcune accurate e altre no – che rende difficile per le persone trovare fonti credibili e una guida affidabile quando ne hanno bisogno. A causa dell'elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili sul 2019-nCoV, i vari team di comunicazione dell'OMS lavorano a stretto contatto per rintracciare miti e voci ingiustificate e rispondere in modo sistematico»[5].
Man mano che cresceva la consapevolezza della dimensione dell’emergenza si cominciava a capire il pericolo rappresentato dalla diffusione di informazioni false o manipolate. Da una parte l’impatto può essere direttamente sulla salute, con false misure di prevenzione, voci su cure o su sintomi non confermati, che possono indurre comportamenti sbagliati. Ma sono preoccupanti e ancora più difficili da identificare gli impatti psicologici, a livello individuale e collettivo degli allarmi che creano panico sociale, le corse all’accaparramento di cibo nei negozi, lo stigma sociale verso determinate persone, categorie o etnie, come è rischiato succedesse con le comunità cinesi in una prima fase. Ma il meccanismo dello stigma sociale verso i malati, o verso categorie di persone specifiche, è tutt’altro che scongiurato[6].
Esistono quindi rischi specifici rappresentati direttamente da informazione e comunicazione, che sono effettivamente rischiose quando diventano disinformazione (disinformation), cioè la circolazione volontaria di informazioni false, per creare paura, identificare nemici, distrarre l’attenzione, nascondere altre notizie, o misinfomazione (misinformation), cioè la circolazione di informazioni false per difetti di comprensione, per notizie che sembrano perfettamente credibili, soprattutto al pubblico meno preparato che quindi le diffonde senza cattive intenzioni. Queste ultime sono innumerevoli e talvolta entrano nel discorso comune diventando verità per trasmissione… virale! Questi meccanismi proliferano in un periodo che è stato definito l’era della post-verità, dove le notizie vengono accettate come vere principalmente sulla base di emozioni e sensazioni, senza verifica della veridicità dei fatti riportati[7].
Nel 2016 l’Oxford English Dictionary ha eletto parola dell’anno Post-truth, post-verità. «Post-truth definisce circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti, nella formazione dell’opinione pubblica, in favore del richiamo alle emozioni e alle convinzioni personali», hanno spiegato gli esperti inglesi. Essa fiorisce in un contesto politico in cui i cittadini diffidano delle notizie trasmesse dalle autorità, pensando che dietro ad ogni fatto ci sia un complotto, un’intenzione nascosta, e non si preoccupano, o non hanno la possibilità, di verificare la veridicità delle affermazioni che vengono messe in circolo.
Ma informazione e comunicazione sono vissute come rischiose proprio dalle istituzioni o dalle persone che detengono e difendono un “potere” e non vogliono o non sanno condividerlo. Il potere che dà la conoscenza – dei fatti, delle ricerche, della politica a livello locale e internazionale – è incommensurabile in situazioni come quella della pandemia che stiamo sperimentando. Le scelte che si fanno in materia di comunicazione hanno una rilevanza politica di prima grandezza, e conseguenze di lungo respiro. Le autorità hanno creato meccanismi molto codificati di trasmissione delle informazioni, si sono limitate a trasmettere direttive sui comportamenti da adottare e informazioni sull’andamento dei contagi che ribadivano la necessità dell’isolamento, confermando in continuazione la validità delle misure adottate.
Il ruolo di informazione e formazione delle opinioni è stato lasciato alla circolazione delle notizie, con un grande affollamento di esperti e “scienziati” spesso auto-definiti, di solito senza alcuna attenzione ai conflitti di interesse, che sono ampiamente presenti nel campo della medicina. Il panorama delle trasmissioni d’intrattenimento-informazione appare un po’ caotico, e alla distanza abbastanza ripetitivo. È sorprendente come una notizia continui a rimanere sulle prime pagine, in testa alla comunicazione social e sui media per mesi in maniera costante: fa parte delle novità di questo periodo e si aggancia alla forte preoccupazione del pubblico e alla vera e propria paura[8], che non si placa ma muta nelle sue forme di espressione.
3. Comunicare per bene
- In questa situazione avanzo l’ipotesi che informazione e comunicazione possono e devono rappresentare la soluzione dei problemi dell’infodemia, nello stesso tempo in cui costituiscono il problema. Uno dei pochi “insegnamenti” in materia di comunicazione che rimarranno in piedi (immaginando il periodo post-pandemia) è che la comunicazione esiste, punto. Cioè che comunicazione è tutto ciò che circola, compresi i contesti, i modi e le forme attorno ai discorsi e ciò che gli attori che comunicano fanno. E anche il silenzio comunica, soprattutto il silenzio di chi ci si aspetta dovrebbe parlare.D’altra parte nel 2005 John Barry pubblica un libro che descrive la temibile influenza spagnola e afferma: «Nella prossima pandemia che sia vicina o lontana, provocata da un virus più o meno aggressivo, l’arma più importante contro la malattia sarà un vaccino. Ma la seconda sarà la comunicazione»[9].
Informazione e comunicazione, declinate in chiave di partecipazione, condivisione delle conoscenze e democrazia, arricchite dalla responsabilità di chi comunica con l’esplicito fine dell’interesse pubblico, possono mirare a rispondere alle esigenze del pubblico. Uno dei risultati cui contribuisce una comunicazione responsabile è quello di formare una memoria collettiva, di creare metafore condivise, “narrazioni” che aiutino a convivere con la situazione attuale di lunga-emergenza senza negarla o rifiutarla.
Per capire cosa significa fare bene informazione e comunicazione senza banalizzare vanno comprese le paure, per sé e per gli altri, e la percezione dei rischi più in generale. Le paure possono essere usate in direzione di una difesa identitaria e per affermare uno stile di potere autoritario oppure all’opposto si può adottare un atteggiamento di cura, condivisione, solidarietà, che cerca di coinvolgere e far esprimere le potenzialità delle persone[10].
Gli elementi che aumentano o mitigano la paura e la percezione del rischio sono stati ampiamente esaminati e discussi[11]. Innanzi tutto la volontarietà: se il rischio è assunto volontariamente, viene percepito come meno grave. Questo è applicabile al fumo, alla guida di auto veloci e alla pratica di sport pericolosi. Se il rischio è imposto da altri (forze esterne) viene percepito come maggiore. Il rischio di COVID-19, come di tutte le pandemie, non è solo involontario ma solo parzialmente controllabile da parte degli individui e difficile da controllare anche da parte delle autorità sanitarie e dei governi. Poi viene la conoscenza: un rischio insolito viene percepito come più spaventoso e il nuovo Coronavirus circolante in questi tempi è stato presentato come un virus sconosciuto, senza cure efficaci. Un rischio di origine naturale provoca meno paura e le teorie della cospirazione aumentano la sensazione di disagio e paura. Un rischio reversibile provoca minore ansia rispetto a un rischio irreversibile. Un rischio che comporta benefici potrebbe anche essere accettabile, come nel caso delle tecnologie/industrie che creano posti di lavoro o forniscono servizi mentre incidono sulla giustizia sociale o sulla salute. Nel caso del nuovo Coronavirus, possiamo vedere come gli individui, le comunità e i paesi subiscono forti svantaggi, e la paura del tasso di letalità è altissima. C’è poi l’elemento della visibilità: un fattore di rischio invisibile viene percepito come più pericoloso di uno visibile (ad es. un impianto chimico, un inceneritore o stazioni radio base). Infine l’elemento chiave: la fiducia. Se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così alto. Nel caso di COVID-19, molti individui alzano la voce, anche in modo opportunistico, per minare la credibilità delle istituzioni sanitarie. Una volta persa la fiducia, è molto difficile riconquistarla. Le divergenze nella comunità scientifica in una situazione di emergenza possono avere effetti devastanti se non si ottiene un consenso. Le autorità pubbliche devono prestare particolare attenzione alla condivisione delle conoscenze, alla ricerca di alleanze nella società e alla costruzione della fiducia, che a sua volta ridurrebbe la paura.
La paura è quindi una caratteristica intrinseca di COVID-19 e non è completamente gestibile, tanto meno con richiami generici a dominare la paura, così come non è evitabile che ci sia preoccupazione per la gestione di un problema così complesso.
4. Cura o guerra
- Ma ciò che è anche opportuno notare qui è il linguaggio di tipo bellico, che in questo periodo viene dato quasi per scontato, e che le autorità pubbliche hanno deciso di adottare a livello globale. La medicina possiede nel proprio linguaggio un costante accenno alla guerra, che trova le proprie radici nella storia, ma che è già stato messo in discussione in diversi contesti, ad esempio nell’affrontare la diffusione dell’AIDS e del cancro. I limiti e le conseguenze di un discorso basato sulla guerra contro un nemico invisibile, su armi, attacchi, trincee di difesa vanno ben considerati. Non solo si limitano le soluzioni, che diventano senza sfumature, dirompenti e risolutive o non esistono, ma vengono ridotte anche le capacità di osservare le sfumature, le diverse reazioni e potenzialità, i modi in cui si possono costruire sistemi di anticorpi, inclusa la cultura, e non solo rimedi che attaccano in modo violento e reattivo. Di fatto le numerose esperienze creative in diversi ambiti – sanità, educazione, volontariato, organizzazione del lavoro – non vengono valorizzate e sono trattate come eccezioni, nel caso vengano scoperte, invece di farne motore di cambiamento e responsabilizzazione. Ci sono invece rischi insiti nel domandare ai cittadini di ubbidire con disciplina militare (senza contribuire, senza ragionare tanto non ce n’è bisogno): non si fa leva sul ragionamento, sulla solidarietà, sulla costruzione comune ma sull’obbedienza. E diventano più comprensibili così i comportamenti di collettività che si ribellano, tipicamente i giovani, che fin dall’inizio sono stati meno consapevoli dei rischi e sono sembrati anche per un certo periodo esenti da problemi di contagio o malattia da COVID-19.C’è bisogno di esercitare una comunicazione che risponda a requisiti etici, che la legano a responsabilità e democrazia, considerando anche i problemi di governance del rischio nella loro dimensione sociale. La governance definisce le competenze, le responsabilità, gli obiettivi, i principi che sono alla base delle azioni da intraprendere, le regole e procedure in modo che il sistema abbia una coerenza e possa essere valutato. I principi di base proposti nel Libro bianco sulla governance dell’Unione Europea sono: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza[12]. Di fronte a rischi causati da eventi naturali o da attività antropiche e alle decisioni da prendere per governarli, la sostanza e i principi fondamentali di governance si traducono nella governance del rischio[13], caratterizzata da complessità, per la molteplicità dei fattori in gioco, incertezza, che esiste per la maggior parte delle conoscenze sugli effetti dei fattori ambientali sulla salute delle persone e sull’ecosistema, ambiguità, perché diversi soggetti attribuiscono valori differenti ai fenomeni e alle loro conseguenze.
Le attività di comunicazione nel percorso di governance del rischio devono tenere conto dei principi etici di riferimento, a partire da quelli utilizzati nella ricerca che vede coinvolti soggetti umani[14]. Il rispetto implica l'obbligo di produrre informazioni comprensibili a tutti, utilizzando un linguaggio appropriato. Per il comunicatore il primo principio etico è garantire la comprensione all’interlocutore, cioè capire il linguaggio, le competenze specifiche degli interlocutori, i bisogni informativi. La trasparenza e l’uso pubblico delle evidenze sono parte dei requisiti che contribuiscono alla validità e riproducibilità della ricerca. La dichiarazione dei conflitti di interesse è requisito etico fondamentale per la trasparenza e l’uso delle evidenze da parte dei decisori e dei cittadini. L’approccio scientifico richiede imparzialità nel disegno e nella conduzione degli studi, nella gestione dei dati e nella produzione e comunicazione dei risultati, tanto più in un settore come quello ambiente e salute in cui le conseguenze in termini di decisioni sono di interesse individuale e collettivo.
Come corollario di questi requisiti, va fatta uno specifico riferimento a chi lavora come amministratore pubblico o come operatrice o operatore di enti pubblici: questa posizione presuppone una scelta di campo, che colloca il proprio operato nel campo della tutela della salute pubblica. Chi opera negli enti pubblici sarà quindi imparziale ma non neutrale, proprio perché sceglierà di mettere al centro l’interesse pubblico e la protezione dei cittadini, sostenere la democrazia, e riconoscere le diverse responsabilità nella gestione dei rischi.
5. L’ambiente che ci contiene
- In conclusione è opportuno non dimenticare i rapporti tra Coronavirus e ambiente. Il COVID-19 è una malattia infettiva o trasmissibile, basata sul passaggio di un agente infettante da un portatore a un ospite che a sua volta può trasmettere il virus ad altri soggetti. Rientra tra i fattori ambientali che influiscono sulla salute perché ha le sue origini e si manifesta in un contesto di intensi mutamenti climatici e di sconvolgimento degli ecosistemi, in cui si sono create le condizioni favorevoli per passaggi anomali di virus tra animali e persone e sono aumentate nel tempo le probabilità di contagio. Anche se la pandemia nasce in un contesto molto specifico le attuali modalità di allevamento animale, anche quelle adottate nel nostro paese e in Europa, sono foriere di pericoli che vanno ben al di là della mera salute degli animali e dei consumatori, ma investono l’ambiente nel suo complesso con effetti diretti sulla salute, per l’inquinamento di aria, suoli e acque e indiretti perché contribuiscono ai cambiamenti climatici. Nell’origine e nella diffusione della malattia si mescolano in modo inscindibile fattori sociali, determinanti di salute e fattori ambientali, quali l’inquinamento che genera popolazioni più vulnerabili all’attacco della malattia. Poiché le cause di malattie di tipo sociale e di tipo ambientale sono collegate servono anche nuovi paradigmi d’interpretazione[15].
È possibile, e alcuni auspicano, che tra gli effetti nefasti della pandemia si riesca a rimettere in discussione e migliorare il modo in cui le persone si rapportano al proprio ambiente. Anche in questo caso sarà importante capire quali conoscenze maturano e filtrano nella società, e come le persone riescono ad assumersi responsabilità in modo diretto e possono contribuire a disegnare soluzioni diverse e creative.
[1] R. Stella, C. Riva, C.M. Scarcelli, M. Drusian, Sociologia dei new media, UTET Università, Torino 2018.
[2] S.O. Funtowicz, J.R. Ravetz, Science for the Post-normal Age, in «Futures», 25, 1993, pp. 739-755.
[3] A. Cerase, Rischio e comunicazione. Teorie, modelli, problemi, Egea, Milano 2017.
[4] L. Cori, F. Bianchi, E.Cadum, C. Anthonj, Risk perception and Covid-19, in «Int J Environ Res Public Health», 17, 2020; L. Pellizzoni, The time of emergency. On the governmental logic of preparedness, in SociologiaItaliana-AIS Journal of Sociology, 16, 2020, pp. 39-54.
[5] Il documento può essere consultato liberamente al seguente link: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf.
[6] A. Baldassarre, G. Giorgi, F. Alessio, et al., Stigma and Discrimination (SAD) at the Time of the SARS-CoV-2 Pandemic in «Int J. Environ. Res. Public Health», 17, 2020.
[7] Sulla questione cfr. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/viviamo-nellepoca-della-postverit%C3%A0/1192.
[8] L. Cori, O. Curzio, F. Adorni, et al., Fear of COVID-19 for Individuals and Family Members: Indications from the National Cross-Sectional Study of the EPICOVID19 Web-Based Survey, in «Int. J. Environ. Res. Public Health», 18, 2021.
[9] J.M. Barry, The Great Influenza, Penguin Books, London 2005.
[10] L. Cori, O. Curzio, F. Adorni, et al., Fear of COVID-19…, cit.
[11] P. Slovic, Perception of risk: Reflections on the psychometric paradigm, in Social Theories of Risk, a cura di S. Krimsky, D. Golding, Praeger, Westport 1992; pp. 117–178.
[12] Cfr. Libro bianco sulla governance europea, approvato dalla Commissione Europea nel 2001, liberamente consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al10109.
[13] T. Aven, O. Renn, Risk Management and Governance: Concepts, Guidelines and Applications, Springer, Hiedelberg 2010.
[14] Cfr. The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, United States Department of Health, Education, and Welfare, April 18, 1979. Il rapporto è liberamente consultabile al seguente link: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html.
[15] L.N. Allen, A.B. Feigl, Reframing non-communicable diseases as socially transmitted conditions, in «The Lancet Global Health», 5, 2017.