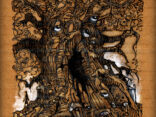Autore
Indice
- Sullo stretto nesso tra sacro e secolare: l’anateismo
- Ludwig Feuerbach: l’ateismo quale verità della religione
- Oltre l’ateismo: la fede post-metafisica di Gianni Vattimo
- La prospettiva anticlericale di Richard Rorty: per una religione antiessenzialista al di là di teismo e ateismo
S&F_n. 23_2020
Abstract
Religion in a post-secular age. The echoes of feuerbachian’s anthropotheism on Gianni Vattimo and Richard Rorty’s thought
This paper questions the role and future of religion in a post-secular age by considering the philosophical perspective of Ludwig Feuerbach, one of the main opposer of Christian religion. The core idea is that a close relationship exists between Holy and Secular. Furthermore, I discuss the idea that religion, even purified from dogmatic stances and metaphysical backdrop, might be a reliable discourse in God’s Death era. The very analysis proposed by Feuerbach about the anthropological essence of Christian religion could be intended as a viaticum to the current debates dealing with the idea of an authentic religious experience in a post-metaphysical era. With regard to this, Gianni Vattimo and Richard Rorty’s contributions, despite the temporal distance to Feuerbach, are characterized from similarities. Indeed, they share with Feuerbach the view of religion as something deeper than mere faith in a transcendent Entity and as something whose essence stands in brotherhood, charity and openness to alterity. Vattimo himself, who is a believer, starts his reflection from a perspective different from Rorty’s, the latter being anticlerical. Nevertheless, religion once stripped away its metaphysical dogmas shows that anti-essentialism of XIX and XX centuries would lead to more tolerance between atheists and theists of different kind.
- Sullo stretto nesso tra sacro e secolare: l’anateismo
Gianni Vattimo, nell’Introduzione al suo scritto Dopo la Cristianità. Per un Cristianesimo non religioso[1], dichiara che quella in cui viviamo oggi è un’epoca in cui non è più possibile pensare alla realtà come a una struttura saldamente ancorata a un unico fondamento, che la filosofia avrebbe il compito di conoscere e la religione, in qualche modo, di svelare. Siamo dentro un universo in cui ci si interroga sul senso a partire da una situazione di non senso, su Dio dopo l’annuncio nietzschiano della morte di Dio, in cui la fede può nascere paradossalmente proprio da questo disperare del divino.
La sfida che egli sembra lanciare al lettore e alla quale sottopone anche se stesso è quella di cogliere proprio nella negazione, nell’epoca della decadenza e dell’indebolimento dell’essere, qualcosa di positivo, che segni l’inizio di una nuova era, di una nuova esperienza sacrale-religiosa. Lo scenario che ci si presenta davanti è quello di una distruzione che edifica, di un momento necessario nell’epoca della morte di Dio, in cui credenza e non credenza arrivano a toccarsi.
In tale contesto diventa opportuno rinnovare la filosofia nel senso di un oltrepassamento della metafisica e consentire alla religione di recuperare il suo ruolo, nonostante si muova in un orizzonte post-secolare, senza maschere e dogmatismi, tornando a occupare un posto accanto alle scienze e alla politica, senza per questo aspirare all’assoluto. La fine della metafisica lascia uno spazio vuoto che non deve necessariamente essere riempito esibendo un fondamento sicuro cui ricondurre l’intera realtà. Al contrario, tale dissoluzione della metafisica può comportare una riduzione del peso dei dogmatismi e delle strutture oggettive del reale, dispiegando quella che secondo Gianni Vattimo e Richard Rorty costituisce la storia del pensiero debole.
In particolare, per entrambi tale storia è riconducibile al moderno processo di secolarizzazione che, però, precisa Vattimo, non va intesa come mero «fenomeno di abbandono della religione, ma come attuazione, sia pure paradossale, della sua intima vocazione»[2], ossia la tendenza alla tolleranza, alla carità e alla solidarietà nei confronti del prossimo. Egli inoltre sostiene che è proprio «rispetto a questa vocazione all’indebolimento e alla secolarizzazione che una filosofia coerentemente post-metafisica dovrà cercare di capire e di criticare, anche, i vari fenomeni di ritorno della religione nella nostra cultura, con l’effetto inevitabile, però, di rimettere in gioco anche sé stessa»[3].
L’idea che la modernità non implichi la fine della religione e che quest’ultima sia qualcosa di molto più profondo della mera fede in un Dio trascendente capace di fornire una fondazione ultima, unica, normativa per la nostra conoscenza e per la nostra etica, non è un’idea nuova nel panorama della storia della filosofia[4], così come non è nuova la convinzione che esista uno stretto nesso tra sacro e secolare[5].
Tale costatazione ha indotto il filosofo irlandese Richard Kearney[6] a “coniare” un nuovo dominio concettuale per la spiritualità del terzo millennio: l’anateismo[7], ossia l’atteggiamento religioso ritrovato nella sospensione di ogni assoluto. Si tratta di una terza via che si apre tra gli estremi del teismo e dell’ateismo, tra sacro e secolare, trascendenza e immanenza[8].
Sebbene l’anateismo non coincida con l’ateismo, concorda con la demistificazione della religione cui mette capo l’ateismo, per attenersi a una sacralità presente dentro l’esistenza quotidiana, che può vedere solo chi si è liberato dalle aberrazioni della religione e dalle perversioni del potere religioso. Tuttavia, il paradigma anateistico non si ferma a questo carattere negativo della religione ma va oltre, fino a realizzare che essa, guidata da fede e amore autentici, è molto più che questo insieme di aberrazioni.
Kearney si domanda che cosa possa significare accettare il sacro nell’universo del secolare e rimanda in primo luogo alla risposta che avrebbe dato Bonhoeffer a questa domanda, ossia che «ciò che è cristiano si trova solo nel naturale, il santo solo nel profano»[9] e prosegue sostenendo che «diversi pensatori cristiani postreligiosi si sono spinti anche oltre, al punto che talvolta il loro lavoro è stato accusato di nichilismo ateistico, laddove invece si propone di passare attraverso la morte di Dio per giungere a un rinnovato amore sacro per il mondo (amor mundi)»[10]. In particolare, tra gli autori ai quali si riferisce Kearney c’è proprio Gianni Vattimo, il quale avrebbe mostrato come un momento di “nulla” e di “vuoto” risieda al centro della fede postmetafisica:
nel caso di Gianni Vattimo […] la Kénōsis richiede una lettura della Prima Lettera ai Corinzi (dove si parla dell’amore), in cui l’incarnazione viene trattata come la rinuncia da parte di Dio di ogni potere, così da riesaminare ogni cosa a un livello secolare: la santificazione dell’esistenza quotidiana. Vattimo considera “l’auto-svuotamento di Dio e il tentativo dell’uomo di pensare l’amore come l’unica legge”, le due facce di un’unica medaglia. E la conclusione di questa “ermeneutica fragile” (il pensiero debole), sorprendente per molti teisti tradizionali, è che la secolarizzazione è “il tratto costitutivo di un’autentica esperienza religiosa”. In questa prospettiva, Copernico, Freud e Nietzsche non devono più essere considerati come nemici del sacro, ma come “realizzatori delle opere dell’amore”[11].
Dunque «l’anateismo non è nulla di nuovo; è solo un termine nuovo per definire qualcosa di molto antico»[12], ossia il messaggio di amore, di speranza, di ospitalità che emerge dal fondo di ogni religione e che va recuperato, riportato alla luce. Non si tratta di un nuovo tipo di religione, ma della scoperta di una sacralità insita nella vita quotidiana e del riconoscimento di un ruolo centrale ai valori della fratellanza, della carità e della dedizione all’altro, gli stessi valori ai quali si richiama Vattimo nella sua analisi del religioso nell’epoca post-moderna.
Secondo la prospettiva anateistica indicata da Kearney l’unico modo per scoprire la sacralità nel quotidiano e meravigliarsi di questa divinità dell’orizzonte mondano è proprio l’accettazione che il soggetto-Dio è morto, che non possiamo mai essere sicuri della sua esistenza.
Come scrive Vattimo nella sua Introduzione al testo di Kearney «l’anateismo non è solo, in definitiva, il momento di sospensione e di vuoto destinato a trovare “di nuovo” una fede “piena” più o meno affine alle fedi tradizionali, ma un atteggiamento che deve accompagnare […] ogni fede ritrovata»[13]. Si tratta di una fede che è stata sempre presente nelle epoche passate ed è emersa ogni qualvolta un individuo ha sospeso le proprie certezze su un Dio a lui familiare, aprendo le porte allo straniero, alla presenza fisica finita della persona che sta di fronte a lui, nella quale riconosce una dimensione di trascendenza che sta però nella e attraverso l’immanenza e che, lungi dallo sminuire l’umanità, la amplifica.
- Ludwig Feuerbach: l’ateismo quale verità della religione
Nel contesto di un’idea di modernità che non implichi la fine dell’esperienza religiosa, ma che vede nella religione (intesa nella sua essenza filantropica, al di là di ogni rigido dogmatismo) un serbatoio di risorse cui attingere, occupa una posizione di rilievo la riflessione del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. Anche lui infatti, al di là della distanza temporale che lo separa dall’analisi di Kearney e dalla prospettiva di Vattimo, sembra mettersi in cammino su quella sorta di terza via tra ateismo e religiosità, che consente di rivisitare il sacro all’interno del secolare, riscoprendo una sacralità del qui e ora.
Feuerbach non intende sopprimere il sacro, del quale riconosce l’impossibile rimozione, ma solo evitarne un esito trascendente. Egli sostiene che la dimensione sacrale-religiosa è costitutiva della natura umana: ciò che va eliminato non è il sacro in sé ma la convinzione che possa esistere una realtà trascendente e altra dal nostro mondo. Solo così può emergere il vero volto del sacro. Esso per Feuerbach coincide con ciò che è comune a tutti, l’universale, il Genere umano come unità io-tu, ossia la totalità umana che ha preso il posto dell’ulteriorità divina.
Dunque, egli del sacro misconosce l’aspetto della separazione, del rimando al trascendente, e fa emergere come, una volta smascherata la natura antropologica della teologia, sacri possono essere considerati l’amicizia, il matrimonio e più in generale i rapporti morali che si stabiliscono nell’orizzonte dell’immanenza.
L’esito della critica feuerbachiana alla religione cristiana, sviluppata nell’opera che più lo ha reso noto, L’essenza del Cristianesimo, è l’affermazione dell’uomo come soggetto che esiste, conosce e agisce in maniera del tutto autonoma, senza alcuna necessità di un Dio esterno ed estraneo alla natura umana. Infatti, alla base di quella critica vi è la convinzione che «l’umanità viene sempre determinata solo mediante se stessa, attinge solo da se stessa i suoi principi teoretici e pratici»[14]. Da ciò deriva che il fondamento della morale non è da ricercarsi nel soggetto Dio, bensì nei predicati etici quali il bene, la saggezza, l’onestà, considerati in e per se stessi[15].
Dunque, non solo la scienza, ma persino la morale, si rivela del tutto indipendente da ogni comando o prescrizione divina: l’uomo compie il bene non per effetto del volere di Dio e quindi per una ragione del tutto estrinseca, bensì per il bene stesso, perché ne individua il fondamento nella sua più intima natura. Allo stesso modo, a giudizio di Feuerbach, la corruzione dei costumi e ogni genere di atrocità non ha certo la sua origine nell’incredulità degli ultimi secoli. Al contrario, è proprio la credenza nei misteri cristiani ad accordarsi molto bene con ogni immoralità e nefandezza. In altri termini viene a cadere il binomio fede-moralità e il pregiudizio secondo il quale esisterebbe uno stretto nesso ateismo-immoralità e corruzione.
Il risultato cui perviene l’antropoteismo[16] feuerbachiano dimostrerebbe che finché non si estirpa la fede nel dogma cristiano della corruzione originaria dell’umanità, ogni miglioramento dell’io è impossibile. Il bene, infatti, si radica nell’uomo solo nel momento in cui egli lo riconosce come sua propria essenza e non si lascia ingannare dalla teologia[17] che lo spinge fuori di lui, proiettandolo in un Dio lontano e inaccessibile. Pertanto, Feuerbach ha rivolto una critica feroce alla riduzione della moralità a meri comandi divini, in particolare nelle Conclusioni a L’Essenza del Cristianesimo. Qui egli sostiene che
quando la morale viene fondata sulla teologia e il diritto su un’autorità divina, le cose più immorali, più ingiuste e più vergognose possono avere il loro fondamento in Dio e venir giustificate. […] porre alcunché in Dio, o derivare alcunché da Dio, null’altro significa che sottrarlo al controllo della ragione, significa porre alcunché come indubitabile, come inviolabile, come santo, senza spiegarne il perché. Ogni costituzione della morale e del diritto sul fondamento della teologia ha dunque sempre alla sua base un volontario o involontario accecamento, quando non addirittura un’intenzione cattiva, un secondo fine di duplicità e di menzogna. Là dove il diritto è qualche cosa di serio, non ha bisogno alcuno di essere puntellato e assistito dall’alto. Non abbiamo bisogno di una legislazione cristiana: abbiamo bisogno soltanto di un diritto ragionevole, giusto, umano. Il bene, il vero, il giusto hanno sempre la loro consacrazione in sé stessi, nella loro qualità. Dove la morale è una cosa seria, è sentita in sé e per sé stessa come una potenza divina; se invece non ha in se stessa fondamento alcuno, non v’è alcuna intima necessità che esista, e allora cade in balìa dell’arbitrio della religione[18].
Feuerbach in questo passo fa riferimento alla religione cristiana considerata nella sua essenza negativa, teologica, che va rifiutata in quanto ancorata all’idea di un Dio-fondamento ultimo dell’universo morale e che comporta la rottura di ogni legame sociale. Il cristiano infatti si considera autosufficiente in virtù del suo legame col divino e, chiuso e indifferente al mondo, si sottrae a ogni rapporto con gli altri uomini[19]. Al contrario, Feuerbach opta per un ateismo dal carattere peculiare, poiché esso non è la negazione radicale della religione tradizionale, ma il disvelamento di una verità che si cela nel fondo dell’esperienza religiosa stessa e che si tratta soltanto di riportare alla luce.
Nonostante la sua critica al Cristianesimo, Feuerbach riconosce che l’esperienza sacrale-religiosa non può essere mai del tutto eliminata, o anche solo trascurata e ignorata; essa troverà sempre una propria maniera peculiare di manifestarsi:
nasce, in tal modo, l’ateismo teorico, che denuncia quasi sempre, anche se in forme camuffate, una nostalgia del sacro, come dimostra l’insistenza di Feuerbach sul tema religioso, analizzato quasi ossessivamente fino in fondo allo scopo di poterlo negare. […] La costatazione della difficoltà umana di vivere senza di esso e il tentativo, impotente, di sostituirsi a esso, si presenta, tuttavia, di nuovo, come appare nella drammatica costatazione nietzschiana, secondo la quale, se ci fossero dèi, egli non potrebbe sopportare di non essere Dio, dunque non ci sono dèi[20].
Pertanto, a giudizio di Feuerbach, le forme del sacro e del religioso sebbene celate o trasfigurate, si manifestano sempre in rapporto a una dimensione che appartiene all’umano e nello stesso tempo la supera. Tale apertura sacrale-religiosa propria di ogni uomo si concretizza nel bisogno dell’altro da sé, che ha del tutto sostituito il divino: questo altro è l’individuo concreto, determinato, non assoluto, fatto di bisogni e sensibilità, nel quale ciascuno si riconosce e al quale ci si affida completamente.
A tal proposito Feuerbach è convinto di trovarsi alle porte di un tempo nuovo, di un presente che anticipa il futuro, poiché vede già, seppur ancora inconsapevolmente, l’attuazione piena dell’uomo non più in Dio ma nella comunità umana di cui fa parte.
Così nelle sue Lezioni sull’Essenza della religione, egli sostiene che «se l’ateismo fosse soltanto una negazione, sarebbe filosofia immorale e di poco conto»[21], invece esso nega la realtà metafisica, trascendente, di Dio solo per affermare la verità della religione. Infatti, negare Dio non implica, a suo giudizio, la fine di ogni esperienza religiosa, dal momento che la religione non si riduce alla mera fede in un’entità trascendente. Feuerbach scinde nettamente Dio e religione, con l’intento di salvare quest’ultima da ogni legame con l’idea di un essere ultramondano, garante della beatitudine eterna.
Per comprendere più nello specifico la peculiarità della sua analisi dell’universo religioso può essere utile applicare a Feuerbach il giudizio che egli formulò a proposito del suo Pierre Bayle: «Bayle è positivo, là dove è negativo»[22], ossia egli esprime il positivo negativamente, talvolta in modo improprio, enigmatico, ironico. Infatti, nell’ambito della sua critica alla religione Feuerbach sostiene che occorre negarla, ma solo nella sua essenza falsa, teologica, che fa dell’uomo un prodotto di Dio, per affermare invece la sua vera natura antropologica, che si esplica proprio in ciò che comunemente è considerato non-religione[23], ossia l’idea dell’inessenzialità del divino, fatto coincidere con l’uomo stesso, in quanto genere umano. Non è un caso quindi che in un celebre passo contenuto nei Frammenti Feuerbach sostenga: «non avere religione – è la mia religione; non avere filosofia – è la mia filosofia»[24], con l’intento di esplicitare, sebbene per via negativa, la sua peculiare maniera di interpretare l’universo filosofico-religioso del quale intende ripristinare l’essenza autentica al di là di ogni apparenza illusoria.
La sua nuova prospettiva è il risultato del rovesciamento della maniera tradizionale[25], idealistico-speculativa, di concepire i rapporti di predicazione. Se per Hegel l’astratto, il pensiero, è soggetto, mentre il concreto, l’umano è mero attributo, nella realtà delle cose tale rapporto è capovolto. La verità va ricercata in ciò che nella prospettiva hegeliana era considerato predicato, ossia l’umano: esso costituisce il punto di partenza da cui prendere le mosse per volgere lo sguardo al futuro, alla feuerbachiana filosofia dell’avvenire, che a sua volta contiene in sé l’essenza vera, antropologica, della religione[26]. Pertanto, quella che Feuerbach definisce “la mia religione” coincide paradossalmente col non avere alcuna religione, ma non nel senso di un rifiuto, bensì di una critica positiva[27] nei confronti della stessa, per farne emergere il volto umano. Allo stesso modo egli fa corrispondere la sua filosofia al non averne alcuna, ma non nel senso di una negazione della filosofia tout court, bensì della necessità di un confronto critico col pensiero speculativo, essendo esso il maggiore responsabile dell’occultamento della verità.
Dunque, Feuerbach non fa altro che applicare all’universo filosofico-religioso il suo metodo della negazione e capovolgimento, cosicché ripone l’essenza della filosofia proprio in ciò che appare non-filosofia e l’essenza della religione in ciò che in apparenza è non-religione, ripensando a partire dall’uomo, dalla materia, dai sensi, le categorie tradizionali del pensiero occidentale. È ancora possibile, dunque, a suo giudizio, parlare del religioso se non addirittura di sacro, pur all’interno dell’orizzonte dell’immanenza, così come è ancora possibile, in un universo ateo, costruire un’etica in termini puramente mondani e secolari. A tal fine, egli sostiene che più che annullare, occorre realizzare la religione mediante il suo stesso superamento.
- Oltre l’ateismo: la fede post-metafisica di Gianni Vattimo
Non si può non notare come l’analisi di Vattimo sul futuro della religione nell’era post-moderna, condotta nello scritto Dopo la Cristianità[28], prenda le mosse da premesse assai simili, sebbene l’esito del suo discorso sia molto diverso da quello di Feuerbach: ritrovare una fede cristiana dopo la fine di ogni metafisica[29].
In particolare, nel suo testo Dopo la Cristianità egli esordisce alla maniera feuerbachiana, sostenendo che «l’annuncio della morte di Dio non chiuda definitivamente il discorso con la religione»[30]. Si tratta piuttosto della fine della metafisica e non di ogni possibile esperienza religiosa: ciò che può dirsi superato è il Dio della morale, il Dio fondamento-ultimo, ossia quell’entità ultramondana che garantisce e fonda l’ordine oggettivo del mondo[31].
Dunque, Vattimo si interroga sulla rinascita del religioso nella società post-moderna e sulle cause di tale fenomeno peculiare[32], rinvenibili, a suo giudizio, essenzialmente nel processo di dissoluzione della metafisica «in quanto credenza in un ordine fondato, stabile, necessario, oggettivamente conoscibile, dell’essere»[33].
Anche per Vattimo, come per Feuerbach, il processo di modernizzazione non implica un abbandono della religione, bensì l’attuazione, sia pure paradossale, della sua aspirazione più intima; per entrambi siamo eredi di una tradizione che si è nutrita di valori cristiani come la fratellanza, la carità, il rifiuto della violenza, che vanno quindi recuperati senza per questo tradire l’aspirazione antimetafisica che caratterizza il ritorno della religione nell’orizzonte dell’immanenza. Pertanto, esiste per Feuerbach, come per Vattimo, una certa continuità tra storia sacra e storia profana. Detto in altri termini, per spiegare la genesi della religione non si può prescindere dai fondamenti naturali dell’esistenza umana, dai suoi bisogni e dalla sua sensibilità, così come per spiegare il processo storico che ha portato l’uomo a distogliere la sua attenzione dal trascendente per volgerla a questo mondo e a questo tempo, non si può negare l’importanza che continua ad avere per lui l’esperienza sacrale-religiosa, liberata però dalle sue implicazioni metafisiche e ultramondane.
Inoltre, sia Feuerbach che Vattimo, reputano impraticabile, per cogliere questa religiosità ritrovata, incamminarsi sulla strada percorsa da quanti considerano il divino come il “totalmente altro”, alla maniera di Karl Barth[34], in quanto è proprio la credenza in un Dio quale entità assolutamente trascendente che deve essere abbandonata. Sebbene Vattimo sostenga che nell’era post-moderna siano venute meno anche le ragioni forti a sostegno dell’ateismo, tuttavia anche lui, come Feuerbach, ribadisce la necessità di un dialogo tra filosofia e religione e si appella alla prima quale sapere critico nei confronti della rinascita del religioso, un sapere che ha il ruolo di vigilare affinché questo ritorno della religione non sia un ritorno alla metafisica, bensì l’esito della dissoluzione di ogni metafisica. Così si esprime a tal proposito in Dopo la cristianità:
la mia tesi è che, se la filosofia riconosce che non può più essere atea, deve trovare in questa consapevolezza anche la base per assumere un atteggiamento critico nei confronti della rinascita della religione […] Può e deve però, riconoscendosi parte dello stesso processo storico che favorisce il ritorno della religione, cogliere all’interno di esso i principi per valutarne criticamente gli esiti. In termini molto sommari: la filosofia ha perso le ragioni dell’ateismo e dunque può riconoscere una legittimità all’esperienza religiosa, ma solo in quanto prende atto della fine della metafisica e della dissoluzione dei metaracconti[35].
Vattimo sembra dunque in qualche modo accogliere la lezione feuerbachiana relativa alla continuità tra pensiero occidentale e tradizione cristiana: la risposta al problema dell’uomo diventa risposta al problema di Dio e, inversamente, la risposta al problema di Dio resta la risposta al problema dell’uomo. Religione e filosofia risultano così inscindibilmente legate, in quanto parlano entrambe, anche se a livelli di consapevolezza diversi, dell’uomo. Pertanto, la tradizione cristiana non va negata ma, come aveva già detto Feuerbach, liberata dalle sue maschere metafisiche e rigidezze dogmatiche. Solo in questa prospettiva sarà possibile recuperare i valori del Cristianesimo originario, ossia la carità, l’empatia e più in generale il legame dell’uomo col suo prossimo, che riveste un ruolo di primo piano tanto nella filosofia feuerbachiana quanto nell’analisi di Vattimo[36] relativa alle implicazioni della rivoluzione antimetafisica cristiana:
queste implicazioni non possono svilupparsi pienamente senza il ricorso alla carità. Ancora una volta in modo schematico: è solo l’amicizia esplicitamente riconosciuta come un fattore decisivo di verità ciò che impedisce al pensiero della fine della metafisica di precipitare in quello che potremmo chiamare, riprendendo l’espressione di Nietzsche, un nichilismo reattivo (e anzi, spesso, reazionario). […] Non posso non vedere nel ruolo centrale che riveste l’altro […] una conferma della mia ipotesi sul ruolo centrale della caritas. […] l’amicizia può diventare il principio, il fattore della verità soltanto dopo che il pensiero abbia abbandonato tutte le pretese di fondazione oggettiva, universale, apodittica. […] Il ruolo centrale dell’altro in molte teorie filosofiche di oggi prende tutto il suo significato se lo collochiamo nell’ambito della dissoluzione della metafisica, e solo a questa condizione evita il rischio del puro e semplice moralismo edificante, o puramente “pragmatico” (“è in ogni caso preferibile vivere in un mondo di amici…”). Con tutte le imprecisioni che una tale conclusione, sebbene provvisoria, lascia sussistere, mi pare che proprio da questo punto si dovrebbe cominciare una riflessione su ciò che rimane, non solo da rimemorare, ma anche da fare, duemila anni dopo l’evento del cristianesimo[37].
L’uomo postmoderno dunque, se assume fino in fondo l’idea della fine di ogni assolutezza metafisica, può finalmente imparare a convivere con se stesso e con la propria finitezza. Tale uomo, capace di distogliere la sua attenzione da ciò che è trascendente e di rivolgerla a questo mondo e a questo tempo, si adopera per far valere gli ideali del pluralismo e della tolleranza praticando attivamente la solidarietà, la carità, l’ironia.
Questo sembra essere il risultato della lezione di Vattimo sul futuro della religione: lasciare che essa si liberi dal peso di qualsiasi autorità dogmatica per trasformarsi in faccenda privata. Solo in questo modo, infatti, l’uomo postmoderno può diventare da agente responsabile verso Dio, un agente responsabile verso se stesso e gli altri. Una convinzione questa, che sembra riecheggiare il progetto feuerbachiano di trasformare «gli amici di Dio in amici degli uomini, gli oranti in lavoratori, i candidati dell’al di là in studenti dell’al di qua, i cristiani in uomini integrali; giungere dal cielo alla terra, dalla fede all’amore, da Cristo a noi stessi, ma soprattutto da ogni forma di soprannaturalismo alla vita reale»[38].
Inoltre, a giudizio di Vattimo, ancora una volta in linea con Feuerbach, la carità, quale vera essenza della rivelazione cristiana, deve prendere il posto della disciplina, dal momento che nella condizione postmoderna, il Cristianesimo non può più svolgere la sua funzione dottrinale, morale, disciplinare ma può, anzi deve, impegnarsi a prendere parte al confronto tra le culture e le religioni, facendo leva sul proprio specifico orientamento alla laicità.
- La prospettiva anticlericale di Richard Rorty: per una religione antiessenzialista al di là di teismo e ateismo
Il filosofo americano Richard Rorty nel suo saggio Anticlericarismo e ateismo[39] si confronta con le analisi di Vattimo e ne condivide la prospettiva che lo colloca sulla scia della riflessione feuerbachiana: la necessità di allontanare la religione dal collegamento con la verità, nello specifico con una verità oggettiva, rigida, dogmatica. Rorty sostiene che
la teologia di Vattimo si rivolge esplicitamente a quelli che egli chiama “mezzi credenti”, quelli che san Paolo definiva “tiepidi nella fede”. […] Vattimo trascura i passi della lettera ai romani che Karl Barth amava di più e riduce il messaggio cristiano al passo paolino preferito da molti, Corinzi 1, 13. La sua strategia è quella di trattare l’incarnazione come il sacrificio che Dio compie del suo potere e della sua autorità, così come della sua alterità. L’incarnazione è un atto di kénosis, l’atto in cui Dio cede tutto agli esseri umani. Questo atto autorizza Vattimo a fare la sua affermazione più cruciale e più importante: che la “secolarizzazione” è il “tratto costitutivo di una autentica esperienza religiosa[40].
Rorty dunque fa emergere come, nel pensiero di Vattimo, Cristo non si identifichi più con la verità e il potere, bensì con l’amore, e che il suo Cristianesimo si riduca a una speranza e a una testimonianza: la speranza che questo amore possa prevalere.
Anche per Rorty solo così la religione può tornare a essere un fatto privato, agendo molto più in profondità di quanto faccia quando pretende di agire, politicamente, come forma di potere. Nella sua prospettiva, quando la fede religiosa assume questa pretesa autoritaria diventa politicamente pericolosa, mentre essa, come esperienza privata, è considerata dal filosofo addirittura un possibile rimedio alla solitudine e alle domande angosciose che la fede dogmatica impone.
Pertanto, Rorty non si dichiara ateo, bensì anticlericale e anzi sostiene che il suo anticlericalismo non sia tanto distante dalla prospettiva di un teista, di un credente come Vattimo. A tal proposito egli afferma che l’anticlericale più che lottare per negare Dio, intende criticarne solo la pretesa autoritaria: «l’anticlericarismo è infatti una visione politica e non epistemologica o metafisica. È l’idea che le istituzioni ecclesiastiche, nonostante tutto il bene che fanno, nonostante tutto il conforto che danno ai bisognosi e ai disperati, siano pericolose per la salute delle società democratiche»[41].
Da quanto detto emergono le motivazioni profonde che spingono Rorty, da non credente, a confrontarsi e ad accogliere in parte la prospettiva di Vattimo e a privilegiare il dialogo con lui: entrambi ritengono che il pensiero che ha caratterizzato il Novecento sia di natura anti-essenzialistica e che ciò avrebbe portato a una maggiore tolleranza tra atei e teisti, nella misura in cui essi abbandonano la pretesa di avere l’evidenza dalla loro parte e abbracciano la comune speranza che l’amore possa prevalere quale unico comandamento.
Ciò che Rorty apprezza della versione “debole” del Cristianesimo teorizzata da Vattimo è la riduzione di tutto alla carità, ossia al valore della solidarietà che deve sostituirsi a quello dell’oggettività, alla ossessiva ricerca di essenze e fondamenti. Se c’è una essenza della cristianità essa consiste infatti nell’auto-svelamento di Dio, nel sacrificio che egli compie del suo potere e della sua alterità, cedendo tutto agli esseri umani e nel tentativo di questi ultimi di pensare l’amore quale unica legge. A tal proposito Rorty sostiene che
Corinzi 1,13 è un testo ugualmente utile sia per i credenti come Vattimo, il cui senso di quel che trascende la nostra condizione presente è legato a un sentimento di dipendenza, sia per i non credenti come me, per i quali questo senso consiste semplicemente nella speranza in un futuro migliore per l’umanità. La differenza tra questi due tipi di persone è la differenza tra un’ingiustificabile gratitudine e un’ingiustificabile speranza. In questo modo, il credere che qualcosa esista realmente e il credere che non esista non entrano in conflitto[42].
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte e in particolare alla luce del dialogo tra un credente come Vattimo e un non credente come Rorty, emerge come la religione da luogo di identità particolare in cui ciascun individuo o popolo finisce con l’irrigidirsi, possa diventare canale di comunicazione e quindi di confronto tra prospettive differenti.
Per far sì che ciò accada occorre però realizzarne il fine antropologico, quello stesso telos individuato da Feuerbach, ossia la tolleranza, la solidarietà, la carità, l’apertura e la dedizione al prossimo, a prescindere da qualsivoglia fede particolare. È in questo senso che la prospettiva feuerbachiana finirebbe col costituire una sorta di anello di congiunzione (al di là della distanza temporale e delle differenti posizioni) tra la riflessione di Vattimo, teista, e quella di Rorty, anticlericale. Il loro reciproco richiamarsi a una religiosità intesa alla maniera feuerbachiana (pur senza mai citare esplicitamente quest’ultimo), ossia spogliata dalle sue maschere metafisiche e rigidezze dogmatiche e riletta in chiave filantropica, dimostra che l’anti-essenzialismo che ha caratterizzato il pensiero Otto-Novecentesco avrebbe paradossalmente gettato le basi per una maggiore tolleranza tra atei e teisti di diversa matrice.
Con ogni probabilità è proprio tale costatazione che avrebbe indotto Vattimo alla riscoperta, sollecitato anche dal confronto con Rorty, delle radici cristiane del secolare, nonché all’accettazione piena della secolarizzazione nella quale il messaggio cristiano può effettivamente continuare a vivere oltre i dogmi e le costruzioni metafisiche della teologia ufficiale, proprio come aveva preannunciato Feuerbach fin dalle sue prime analisi sulle radici antropologiche della teologia. Questo sembra essere il lascito della riflessione feuerbachiana all’era post-secolare intorno al quale si sono interrogati Vattimo e Rorty. Da ciò la possibilità di ripartire dalla sua critica positiva alla religione per far sì che essa possa rappresentare ancora oggi un contenitore di valori cui attingere, sebbene riletti e re-interpretati in una prospettiva immanente.
[1] G. Vattimo, Dopo la Cristianità. Per un Cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano 2002. La produzione di Vattimo relativa alla questione della fede religiosa post-metafisica non si limita a questo testo. Per un’analisi più sistematica della sua riflessione sulla fine della metafisica e gli esiti della secolarizzazione, cfr. Id., La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura post-moderna, Garzanti, Milano 1985; Id., Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per la filosofia, Laterza, Roma-Bari 1994; Id., Credere di Credere, Garzanti, Milano 1996; G. Vattimo, P. Sequeri, G. Ruggieri, Interrogazioni sul cristianesimo: cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo?, Lavoro, Roma 2000; G. Vattimo, R. Girard, Verità o fede debole? Dialogo su cristianesimo e relativismo, Transeuropa, Pisa 2006; G. Vattimo, C. Dotolo, Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra filosofia e teologia, Rubettino, Soveria Mannelli 2009. Nell’ambito di questa vasta produzione, è parso opportuno, ai fini della tesi supportata, selezionare lo scritto Dopo la Cristianità in quanto a) opera paradigmatica della peculiare maniera in cui Vattimo presenta la sua idea di modernità e di un Occidente ancora cristiano ma libero dalla rigidità dottrinaria del Cristianesimo stesso; b) in quanto testo rappresentativo delle argomentazioni messe in campo nelle opere precedenti relativamente agli esiti dell’indebolimento dell’essenzialismo, dell’oggettivismo, del fondazionalismo; c) in quanto testo emblematico della ricchezza e profondità dei nodi etici ed esistenziali solitamente affrontati dall’autore. L’esame di questi ultimi ha reso possibile tracciare (e rintracciare) la linea teorica che dalla critica feuerbachiana al Cristianesimo arriverebbe fino all’idea, sostenuta da Vattimo, della secolarizzazione quale profanazione della metafisica che, però, avrebbe aperto paradossalmente al religioso un nuovo teatro d’azione.
[2] Ibid., p. 28.
[3] Ibid.
[4] Per ripercorrere la storia di tale idea nel panorama della filosofia occidentale, cfr. E. Lecaldano, Senza Dio. Storie di atei e ateismo, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 45-82.
[5] Cfr. R. Panikkar, La realtà cosmoteandrica. Dio-uomo-mondo, (1999), tr.it. Jaka Books, Milano 2004; R. Dworkin, Religione senza Dio (2013), tr. it. Il Mulino, Bologna 2014; G. Lingua, Esiti della secolarizzazione. Figure della religione nella società contemporanea, Edizioni ETS, Firenze 2013; M. Fraijó, Religione senza Dio, in «La società degli individui», XVII, 50, 2014, pp. 11-36.
[6] Allievo di Paul Ricoeur, insegna filosofia al Boston College e ha insegnato allo University College di Dublino e alla Sorbona di Parigi.
[7] «Quando parlo di anateismo non è certo mia intenzione propugnare un qualche tipo di nuova religione. Dio me ne guardi! L’anateismo non costituisce affatto l’ipotetica sintesi di un movimento dialettico che dal teismo, passando attraverso l’ateismo, giunge a un fine ultimo. L’anateismo non segue una metanarrazione sullo sviluppo dell’umanità che, partendo da una religione originaria, avrebbe maturato, attraverso una critica laica, una nuova forma di spiritualità per il terzo millennio […] Non si fonda su di un progresso periodizzato che va da una credenza arcaica a una postfede razionale. Qui non vi è alcuna teologia del compimento. […] Come l’archeologia, anche l’anateismo rifugge dalla teologia e si oppone all’idea di un’Origine e di un Fine perfetti. Che cos’è allora l’anateismo? Come suggerisce il prefisso ana, l’anateismo concerne la ripetizione e il ritorno, ma non nel senso di una regressione a uno stadio di perfezione anteriore così come accade nell’anámnēsis platonica, intesa come ricordo della propria pre-esistenza iperurania. E neppure nel senso di un ritorno a un qualche stato prelapsario di fede assoluta, prima che la modernità corrodesse ogni verità eterna. Non vi è nulla di nostalgico giacché, per dirla con Kierkegaard, il nostro interesse non è rivolto a un “ricordo” retrospettivo, bensì a una “ripetizione” in avanti. Il prefisso ana indica un’azione di ritorno a quella che io definisco una scommessa primordiale, a quell’istante iniziale di valutazione che è alla base di ogni credo. Esso segna una nuova apertura su quello spazio di libera scelta tra l’avere o il non-avere fede. In tal senso, l’anateismo costituisce la possibilità di scegliere di recuperare la propria fede operando tanto prima quanto dopo la divisione tra teismo e ateismo, e rendendoli in tal modo entrambi possibili. In breve, è un invito a rivisitare quella che potrebbe essere definita la scena originaria della religione: l’incontro con un totale Estraneo che abbiamo scelto, o meno, di chiamare Dio», R. Kearney, Ana-teismo. Tornare a Dio dopo Dio (2008), tr. it. Fazi, Roma 2012, pp. 7-8.
[8] «L’anateismo non è un ateismo che vuole eliminare Dio dal mondo, rifiutando il sacro a favore del secolare; e non è nemmeno un teismo che vuole liberare Dio dal mondo, rifiutando il secolare a favore del sacro. E infine, non è neppure un panteismo (antico o new age) che costringe il secolare e il sacro in una cosa sola, negando ogni distinzione tra il trascendente e l’immanente. L’anateismo non dice che il sacro è il secolare: dice che è nel secolare, attraverso il secolare, verso il secolare. Mi vorrei spingere sino al punto di dire che il sacro è inscindibile dal secolare, sebbene questi rimangano distinti. L’anateismo parla di “animazione reciproca” tra il sacro e il secolare, ma non di fusione o di confusione. Essi sono inestricabilmente connessi, ma mai la stessa cosa», ibid., pp. 219-220.
[9] Ibid., p. 173.
[10] Ibid., pp. 173-174.
[11] Ibid., p. 175.
[12] Ibid., p. 9.
[13] Ibid., p. IX.
[14] L. Feuerbach, Opere, a cura di Claudio Cesa, Laterza, Bari 1965, p. 370.
[15] «La teologia fonda l’etica sulla volontà di Dio; se essa si immagina semplicemente questa volontà come fondamento dell’etica perché è la volontà di Dio, il comando del Signore, allora essa ha un principio dell’etica arbitrario, non etico, un principio che annienta l’etica nella sua base, poiché il bene non ha altra potenza che la sua propria, deve legare e determinare l’uomo per se stesso, cioè non può esserci alcun altro fondamento al dovere etico di compiere il bene che il concetto del bene in e per se stesso», Id., Pierre Bayle. Un contributo alla storia della filosofia e dell’umanità, tr. it. La Città del Sole, Napoli 2008, p. 135.
[16] «L’antropotesimo è questo nuovo umanesimo che fa propri i caratteri positivi della religione, la sua affermazione dei bisogni del “cuore” e la sua dissoluzione del teismo in antropologia. L’antropoteismo è il cuore ridotto a ragione; esso dice nella testa in maniera intellettuale quello che il cuore dice a modo suo. La religione è soltanto affettività, sentimento, cuore, amore, cioè la negazione, la dissoluzione di Dio nell’uomo. La nuova filosofia è perciò, in quanto negazione della teologia, che nega la verità dell’affettività religiosa, la posizione della religione. L’antropoteismo è la religione consapevole di se stessa, la religione che comprende se stessa. La teologia invece nega la religione facendo finta di porla. La religione ha di fronte alla teologia e alla sua traduzione razionale, la filosofia speculativa, il vantaggio di identificare immediatamente l’essenza di Dio con l’essenza dell’uomo, l’essenza dell’uomo con l’uomo, e di avere a principio il “cuore”, il “bisogno”, la “sensibilità”, il “principio del materialismo”, non il pensiero astratto come la teologia e la filosofia speculativa: la nuova filosofia deve rivendicare a sé questa verità della religione», C. Ascheri, Feuerbach 1842. Necessità di un cambiamento, G. C. Sansoni Editore, Firenze 1970, p. 94.
[17] A proposito dei rapporti tra religione e teologia nella riflessione di Feuerbach, Bazzani sostiene che mentre il suo atteggiamento verso la religione è risultato talvolta oscillante, quello verso la teologia è stato costantemente critico, oppositivo. Tale divario si fa sempre più netto nel corso della sua produzione. Infatti, se ne L’Essenza del Cristianesimo «ci si limitava a dire che la teologia è la pretesa di sistemare in schemi di ragione quel che di fatto è altra cosa rispetto alla ragione, ovvero il “sentimento”, “l’animo”, nel ’46 si asserisce che la teologia è “il sistema della dipendenza dell’uomo”, la “forma dell’alienazione più estrema dell’uomo”, la radicale rescissione di ogni legame con la realtà effettuale dell’esistenza. Nel ’46, cioè, il divario appare più marcato proprio perché, finalmente delineati i tratti della filosofia dell’avvenire, dell’antropologia del futuro, si muove proprio dall’antropologico, dall’esistenziale, dal naturale-tecnico e meglio si sa determinare la religione quale re-ligio tra gli uomini e la teologia quale semplice discorso intorno a un Dio che può anche non avere alcuna parentela con questa re-ligio», F. Bazzani, Prefazione a L. Feuerbach, L’Essenza del Cristianesimo, Ponte alle Grazie, Firenze 1994 p. 28.
[18] L. Feuerbach L’Essenza del Cristianesimo, tr.it. Feltrinelli, Milano 2013, pp. 288-289.
[19] A giudizio di Feuerbach il cristiano ha avuto tutto in sé, tutto nel suo Dio e di conseguenza non ha avuto bisogno di completarsi attraverso l’altro (il rappresentante del genere), né di rapportarsi al mondo: «Dio è l’unico bisogno del cristiano; perciò gli altri uomini, la specie umana, il mondo, non rappresentano per lui una necessità, l’intrinseco bisogno degli altri non esiste. Dio rappresenta per me appunto la specie, l’uomo altro da me; anzi soltanto nell’allontanamento dal mondo, nell’isolamento, sento veramente il bisogno di Dio, sento viva la sua presenza, sento ciò che Dio è, e ciò che può essere per me. É sì vero che il religioso ha anche bisogno della comunità, della preghiera comune, ma il bisogno degli altri rimane pur sempre qualche cosa di molto secondario. La salvezza dell’anima è la cosa principale, il concetto fondamentale del cristianesimo, e questa salvezza è solo in Dio, solo nella concentrazione in Lui. Si richiede anche l’attività per gli altri, è una condizione per raggiungere la salute eterna, ma il fondamento della salute eterna è Dio, il rapporto immediato con Dio», ibid., p. 174.
[20] A. A. Bello, Il senso del sacro. Dall’arcaicità alla desacralizzazione, Lit edizioni, Roma 2014, p. 116.
[21] L. Feuerbach, Trenta lezioni sull’essenza della religione, tr. it. Battezzati, Milano 1872, p. 219.
[22] Id., Pierre Bayle. Un contributo alla Storia della Filosofia e dell’Umanità, cit., p. 237.
[23] A tal proposito, Bazzani nella sua Prefazione a L’Essenza del Cristianesimo di Feuerbach, sostiene che egli utilizza la religione «proprio contro il tempo presente, poiché il tempo presente, la filosofia moderna, razionalistica, è negatrice di quella vita, di quella corporeità, di quel riconoscimento della pulsionalità che la religione, pur se avvolta nelle maschere del misticismo, soprattutto nella sua forma luterana sa rivalutare», F. Bazzani, op. cit., p. 27.
[24] L. Feuerbach, Opere, cit., p. 374.
[25] Il riferimento è qui al pensiero hegeliano: «Feuerbach vuol fare i conti con Hegel, ma fare i conti con Hegel significa fare i conti con l’intera tradizione filosofica della modernità, poiché Hegel altro non sarebbe che il punto di culminazione di questa tradizione. E fare i conti con Hegel significa, anche, fare i conti con se stesso, mettersi alla prova, cioè autointerpretare la propria e personale teoresi», F. Bazzani, op. cit., p. 8.
[26] Feuerbach sostiene che la filosofia dell’avvenire, in quanto antropologia, debba diventare la nuova religione. Eppure come emerge dall’analisi di Perone, «Feuerbach, operando questa identificazione, non intende riferirsi alla religione, quale nel passato si è mostrata, ma a una religione che ancora non esiste, così come non intende parlare della filosofia quale è, ma quale deve essere compiuta. Filosofia e religione si identificano, ma la loro dimensione è quella del futuro. Esse non sono, ma saranno. La religione vera sarà la religione liberata da Dio, la filosofia vera sarà la filosofia che pone al centro del proprio interesse l’uomo. Dimensione del futuro e concretezza sono le qualità che religione e filosofia avranno in comune. In questa identificazione di religione e filosofia Feuerbach richiama evidentemente Hegel. […] Per Hegel filosofia e religione sono identiche, ma dal punto di vista della filosofia, per Feuerbach filosofia e religione sono identiche, ma dal punto di vista della religione. Per Hegel infatti la religione ha una razionalità intrinseca che la filosofia esplicita, assumendo il medesimo contenuto della religione, ma esprimendolo in una forma più adeguata, cioè per concetti. […] Feuerbach invece opera la stessa identificazione, ma a partire dalla religione. Non la religione sarà razionale, ma la filosofia sarà umana; non la religione si risolverà in conoscenza, ma la filosofia esprimerà l’amore. Tra i due opposti modi di intendere la realtà, uno teso al razionale e fondato sulla ragione, l’altro teso al concreto e fondato sull’amore, sarà il primo a doversi adeguare al secondo e a essere da questo riassorbito», U. Perone, Teologia ed esperienza religiosa in Feuerbach, Mursia, Milano 1972, pp. 175-177.
[27] Per cogliere il carattere positivo di questa critica Cfr. F. Engels, K. Marx, La sacra famiglia (1845), tr. it. Editori Riuniti, Roma 1969. Qui Marx fa emergere la sostanziale differenza tra il carattere assoluto della critica di Bruno Bauer (che si presenta come annichilimento, forza puramente distruttiva, terrorismo della teoria) e la maniera di criticare feuerbachiana. Così a proposito della critica pura di Bauer egli sostiene che essa nelle sue mani «è lo strumento per sublimare in semplice parvenza o in puro pensiero tutto ciò che, fuori dell’autocoscienza infinita, afferma ancora un’esistenza materiale, finita. Nella sostanza, egli combatte non l’illusione metafisica, ma il nocciolo mondano – la natura, la natura così come essa esiste fuori dall’uomo, e la natura come natura propria dell’uomo. Non presupporre la sostanza in alcuna cerchia - egli parla ancora in questa lingua – significa dunque per lui non riconoscere nessun essere distinto dal pensiero, nessuna energia naturale distinta dalla spontaneità spirituale, nessuna forza essenziale umana distinta dall’intelletto, […] nessun cuore distinto dalla testa, nessun oggetto distinto dal soggetto, nessuna prassi distinta dalla teoria, nessun uomo distinto dal critico […] nessun tu distinto dall’io», ibid., pp. 185-186. Dunque, in Bauer la critica rinuncia ai caratteri della negazione determinata: essa è contrapposizione netta, totale alla storia; il soggetto è annientatore dell’oggetto: tra i due c’è uno scontro senza alcuna possibilità di conciliazione. Infatti, il reale è, a suo giudizio, il soggetto e non l’oggetto, è la forza umana di criticare l’oggettivo e di toglierlo. Secondo Bauer la verità dell’uomo non è quindi la vita della natura, come per Feuerbach, bensì la via dello spirito; non è il materialismo ma la filosofia dell’autocoscienza. Pertanto Marx riconoscerà a Feuerbach il merito di aver elaborato una critica non più astrattamente razionalistica, assoluta, meramente annientatrice, ma umanistica, naturalistica, una critica che paragona l’esistente non più alla ragione, all’autocoscienza, a un’idea, bensì alla realtà umano-naturale: «solo Feuerbach, che ha completato e criticato Hegel dal punto di vista hegeliano, risolvendo il metafisico spirito assoluto nell’ “uomo reale che ha il suo fondamento nella natura” ha portato a compimento la critica della religione, tracciando nello stesso tempo i grandi e magistrali lineamenti per una critica della speculazione hegeliana e quindi di ogni metafisica», ibid., p. 183.
[28] È bene sottolineare fin da adesso che nello scritto di Vattimo preso in esame non si è riscontrata mai la presenza di un rimando esplicito al pensiero di Feuerbach. I suoi riferimenti teorici vanno dal pensiero di Nietzsche a quello di Heidegger, Habermas e Lévinas, per citare alcuni degli autori richiamati. In particolare, Vattimo prende le mosse dalla teoria nietzschiana della morte di Dio e si rifà alla teorizzazione dell’oltrepassamento della metafisica così come formulata da Heidegger, ossia lo sforzo di pensare l’essere non più come struttura obiettivante, bensì come evento, accadimento. Tale essere perde, così, per Heidegger quella stabilità che la tradizione metafisica gli aveva attribuito: non è più stabile, eterno, ma è ciò che di volta in volta accade nel suo evento. Davanti a questo essere come evento, il compito del pensiero è, secondo Heidegger, quello di rammemorare la sua storia, ma senza la pretesa di avere una conoscenza vera e completa di ciò che l’essere oggettivamente è. È per tale ragione che Heidegger ci dice che l’essere non è nulla di oggettivo e stabile, bensì quell’evento nel quale siamo sempre coinvolti come interpreti e in qualche modo in cammino. Vattimo quando parla di pensiero debole insiste proprio su questo aspetto della rammemorazione heideggeriana, sull’indebolimento dell’essere heideggeriano, un indebolimento che mette in crisi le pretese di perentorietà con cui si sono sempre presentate le strutture ontologiche della metafisica.
[29] La fede che Vattimo ritrova è una fede non dogmatica, vaga che si concretizza nell’espressione che egli stesso conia: “credere di credere”: «l’espressione suona paradossale anche in italiano: credere significa sia avere fede, convinzione, certezza di qualche cosa; sia opinare, pensare con un certo margine di incertezza. Per rendere il senso dell’espressione, direi dunque che il primo “credere” ha quest’ultimo significato, e il secondo dovrebbe avere il significato numero uno – aver fede, convinzione, certezza. Solo che è alquanto complicato mettere insieme i due sensi del verbo: se semplicemente opino, penso, ritengo con qualche probabilità di avere una certezza e una fede, la cosa risulta ambigua e sospetta. Eppure, ciò che intendo significare con questa espressione ambigua mi sembra un’esperienza abbastanza comprensibile e diffusa che molti di noi conoscono bene», G. Vattimo, Dopo la Cristianità, cit., p. 5. L’esperienza alla quale Vattimo fa riferimento è quella post-moderna, della fine della metafisica oggettivistica e dell’esperienza del pluralismo delle culture nonché della storicità contingente dell’esistere. È in tale contesto che Vattimo ritrova la fede in un Dio post-metafisico lui stesso, che «non “esiste” come una realtà “oggettiva” fuori dall’annuncio di salvezza che, in forme storicamente mutevoli e offerte alla continua reinterpretazione della comunità dei credenti, ci è annunciato dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione viva della chiesa. In un tale Dio non si crede nel senso “forte” della parola, come se la sua realtà fosse provata più che quella delle cose sensibili o degli oggetti della fisica e della matematica. […] Nel Dio della Rivelazione si crede perché se ne è “sentito parlare”, dunque con tutta l’incertezza che è legata alle cose che prendiamo per vere perché ci sono state dette da qualcuno in cui abbiamo fiducia, una fiducia però condizionata dal sentimento di amicizia, di amore, di rispetto. E si sa anche che spesso l’amore è cieco, non vede affatto le cose come sono nella loro verità “oggettiva”» ibid., p. 11. Da tali dichiarazioni emerge dunque il carattere peculiare della fede cristiana che Vattimo ritrova dopo la fine di ogni metafisica, ossia un credo completamente al di là di ogni dogma e autoritarismo, che presenta piuttosto «i tratti della congettura, della scommessa rischiosa, o infine dell’accettazione per amicizia, amore, devozione, pietas», ibid., p.12.
[30] Ibid., p. 15.
[31] «È proprio questo mondo quello in cui il “Dio morale”, cioè il fondamento metafisico, è morto e sepolto. Ma si tratta, appunto, di quello che Pascal chiamava il Dio dei filosofi. Sembra infatti da molti segni che proprio la morte di questo Dio abbia liberato il terreno per una rinnovata vitalità della religione. […] Oggi sembra proprio che uno dei principali effetti filosofici della morte del Dio metafisico e del discredito generale, o quasi, in cui è caduto ogni fondazionalismo filosofico, sia quello di liberare il campo per una rinnovata possibilità dell’esperienza religiosa», ibid., p. 19.
[32] «Quel che ridà peso alla voce e alla presenza della religione – in Occidente, al cristianesimo e specificamente al cattolicesimo – è anche la novità e gravità dei problemi di fronte a cui le nostre società si trovano a causa di certi sviluppi recenti della scienza e della tecnologia. Penso, com’è ovvio, ai problemi legati alla bioetica, e anche a quelli dell’ecologia. Soprattutto nel primo campo, le questioni che si aprono sembrano spesso troppo grandi per essere risolte con il solo aiuto dell’argomentazione razionale. Esse toccano quelle vere e proprie colonne d’Ercole che sono i confini tra vita e morte, o quelli della libertà e autodeterminazione, del destino della persona – dunque un terreno dove sembra inevitabile che si incontri il sacro. […] proprio gli scienziati oggi si trovano spesso confrontati con le questioni ultime. […] si potrebbe continuare a lungo a enumerare le motivazioni della ripresa di ascolto nei confronti della religione […] nel nostro mondo. Almeno un altro tema non può qui essere dimenticato: il significato che riveste la religione per gruppi sociali in cerca di una identità che li salvi dalla situazione di “anomia” […] in cui l’evoluzione del mondo tardo-industriale li ha gettati. Insieme alla gravità e novità dei problemi morali del tipo di quelli che ho evocato poco fa, questo bisogno di identità è un altro potente fattore di reviviscenza della religione nella nostra società», ibid., pp. 90-91.
[33] Ibid., p. 26.
[34] «Di derivazione apertamente kierkegaardiana è la differenza qualitativa che è alla base della teologia barthiana. Del resto Barth stesso, nella seconda edizione del suo commento all’Epistola ai Romani (1922) scriveva testualmente: “se ho un sistema esso consiste in questo, che cerco di tenere presente, con la maggiore possibile costanza, nel suo significato negativo e positivo, quella che Kierkegaard definisce: l'infinita differenza qualitativa tra il tempo e l'eternità. Dio è nel cielo, tu sei sulla terra. La relazione di questo Dio con questo uomo, la relazione di quest'uomo con questo Dio è per me il tema della Bibbia e al tempo stesso la somma della filosofia. I filosofi chiamano questa crisi della conoscenza umana: l'origine. La Bibbia vede a questo incrocio di vie Gesù Cristo”. Fondandosi su questa citazione, Barth è stato considerato da molti critici, come uno dei promotori della Kierkegaard-Rènaissance. Ma questo non rende ragione di tutto Barth, non degli sviluppi posteriori del suo pensiero: egli non va a sfociare in una filosofia dell’esistenza, in una tormentosa escavazione del Dasein per estrarne la soluzione immanente dell’enigma dell’esistenza. Dopo la riconquista del “totalmente altro”, si stabilisce nella certezza di una concezione teocentrica. Forse i critici hanno esagerato sulla portata di questa dichiarazione di Barth, arrivando alla conclusione che Kierkegaard sia, se non proprio l’unica, almeno la sorgente principale del pensiero barthiano. Noi, invece, pensiamo che vi siano stati altri profondi influssi che hanno aiutato Barth a definire il rapporto tra tempo ed eternità, tra uomo e Dio. Non si può negare, del resto, che egli abbia evitato volutamente un aspetto essenziale del pensiero kierkegaardiano (l’orientamento verso l’esistenza!) e ciò sarebbe già sufficiente a non farlo considerare suo “discepolo”, oltre al fatto che negli anni successivi, Barth, in tante maniere, ha fatto intendere che il suo accostamento al teologo danese è stato casuale o meglio ancora provvisorio. Così quando si rese conto che l’individualismo esistenzialista è sulla stessa linea dell’esperienza mistica, per la quale già Kierkegaard s’era piegato al pietismo, mantenne di Kierkegaard il contrasto dualistico- paradossale, il concetto della differenza qualitativa tra Dio e la realtà cosmica, ma s’oppose all’intimità, al soggettivismo di lui. Insomma, Barth attinge a Kierkegaard, ma non si tratta di una semplice ripetizione dei principi teologici del Danese: Barth, prima che gli elementi del pensiero kierkegaardiano passino nel suo sistema, li medita, li vaglia, li adatta alla sua maniera di concepire la teologia», N. Longobardi, L’ecclesiologia di Karl Barth nel Romerbrief, Pontificia Facoltà Teologica S. Aloisius, Napoli 1973, pp. 80-82.
[35] G. Vattimo, Dopo la Cristianità, cit., p. 94.
[36] Anche in questo caso vale la pena sottolineare che non c’è nel testo preso in esame alcun richiamo di Vattimo a Feuerbach e alla sua teoria relativa al rapporto Io-Tu, ma i principali riferimenti teorici dell’autore rispetto al tema dell’altro, risultano essere filosofi come Lévinas, Habermas e Davidson.
[37] Ibid., p. 117-118.
[38] K. Barth, La teologia protestante nel XIX secolo (1946), vol.2, tr. it. Jaka Book, Milano 1979, p. 122.
[39] R. Rorty, Anticlericalismo e ateismo, in R. Rorty, G. Vattimo, Il futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, a cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 2005, pp. 33-45.
[40] R. Rorty, G. Vattimo, op. cit., p. 39.
[41] Ibid., p. 37.
[42] Ibid., p. 45.