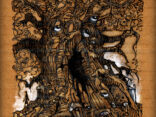Autore
Indice
1.Perché occorre mantenere il significante semi-vuoto “Antropocene”
2. Perché occorre mantenere la nozione di “mondo” e di “rapporto al mondo”
3. Tesi n. 1. Il problema centrale della contemporaneità e il senso della crisi non è rappresentato dalla fine della natura, di cui occorre accelerarne la dissoluzione, ma dalla fine del mondo
4. Tesi n. 2. La fine della natura può avere l’effetto di accelerare la decomposizione del “rapporto al mondo” come sistema complesso relazionale di differenti potenzialità d’azione – questo effetto è da evitare
5. Tesi n. 3. Il “mondo” e il “rapporto al mondo” (umano e vivente) devono essere ripensati nei termini di una relazionalità profonda non più binaria né soltanto intra-specifica, al di là della dicotomia tra “parti discrete” e “Tutto indiscreto”, come un rapporto vivente e non gerarchico – resta il problema del che fare?
6. Tesi n. 4. La riattivazione del “rapporto al mondo” (umano e vivente) per procedere oltre la crisi simbolica, economica ed ecologica necessita della riattivazione del conflitto che, mettendo in discussione gli assunti binari e gerarchici della modernità, metta nuovamente in discussione il modo di produzione capitalistico
S&F_n. 22_2019
Abstract
Considerations on the concept of world and of relationship to the world in the age of Anthropocene: essay on XXI century philosophy
The essay intends to analyze the notion of “world” and “relationship to the world” as a crucial problem connected to the symbolic, economic and ecological crisis. The reflection starts from the analysis of the complex notion of “Anthropocene” (and why it should be conserved) and from the analysis of the notion of “world” (and why it should be conserved as a “relationship to the world”). The essay then proposes four theses on how to understand the “world” and the “relationship to the world” through a critical discussion especially with the theories of Bruno Latour, Quentin Meillassoux and Donna Haraway. The development of the essay leads to the central question of the need for conflict and for overcoming of the modern imaginary and the capitalist mode of production as the only possible solution to the “loss of the world” and to the contemporary symbolic, economic and ecological crisis.
Tutti vogliono possedere la fine del mondo
Don DeLillo
- Perché occorre mantenere il significante semi-vuoto “Antropocene”
Occorre partire da una domanda: perché mantenere la definizione di Antropocene[1] come bussola per orientarsi nella complessità della contemporaneità e nelle sinuosità del rapporto vivente con il “mondo”? La domanda non è di poco conto, data la diffusione sempre più ampia di questo significante, e la posta in gioco è quanto mai alta, soprattutto perché, come è stato sottolineato più volte, esiste un concetto geologico di Antropocene (del resto è in quell’ambiente che è nato) ed esiste parallelamente un concetto di Antropocene alla moda[2]: se il primo ha posto indubbiamente le basi per il secondo, il secondo muovendo dal primo lo ha mantenuto essenzialmente come riferimento iniziale o sfondo, prendendo strade molte variegate (e controverse) e impregnando di sé non solo la riflessione teorica ma anche, giusto per fare qualche esempio, l’esperienza artistica e letteraria[3]. Se un concetto – mettendo tra parentesi per il momento il suo valore o pregnanza – riesce a esondare dai confini disciplinari e a inondare un territorio sempre più ampio di saperi e pratiche (rivelando così la sua potenza “ecologica”[4]), allora mostra già di per sé la sua rilevanza, rilevanza immediata che è testimoniata dal fatto che ci si ritrova in una fase in cui evidentemente le comuni abitudini di pensiero non bastano più (sia nella dimensione del “senso comune” sia all’interno degli studi specialistici), dal fatto che si ha la percezione di essere dinanzi a un sommovimento tellurico delle certezze ritenute evidenti fino a poco tempo fa – ci troviamo, utilizzando una concettualizzazione foucaultiana, all’interno di una problematizzazione che diviene compito per il pensiero[5].
Un fenomeno alla moda – e la moda stessa è un fenomeno pienamente moderno e contemporaneo – va analizzato sempre e comunque, in quanto manifesta in maniera chiara e limpida quello che possiamo definire un vero e proprio sintomo che può permettere di accedere, mediante una complessa eziologia teorica e pratica, a una specifica patologia del tempo, e il compito della filosofia non può che essere quello di muoversi, percependo la necessità etico-politica di questo movimento, all’interno di questa patologia, al di là se si ritenga corretto il significante Antropocene (l’anamnesi), se si ritenga di vivere davvero in una nuova era geologica (la diagnosi), se la prognosi la si possa intendere come riservata oppure no: insomma, bisogna dirigersi lì dove il sintomo sembra essere più violento e la sfida terapeutica e farmacologica (nel senso di Isabelle Stengers[6]) deve essere raccolta.
Dunque, possiamo affermare che questo significante – Antropocene – che è possibile definire semi-vuoto, nella misura in cui può essere riempito (ed è stato e presumibilmente sarà riempito) delle nozioni più disparate, deve essere mantenuto (“mantenuto” in tutte le forme che ha assunto, da Capitalocene[7] a Chthulucene[8] passando per Plantationocene[9] – da mantenere insomma è l’idea dell’ingresso in una nuova “epoca” storica umana che è contemporaneamente una nuova epoca geologica, o, in maniera ancora più generale, l’idea dell’attraversamento di una “linea”, di un punto di non-ritorno, che invoca un impegno etico-politico e teorico) in quanto può permettere di analizzare un passaggio decisivo ed epocale per quanto concerne l’esperienza vivente del vivente umano e nonumano, una nuova rappresentazione dell’esperienza interconnessa di differenti elementi del reale o che, per meglio dire, compongono il reale in un’idea di “mondo” del tutto nuova e da esplorare. Certo, il problema della percezione della temporalità specifica dell’Antropocene è in connessione con i problemi strettamente imbricati del moderno e del postmoderno: nel momento in cui non è ancora chiaro se l’epoca dell’Antropocene ci traghetterà al di là o al di fuori della modernità (laddove, per modernità, intendiamo in via preliminare il connubio di razionalità riflessiva e modo di produzione capitalistico), sembra essere comunemente ammesso che questo significante semi-vuoto ha permesso di leggere in stretta filiazione il postmoderno rispetto al moderno e di leggere dunque modernità e postmodernità come un unico progetto complessivo, incompiuto e fondamentalmente da superare – e così, come risulterà chiaro nel corso della trattazione, il problema del postmoderno (nella sua derivazione dal moderno), quando è esplicitato, lo è soltanto nella misura in cui l’ingiunzione fondamentale è quella di un suo parziale superamento, e quando non è esplicitato, è perché se ne percepisce una continuità con l’incompiutezza del programma della modernità[10].
Se si intende mantenere, dunque, il concetto di Antropocene è perché abbiamo la chiara rappresentazione di un passaggio, l’idea che l’immagine della relazione tra bios, logos e “mondo” ne uscirà comunque trasformata in maniera radicale, perché ad essere trasformata in maniera radicale potrebbe essere allo stesso tempo sia l’immagine che abbiamo della realtà materiale che la stessa realtà materiale all’interno della quale siamo immersi. Si tratta, allora, di una nozione-soglia: di una nozione fondamentale in quanto sta facendo lavorare contemporaneamente le commissioni internazionali di geologia (di qui la battuta di Bruno Latour: «lo Zeitgeist deciso da una sottocommissione?»[11]) e gli “esperti” di scienze umane e sociali; di una “soglia” decisiva in quanto sembra che possa condurre a un ripensamento di una serie di categorie che hanno permeato in maniera fondamentale quella specifica epoca umana che chiamiamo modernità/postmodernità (il segno diacritico “/” viene utilizzato, qui, per mostrare l’intima connessione tra i due elementi che soltanto per comodità e abitudine occorre mantenere separati): dal problema dell’antropocentrismo e del postantropocentrismo a quello più astratto della relazione soggetto/oggetto, dalla questione della temporalità che deriva da una connessione tra storia geologica e storia umana[12] al nodo fondamentale di che cos’è il mondo; il tutto mettendo in discussione la complessa articolazione epistemologica che ha attraversato l’epoca umana degli ultimi secoli e cioè la distinzione tra natura e cultura.
Il ripensamento di queste categorie fondamentali non è altro che il ripensamento dell’esperienza nella sua complessità, in vista di quella che abbiamo già definito un’esperienza allargata[13]: per esperienza, occorre intendere una stretta connessione tra il bios, la specifica postura dei viventi umani e nonumani che si trovano ad agire nel mondo, imbricati con esso in una relazione immanente e contingente di co-evoluzione e co-produzione, il logos, la specifica maniera mediante la quale il vivente umano costruisce rappresentazioni che determinano, definiscono e/o negano l’originaria co-appartenenza di vita e mondo, e il “mondo”, la specifica maniera mediante la quale si manifesta da un lato l’intricato “rapporto” tra le potenze di agire dei viventi umani e nonumani e dall’altro una sorta di resistenza del reale che determina nuove prospettive di contingenza e che si palesa come agente complesso esso stesso.
In questo saggio intendiamo analizzare alcune trasformazioni che si sono avute all’interno della nozione di “mondo” nella filosofia contemporanea (tra gli ultimi scorci del XX secolo e i primi due decenni del XXI secolo) – quella che possiamo definire l’ultima sopravvissuta tra le idee metafisiche della modernità (secondo lo schema loewithiano, e ovviamente kantiano, di Dio, uomo, mondo[14]): partendo dal presupposto che il concetto di Antropocene non può essere compreso se non in stretta connessione con l’emergenza epocale del surriscaldamento globale – con la rappresentazione sempre più chiara di una possibile fine del mondo senza alcun Regno ad attendere i “buoni”[15] – si intende proporre alcune tesi che riguardano il ripensamento di alcune categorie fondamentali del moderno (di cui abbiamo fatto cenno poco sopra), lavorando intorno alla relazione tra epistemologia e ontologia così come viene fuori dalle due immagini del “mondo” più efficaci degli ultimi anni, da un lato il materialismo speculativo di Quentin Meillassoux e dall’altro la rinascita dell’ipotesi Gaia negli scritti di Isabelle Stengers e Bruno Latour (in stretto dialogo con l’originale immagine della tentacolarità nell’ipotesi di Donna Haraway).
- Perché occorre mantenere la nozione di “mondo” e di “rapporto al mondo”
Ma prima di affrontare la questione del “mondo” nella riflessione del XXI secolo, in quel clima culturale che intendiamo continuare a chiamare “Antropocene”, occorre chiedersi in che senso sia opportuno mantenere la nozione stessa di “mondo” e quella ancora più decisiva (seppur, come vedremo, criticata) di “rapporto al mondo”. Come nota giustamente il filosofo tedesco Karl Löwith il “mondo” «è da concepirsi non isolatamente, bensì soltanto a partire dal suo rapporto con Dio e uomo»[16]: riteniamo che lo dica giustamente non per riproporre una visione onto-epistemologica propria della modernità, per cui soltanto il correlazionismo (e il costruzionismo o costruttivismo) sarebbero le uniche chiavi possibili di accesso a una qualche riflessione sul “mondo” (questione che sarà al centro di alcune analisi contenute in questo saggio), ma perché nella storia del pensiero occidentale, queste tre determinazioni si sono sviluppate costantemente in relazione reciproca, provocando smottamenti e spostamenti, centralità nuove e decentramenti inaspettati. Se l’Antropocene – o quello che si intende con questa parola-sintomo – ha un senso ed è compito per il pensiero, lo è proprio nella misura in cui rimette in discussione il problema della “rapporto” vivente in tutte le sue forme di espressione: quando si parla, in maniera ecologicamente naïf, di dover “salvare il mondo”, cosa si intende di preciso? Qual è il “mondo” da salvare? Cosa si nasconde dietro questo “compito” che (un po’ ipocritamente e senza impegno) l’uomo occidentale della contemporaneità si assegna? Quali determinazioni dell’umano e del divino vengono fuori da queste riflessioni e da questi compiti? Che tipo di “rapporto al mondo” va prima analizzato e decostruito e poi (chissà) istituito in maniera rinnovata?
La messa in discussione della nozione di “mondo” che la modernità ci ha consegnato – messa in discussione che troviamo in molta della filosofia contemporanea – può essere colta preliminarmente ragionando in termini di definizione di questo rapporto fondamentale con l’umano e il divino. E allora ha sicuramente e nuovamente ragione Karl Löwith quando racconta in pochi passaggi l’evoluzione dell’idea di “mondo” da qualcosa di «originariamente divino» nella percezione greco-romana a «creazione di un Dio sovrannaturale» nella percezione cristiana a «qualcosa divenuto senza Dio» nella percezione moderna ai differenti tentativi di ri-condurlo a qualcosa di «ridivinizzato» nella percezione nietzschiana[17]. Sembra essere chiaro che, nell’idea di “mondo”, ne va dell’idea del divino e dell’umano, e che l’idea del “divino” e delle mitologie e cosmologie ad esso connesse (il piano del “simbolico”, come intuito sin dagli albori delle scienze sociali da Émile Durkheim[18]) non è mai una questione definitivamente superata né forse superabile.
I passaggi ritrovati dal filosofo tedesco sembrano ancora adeguati all’analisi del problema. In ambito greco «il mondo è il tutto […] un “Dio visibile” […] non è dominato da leggi prestabilite e ad esso imposte da un intelletto divino o umano»[19]; il mondo non ha inizio e non ha fine nel tempo, è perfetto nella misura in cui è “concluso”, finito e non infinito nello spazio, in quanto è “cosmo”, cioè ordine, ed è «a differenza del caos, un ordine che esiste così e non altrimenti, che cioè è necessario e contemporaneamente strutturato secondo una gerarchia, in cui l’uomo mortale occupa un posto determinato, cioè subordinato»[20]; in questo “mondo”, che ha nella necessità della sua gerarchia l’elemento decisivo della sua “autonomia”, il logos non può essere altro che ciò che «si eleva oltre la terra», in quanto il vivente umano è sì «relativamente il più perfetto» all’interno della natura, ma il suo movimento vitale non è circolare, dunque perfetto, come quello degli astri, perché non ricongiunge mai la fine con l’inizio[21]; l’umano è un vettore che incrocia tangenzialmente la perfetta armonia circolare dell’esistente, mentre il “mondo” è semplicemente il divino.
La prima soglia determinante in questo racconto è rappresentata dalla “perdita del mondo” che inizia a prodursi a partire dai primi secoli dell’età cristiana: se il “mondo” nel suo essere ordine e armonia trovava la sua forma di rispecchiamento e di visibilità nel “politico”, le mutate condizioni, che si iniziano ad affacciare nell’età alessandrina e che vengono portate a compimento dalla pax augustea, producono un ripiegamento nell’interiorità del sé (inizialmente con i culti misterici e poi, in maniera “aperta” ed “ecumenica”, nel cristianesimo) che ha come contraltare la definizione di una nuova percezione del “mondo” come esteriorità, producendo un nuovo “rapporto al mondo” che si costruisce mediante questa dinamica e questo “movimento” costante da un dentro verso un fuori, e da un fuori verso un dentro. È a questo punto che il “mondo” in quanto esteriorità diviene semplicemente, nel Cristianesimo, «una creazione in vista di uno scopo e, da ultimo, come una macchina»[22]: dunque, da un lato il “mondo” viene depotenziato e denaturalizzato perché non possiede più la perfezione dell’essere totalità (la scissione fondamentale è proprio tra “mondo” e “Dio”), non è più ciò che auto-sussiste né che ha la sua potenza di agire nel senso di un auto-movimento vitale e creatore, dall’altro diviene allo stesso tempo qualcosa creato per l’uomo affinché lo accompagni e sia risorsa per la sua avventura esistenziale e qualcosa che va superato e, al limite, disprezzato, in quanto unico oggetto di amore può essere soltanto l’Amore stesso, cioè questo Dio che si è staccato dalla natura e ha occupato una posizione trascendente e che mostra di avere un certo “debole” per questa creatura specifica che è il vivente umano.
Se il momento decisivo, la soglia determinante, è rappresentata da questa che possiamo definire come una scissione tra “mondo” e “divino”, è anche vero che l’altra scissione determinante che si è andata a produrre è quella tra “mondo” e “vivente umano”: la “perdita del mondo” conduce, dal punto di vista del logos, al fatto che l’unica e prima certezza (allo stesso tempo “teoretica” e “morale”) può essere, non l’evidenza di un mondo visibile, ma la coscienza interiore di se stessi (il nesso Agostino-Cartesio), per cui «nella nostra coscienza comune il mondo è rimasto fino ad oggi un mondo esterno, presumibilmente perché noi siamo pur sempre ancora cristiani […] senza credere in Dio e senza pensare alla salvezza dell’anima»[23].
Nasce, allora, un nuovo “rapporto al mondo”, per certi versi determinante fino ai giorni nostri: volendo procedere anche un po’ oltre la riflessione di Karl Löwith, da un lato possiamo notare come, mediante la dinamica di interiorità/esteriorità, il “mondo” divenga ciò che è a disposizione del vivente umano (dal punto di vista “intellettuale” e dal punto di vista dell’homo faber), un mondo che forse non viene disprezzato più ma che è comunque visto costantemente come una “risorsa” (anche nei termini di una “natura selvaggia” che rilassa dallo stress della vita moderna), dall’altro diviene il luogo della messa alla prova dell’esistenza umana, sfondo e scenografia dell’unica potenza di azione (agency) immaginabile, quella umana – anzi, proprio all’interno di questa ri-problematizzazione del “mondo” in funzione umana, sorge l’idea della vita umana come e-sistenza e della “natura” come ciò che è semplicemente presente. Ha ragione, allora, Karl Löwith quando afferma che questa dinamica di esteriorizzazione del mondo e di interiorizzazione del sé non può che produrre un duplice movimento, e questi spostamenti, a partire dalla prospettiva da cui stiamo muovendo, manifestano esattamente ciò che diviene-problema nella percezione dell’Antropocene:
1) «l’uomo si ritrova senza posto e spaesato», dice il filosofo, in quanto diviene (e si percepisce) sempre di più come una e-sistenza del tutto contingente e assurda[24] – la “perdita del mondo”, che come abbiamo visto rappresenta la soglia fondamentale di questa narrazione, nell’epoca dell’Antropocene, in cui sembra potersi realizzare effettivamente e non soltanto nell’immaginario del tempo dell’attesa apocalittica (il katéchon), sembra poter condurre a un’uscita dal mondo fantasmatico e paranoide dell’uomo moderno per divenire nuovamente “realtà”, e così l’emergenza connessa al surriscaldamento globale, in relazione con un mondo completamente secolarizzato, in cui si tende a credere sempre meno all’avvento del Regno dopo l’Apocalisse, rende il vivente umano sempre più senza collocazione, una sorta di “anomalia”, di “malattia mortale” per il “mondo”;
2) l’uomo acquista una centralità inedita (il nodo dell’antropocentrismo o, nei termini loewithiani, dell’“antropo-teologia”), centralità che risulta essere nutrita dall’idea stessa dell’Antropocene – l’umano è visto addirittura come forza geologica e non solo biologica, come quel vivente che può giocare con i destini strutturali del “mondo” e, grazie al potenziamento del suo logos tecnologico, potrebbe al limite trasformare il “mondo” in un laboratorio bio-ingegneristico[25]; questa centralità è, però, ambigua e ideologica perché risulta essere messa costantemente in discussione mediante il dominio tecno-cratico e post-antropocentrico del capitalismo globalizzato di cui la maggior parte della popolazione globale si trova ad essere “schiava” fin nelle sinuosità della propria costituzione biogenetica, mediante la trasformazione della forma-di-vita umana in qualcosa da “potenziare” in vista della produttività, o da “sfruttare” in vista delle costituzione di una “risorsa” a buon mercato.
In vista del superamento del duplice movimento di esteriorizzazione del mondo e interiorizzazione del sé, è possibile affermare che il concetto di “mondo” sia un concetto essenzialmente normativo, e allo stesso tempo che il “rapporto al mondo” sia sempre vivente perché si costituisce a partire da quella porzione specifica di “mondo” che è il corpo vivente: in effetti, è proprio il fatto che il corpo vivente sia essenzialmente “finito” (nel duplice senso di finitezza e confine) che si dà la possibilità di “mondo”, e il “mondo” accresce la sua normatività a partire dall’ampiezza della potenza di agire (agency) virtuale di un corpo vivente in relazione con le potenze di agire di tutti gli altri corpi viventi[26]. Utilizziamo il sintagma “corpo vivente” e non “corpo umano” proprio perché, come si cercherà di analizzare nel corso della trattazione, l’agency a fondamento della possibilità di esistenza di un “mondo” non appartiene soltanto all’umano (sarebbe ancora una volta un ulteriore rifugio del suo eccezionalismo) ma al vivente in generale.
La questione della nozione di “mondo” e di “rapporto al mondo” deve essere innanzitutto discussa mediante un’analisi della nozione di natura, nelle loro differenze costitutive, e soltanto successivamente mediante nuove rappresentazioni che in un modo o nell’altro, in maniera positiva o negativa, raccontano la necessità di ripensamento di questo “rapporto”. Tenendo però fermo un punto: la riflessione sulla relazione tra bios, logos e “mondo” a partire dall’esigenza di un’esperienza allargata è sempre “ecologica”, e l’ecologia, per la sua natura di riflessione complessiva sulla “relazione”, è sempre politica.
- Tesi n. 1. Il problema centrale della contemporaneità e il senso della crisi non è rappresentato dalla fine della natura, di cui occorre invece accelerarne la dissoluzione, ma dalla fine del mondo
Secondo Bruno Latour la fine della natura è già avvenuta[27] e il vero problema è il rinnovamento del rapporto al mondo: per “fine della natura” occorre intendere la fine di un certo immaginario sulla natura, mentre per “rinnovamento del rapporto al mondo” occorre intendere un nuovo modo di pensare l’imbricamento essenziale e originario tra viventi umani, viventi nonumani e realtà extravivente. La tesi è sicuramente radicale: il surriscaldamento globale e il problema che provvisoriamente possiamo definire ecologico non rappresentano più una semplice crisi («un modo per rassicurarsi dicendosi che “passerà”; che la crisi “sarà ben presto alle nostre spalle”»[28]), quanto piuttosto «una profonda mutazione del nostro rapporto al mondo»[29]. Ci troviamo così dinanzi a una soglia davvero determinante: la situazione dell’umanità nell’epoca dell’Antropocene dispiegato e del surriscaldamento globale con caratteristiche di una certa irreversibilità sarebbe quella del “si sarebbe potuto agire” (dal momento che di crisi ecologica si parla da circa quarant’anni), e sarebbe questo il motivo per cui, nei fatti, non si agisce in maniera perentoria dinanzi a un “mutamento” di cui non è possibile prevedere l’evoluzione; è come se si trattasse di una sorta di “rimozione” le cui origini affondano nel mondo delle idee e nella specifica relazione tra ontologia ed epistemologia così come si sono costituite nella modernità in stretta correlazione con l’avvento del modo di produzione capitalistico. Il nodo centrale, dunque, e il compito determinante, dovrebbe essere quello di una trasformazione radicale del modo specificamente umano di essere al mondo, una trasformazione radicale che dovrebbe mettersi alle spalle l’intero progetto incompiuto della modernità: se da un lato bisognerebbe superare l’immagine politica di una “natura” che è a disposizione dell’umano come risorsa a cui attingere come speculare all’immagine onto-epistemologica di una “natura” che è a disposizione della conoscenza umana come “oggetto” separato e contrapposto, dall’altro bisognerebbe pensare un modo differente di costituire questo rinnovato “rapporto al mondo”, il quale non può prescindere da un’immagine della natura che «non è una natura-risorsa ma piuttosto una natura-matrice: una natura che opera non solo al di fuori e all’interno dei nostri corpi (dal clima globale al macrobioma), ma anche attraverso i nostri corpi, includendo le nostre menti incarnate»[30]. Il problema è che quando si parla di “rapporto al mondo”, di appartenenza al mondo, la definizione di mondo si trova immediatamente duplicata in una percezione di appartenenza a una “natura” e una percezione di appartenenza a una “cultura” (nel senso di mondo culturale di riferimento): l’uomo duplicato e a due dimensioni della modernità si trova stretto costantemente tra le ingiunzioni di un “mondo della natura” idealizzato (e “ideologizzato”) e quelle di un “mondo della cultura” formalizzato. È per questo che, quando si afferma che il problema ecologico dovrebbe essere affrontato mediante un ritorno dell’uomo alla natura, non si comprende bene cosa possa significare[31]: il ritorno alla natura può avere sicuramente una risonanza new age (e, in questo senso, ha una funzione di rasserenamento meramente fantasmatico e individualistico), ma impregna di sé anche e soprattutto l’immaginario della green economy la quale muove sempre dall’idea di questa “divaricazione” tra uomo e natura (come entità sempre e comunque separate, quasi in senso teologico-cristiano, come manifestazione ultima e ulteriore dell’eccezionalismo umano), per cui la soluzione è da trovarsi in un modo più “rispettoso” di rapportarsi alla natura, senza chiaramente mettere troppo in discussione i dividendi delle multinazionali e senza mettere in discussione in alcun modo il dogma della “crescita sostenibile” – insomma, si tratta di un modo di essere “responsabili”[32] dinanzi alla natura (come un buon padre di famiglia in una società patriarcale), la quale resta comunque a nostra disposizione, naturalmente sotto il nostro dominio. Dunque, new age e green economy – nell’orizzonte di un “controllo” della natura idealizzata e oggettivata, lì, immobile, prevedibile e semplicemente presente, come relax e risorsa per il vivente umano – condividono il medesimo terreno di coltura: un terreno che, a quanto pare, sembra essere irrimediabilmente avvelenato.
La (immagine della) natura di cui si dovrebbe volere fino in fondo la fine, allora, ha avuto essenzialmente due funzioni (si noti che la modernità scinde “natura” e “cultura”, creando due territori differenti e contrapposti, ma poi costantemente fa agire le ingiunzioni dell’una sull’altra e viceversa, creando ibridi di immaginario e soprattutto manipolazioni di carattere ideologico[33]): la prima concerne una forma specifica di “eternizzazione” di alcuni elementi che si vogliono imporre come ideologicamente determinanti – si tratta di quello che possiamo chiamare “dispositivo di naturalizzazione” in connessione con un fondamentale e fondante “determinismo biologico” che impregna di sé spesso e volentieri sia le scienze dure che quelle morbide, e che si trova ad agire soprattutto all’interno del sistema di pensiero connesso al liberismo e al neoliberismo economico (dal momento che la garanzia della “giustizia” del sistema non poteva essere più affidata a un’entità trascendente di origine divina): si va dall’uomo egoista per natura e che deve perseguire il proprio egoismo anche in vista del bene comune (la famosa, quanto inquietante, mano invisibile) alla necessità di rafforzare la “natura” dell’uomo in vista dell’accrescimento delle sue potenzialità di investimento produttivo (il nodo del “capitale umano”), senza tacere tutta la storia dell’imperialismo e del razzismo occidentale; la seconda concerne la rappresentazione della “natura” esterna e interna all’uomo come una sorta di paradiso perduto verso il quale l’uomo dovrebbe tendere per riscoprire se stesso in questa specularità originaria (una sorta di movimento profondo dell’esistenza umana verso l’origine che ha la caratteristica di presentarsi sempre come la sua realizzazione ultima) e che si esplica all’interno di un racconto della natura come wilderness[34], come quella dimensione selvaggia che l’uomo avrebbe tradito ma di cui sente ancora forte il richiamo ineludibile. Anche se apparentemente sembrano la rappresentazione di due visioni contrastanti (e, sulla superficie dei saperi e delle percezioni, è indubbiamente così), si tratta invece di due narrazioni della “natura” che hanno senso soltanto all’interno di un dispositivo onto-epistemologico complessivo che si fonda su una scissione profonda tra la dimensione del “naturale” e quella del “culturale/sociale” – il gesto che ha prodotto questa duplice visione è il medesimo ed è aurorale e consustanziale alla nascita della modernità; si tratta dunque di due rappresentazioni che manifestano una specularità rovesciata, determinante, nella misura in cui la “natura” è sempre funzione/risorsa di una “cultura” umana che, pur essendo oramai irrimediabilmente separata dal tutto naturale, in esso trova la possibilità della sua destinazione ultima, sia all’interno di un dispositivo economico che pesca alla cieca dalla metaforica delle scienze naturali sia come valvola di sfogo per le amarezze della realtà sociale. Ma la “fine della natura” ha anche un aspetto ulteriore e il “naturale” ha avuto e ha ancora una funzione ulteriore. Come ha notato giustamente Isabelle Stengers «il naturale, nel senso del tristemente prevedibile, è ciò che serve d’argomento per coloro che si sentono responsabili» per cui «la barbarie è oggi il tristemente prevedibile»[35]. L’elemento ulteriore che appartiene al nostro immaginario scientifico è quello della prevedibilità della natura, l’idea seminale e fondativa della scienza moderna per cui la natura si comporta sempre allo stesso modo, e, se gli scienziati più prudenti hanno decisamente limitato il presupposto determinista di Laplace, secondo il quale se in un dato istante un’intelligenza arrivasse a una conoscenza complessiva di tutte le forze che animano la natura (dall’universo complessivo al singolo atomo) non vi sarebbe più nulla di incerto e il futuro, come il passato, sarebbe perfettamente presente, il senso comune delle pratiche scientifiche – e gli eccessi ecomodernisti – ci raccontano ancora di una natura che ha un certo grado di prevedibilità e dunque di governabilità. La prevedibilità rappresenta un ulteriore elemento del grande racconto della modernità che ha come protagonista l’uomo e il suo dominio sulla natura: l’uomo, grazie alla costruzione delle leggi di natura, non solo può comprendere il funzionamento del mondo, ma può prevederne gli sviluppi e giocarli a proprio favore. Il surriscaldamento globale – e dunque l’emergenza ecologica ai tempi dell’Antropocene – fa saltare questo elemento di prevedibilità della natura, trascinando lentamente con sé anche le altre due funzioni di cui abbiamo discusso: si tratta di una sorta di “intrusione”[36], una natura che sembra ribellarsi alla presa politica, ontologica ed epistemologica dell’uomo. Ma è chiaro che la natura non si ribella all’uomo – non si tratta di un “soggetto” nei termini in cui l’uomo ha sempre pensato a se stesso, del resto si tratterebbe di una forma ingenua di antropomorfismo – perché la “natura”, intesa allo stesso tempo come qualcosa di selvaggio e minaccioso, di fragile e da proteggere, come risorsa sfruttabile a buon mercato[37], semplicemente non esiste più, nella misura in cui non è mai esistita. Il sogno della modernità, da intendersi come progetto incompiuto fondato su razionalità riflessiva e modo di produzione capitalistico, si starebbe lentamente avviando a conclusione e il risveglio sembra poter avere tonalità drammatiche: l’ingiunzione fondamentale è che occorre, dal punto di vista “simbolico”, superare la dicotomia natura/cultura e ripensare il modo del rapporto al mondo, e, dal punto vista economico-politico, superare i rapporti di produzione di tipo capitalistico (sia nel senso del “capitalismo fossile”, sia nelle derive biogenetiche, sia nel senso complessivo di un modo di organizzare la società mondiale), il tutto prima che il mondo finisca – la crisi ecologica è allo stesso tempo crisi economica e crisi dell’immaginario simbolico. Soltanto in questo senso può essere compresa la provocazione ancora una volta di Bruno Latour quando afferma che «agli Occidentali e a coloro che li hanno imitati, la “natura” ha reso il mondo inabitabile»[38]; con Jason W. Moore si potrebbe aggiungere che la sempre più accresciuta inabitabilità del mondo è stata scandita prima dall’affermazione di una rappresentazione della “natura a buon mercato”, durata ben quattro secoli, e poi dalla percezione di una sua irrimediabile fine (la crisi economica ed ecologica allo stesso tempo, perché appunto sono la stessa crisi): per “natura a buon mercato” deve intendersi l’insieme di quattro fattori, la forza-lavoro, il cibo, l’energia e le materie prime, in poche parole l’insieme dell’attitudine estrattivista del modo di produzione capitalistico nei confronti delle nature umane e nonumane, “nature” che devono essere necessariamente “economiche” per permettere la costruzione del profitto – la “natura” oggettivata funziona nel capitalismo sia come operatore interno all’umano (l’estrazione del lavoro vivo dalla forza lavoro, la gestione del capitale umano e della riproduzione dal punto di vista biogenetico, l’egoismo “per natura” e così via) sia come operatore esterno all’umano (l’estrazione di cibo, energia e materie prime per permettere il ciclo della produzione). Il capitalismo, nella sua connessione con la specifica razionalità riflessiva del moderno, rappresenta un modo di organizzare non solo la società ma anche la natura (del resto, è proprio questa ideologica scissione a dover essere superata), e questa forma di “organizzazione/costruzione” allo stesso tempo epistemologica e politica non può che determinarsi, dal punto di vista di una genealogia delle relazioni politiche ed economiche, a partire dalla forma del “lavoro non retribuito” conseguente al rovesciamento del rapporto tra terra e lavoro nella costruzione della dinamica del “valore”: la natura, che è sempre stata “costosa” e i cui prodotti erano sempre stati interessati da “rarità”, diviene a buon mercato nel momento in cui si determina l’appropriazione del lavoro non retribuito. Se è vero che «il reale dinamismo della produzione capitalistica è impensabile in assenza di appropriazioni delle frontiere che consentono a crescenti quantità di materiali di fluire attraverso una data unità di tempo di lavoro astratto», per cui il valore ha un carattere di autoespansione nel momento in cui promuove la crescita della quantità di produzione senza contemporaneamente accrescere la quantità di lavoro astratto incorporato, allora «la riduzione incessante del tempo-di-lavoro può verificarsi, tuttavia, solo nella misura in cui energia a buon mercato, cibo a buon mercato, materie prime a buon mercato, e, sì, lavoro a buon mercato possono essere assicurati mediante strategie di appropriazione esterne all’immediato circuito del capitale»[39].
La rappresentazione della “natura”, quando ragioniamo in termini di “organizzazione/costruzione” da parte del modo di produzione capitalistico, è fondamentalmente “astratta”, così come l’immaginario connesso alla “società”, anch’essa resa decisamente “astratta”: in questo senso il capitalismo si fonda su queste violente astrazioni ed emerge e può affermarsi soltanto a partire da una pratica di costruzione del “rapporto al mondo” mediante la determinazione di una “natura” come oggetto esterno e come elemento speculare di una “società” che rappresenta il soggetto appropriatore in quanto eccezione. Se si continua a concepire la “natura” a partire dalle funzioni di cui abbiamo discusso e come luogo di appropriazione e riproduzione – anche se mitigata in chiave green – non si fa un passo in avanti nei confronti del mutamento e della crisi economica ed ecologica che stiamo vivendo, occorre allora approcciarsi alla “natura” come «storica e immanente a qualsiasi cosa facciano gli esseri umani nel lungo periodo e su vasta scala […] per cui il cambiamento storico è un movimento congiunto di esseri umani e di nature extraumane»[40].
La crisi ecologica, la crisi del capitale e la crisi simbolica dell’immagine della natura rappresentano dunque la medesima crisi: in questo senso, riteniamo che ci troviamo dinanzi a una soglia determinante, un mutamento nel senso latouriano di cui sopra. Il problema diviene, dunque, allo stesso tempo la costruzione dell’immaginario di un rapporto al mondo che si liberi della nozione di “natura” così intesa nel moderno come movimento complessivo che rimetta in discussione i rapporti tra produzione e riproduzione tipici del capitalismo neoliberista avanzato[41]. Per salvare il mondo dalla sua fine, occorre accelerare la fine della natura.
- Tesi n. 2. La fine della natura può avere l’effetto di accelerare la decomposizione del “rapporto al mondo” come sistema complesso relazionale di differenti potenzialità d’azione – questo effetto è da evitare
«È curioso notare» ricordano giustamente Viveiros de Castro e Danowski «che rispetto alle tre grandi idee trascendentali di Kant, ovvero Dio, Anima e Mondo […] è come se stessimo assistendo al crollo dell’ultima idea […] ultimo e vacillante bastione della metafisica»[42]: il “rapporto al mondo” così come lo abbiamo imparato a conoscere in chiave kantiana si starebbe decomponendo (nell’immaginario e nella concretezza della crisi ecologica) e quindi occorrerebbe iniziare un lavoro di composizione di mondi, un lavoro su un nuovo immaginario, immaginare una nuova e rinnovata cosmopolitica[43]. Ma precisamente cos’è che va in crisi? Cos’è che si sta avviando verso la decomposizione? Si potrebbe rispondere in via preliminare, e partendo dagli assunti della Tesi n. 1, che ad andare in crisi e a decomporsi sia l’immagine del “mondo” che ci ha consegnato la rivoluzione scientifica a partire dal XVII secolo. Ad essere immediatamente compromessa sarebbe non solo l’immagine della “natura” ma anche quella di “mondo” nella sua duplicità esperienziale di oggetto dello “sguardo” conoscitivo e tassonomico umano e di scenario/sfondo per la messa alla prova dell’esperienza della vita umana. Sembra, insomma, che il “mondo” non sia più completamente a nostra disposizione, sia nel senso di un “oggetto” da manipolare e di cui servirsi, sia come lo sfondo della nostra avventura esistenziale: in poche parole, è proprio l’epoca dell’Antropocene (che, come abbiamo visto, sembra poter raccontare l’immane potenza umana in seno al mondo, addirittura come forza geologica, dunque come baluardo inespugnabile dell’eccezionalismo umano) a mostrare come l’antropocentrismo sia la vera malattia mortale dell’uomo e come il mondo sia diventato sempre più chatouilleux[44].
Sembra dunque che il “mondo” sia destinato alla decomposizione (che, “fuor di filosofia”, significa la possibilità della “fine del mondo” senza Regno a venire per l’uomo), finché a decomporsi non sarà l’immaginario della centralità umana nel mondo. Con la fine della natura, occorre accelerare la fine dell’uomo. Per progredire e accelerare in questo senso, bisogna comprendere quale idea di “uomo” deve essere condotta alla sua fine: la risposta è a prima vista semplice, l’uomo della modernità, quell’uomo sorto inizialmente in una specifica area del pianeta, che ha come caratteristica la razionalità riflessiva e l’organizzazione produttiva di tipo capitalistico, che è fondamentalmente Bianco Civilizzato Eterosessuale, quello che ha condotto alla spaccatura (e dunque alla ri-creazione) di natura e uomo come poli opposti, e soprattutto il soggetto che ha la pretesa che qualunque cosa produca, dalle idee alle politiche, passando per le etiche e le teorie, sia “universale”, di un’universalità non negoziabile, ma soltanto da imporsi agli altri.
Questa tipologia di “uomo” ha creato nella modernità (per poi imporlo universalmente) un modo molto particolare di leggere il “rapporto al mondo”, quello che, utilizzando un termine oramai piuttosto alla moda, possiamo chiamare correlazionismo: esso sembra rappresentare sempre più una sorta di patologia terminale, un delirio narcisistico per cui tutto ciò-che-è è in funzione dell’uomo, della sua gestione, della sua creazione, della sua potenza di distruzione, per certi versi quasi la forma razionale che assume sulla superficie dei saperi una sorta di pulsione di morte inconsapevole che accompagnerebbe l’uomo della modernità a volere tutto e subito, anche la “fine”, a volerla tutta e subito. A lanciare un tanto vigoroso quanto problematico atto d’accusa al correlazionismo – con cui occorre intendere, in via preliminare, la visione del “mondo” come un oggetto correlato a un soggetto “legislatore della natura” – è il giovane, e molto in voga, filosofo francese Quentin Meillassoux, il cui “esordio” filosofico, Dopo la finitudine, rappresenta un tentativo concreto di superamento del correlazionismo che avrebbe un’iniziale matrice kantiana[45]. In realtà, il correlazionismo, inteso soprattutto in chiave epistemologica come “costruzionismo”, è il punto di attacco anche delle critiche di Bruno Latour[46], Isabelle Stengers[47] e Donna Haraway[48], con cui occorrerà confrontarsi per l’elaborazione di alcune immagini fondamentali, sorta di fantasmi di un “mondo” finalmente liberato dalla morsa stringente del correlazionismo e del costruzionismo: compariranno sulla scena (e non più come sfondo) il mortuum[49] di Meillassoux, la Gaia di Latour/Stengers[50], il bizzarro e tentacolare Chthulu di Donna Haraway[51].
Ma cosa dobbiamo intendere per correlazionismo? E quanti correlazionismi devono essere affrontati e sconfitti? Meillassoux risponde che questo protocollo onto-epistemologico si fonda sul «presupposto più o meno esplicito che non vi siano oggetti, eventi, leggi o enti che non siano già sempre correlati con un punto di vista, con una modalità di accesso soggettiva»[52] e che questa “deriva” filosofica muove sicuramente dalla seppur moderata filosofia trascendentale di matrice kantiana, ma ha proseguito il suo cammino fino alle varie fenomenologie e al postmoderno, seppure in modalità e con tonalità differenti: il “correlazionismo”, muovendo sempre dall’idea di un accesso soggettivo a una realtà oggettiva (tu che parli di questo e di quello, da quale posizione ne parli?), nega la possibilità di giungere alla conoscenza della cosa in sé (come “cosa separata”, un “assoluto” nel senso etimologico del termine) in quanto non sembra essere più possibile la distinzione tra le proprietà di un oggetto e quelle che appartengono alla modalità particolare di accesso soggettivo dell’uomo (la vecchia questione delle qualità primarie e delle qualità secondarie, ormai “mescolate” nel postmoderno) – delimitare dove finiscono le proprietà “autonome” di un oggetto e dove iniziano le categorie organizzatrici e/o interpretative di un soggetto sembra essere il problema fondamentale del “correlazionismo”, per cui se è vero che è l’uomo a essere il “legislatore della natura”, nella forma correlazionista kantiana, è anche vero che il correlazionismo di matrice postmoderna può affermare che nulla esiste (il tanto mal compreso aforisma nietzschiano “non esistono fatti, solo interpretazioni”) ed è tutto un gioco politico, di rapporti di forza: non esiste la verità assoluta, ma esiste soltanto la verità del più forte, di colui che (forza storica, politica, sociale) riesce a imporre la propria interpretazione come un fatto oggettivo; se è sempre utile effettuare una critica politica dei saperi e dell’oggettività dei saperi, in quanto saperi situati[53], occorre comunque cercare nuove forme di sapere intersoggettivo che vadano al di là delle contrapposizioni tra universalismo e differenzialismo: se è vero che l’universale non esiste, non è neanche vero che tutte le interpretazioni debbano essere considerate uguali e che a decidere debba essere soltanto la forza.
Il ragionamento di Meillassoux (considerato uno dei padri fondatori del “realismo – o materialismo – speculativo”[54] con cui si confronta anche il filosofo italiano Maurizio Ferraris[55]) non punta tanto a scardinare le pretese di post-verità del postmoderno più spinto, né ad affrontare la questione immediatamente sul versante etico-politico, quanto ritagliare un rinnovato spazio a una filosofia teoretica, capace nuovamente di confrontarsi con un qualcosa – il “mondo” – che non sia un correlato del pensiero umano, che esista non solo al di là del nostro modo di vederlo, ma che abbia un regime di esistenza che è già-sempre indipendente a qualunque forma di sguardo o azione che cerchi di determinarlo: insomma, la definizione della realtà di un altro del pensiero, una nuova filosofia dell’assoluto, come viene definita dallo stesso filosofo francese. In poche parole, si tratta di un’immagine del “mondo” che si è finalmente liberato di noi (questo il mood antropocenico che è possibile cogliere anche in un’opera che non tratta direttamente queste questioni).
Se Meillassoux ha ragione fino alla banalità, quando propone il “problema dell’arcifossile”, il nodo complessivo della sua riflessione si ha tutto in quello che definisce come “principio di fattualità”. La riflessione, molto articolata, contratta e complessa attraversa fondamentalmente due passaggi:
1) il problema fondamentale del correlazionismo è che non è in grado di ammettere nella sua visione asserzioni ancestrali che abbiano per oggetto l’arcifossile: gli isotopi radioattivi che permettono di determinare l’età di una roccia o la luminescenza delle stelle che permette di determinarne l’età (“arcifossili” nel linguaggio del filosofo francese) portano alla possibilità di costruzioni di asserzioni su cose e/o eventi che precedono la comparsa dell’uomo (e, dunque, del suo pensiero) sulla terra – per il correlazionismo il pensiero di un “oggetto” è sempre il pensiero sulle forme di correlazione esperienziale tra un soggetto e un oggetto, ma se l’oggetto precede il pensiero, come possono essere accettate alcune asserzioni della scienza moderna? «Per un correlazionista l’ancestralità non può essere una realtà che precede i soggetti, ma soltanto una realtà detta e pensata dal soggetto come precedente al soggetto»[56] dice Meillassoux, sottolineando come un correlazionista davvero conseguente non dovrebbe mai accettare questa tipologia di asserzioni, ma come allo stesso tempo sia proprio la presenza di questa tipologia di asserzioni a mostrare come la correlazione sia un protocollo da superare senza se e senza ma – dunque, il progetto paradossale sarebbe il seguente: bisogna usare il pensiero per scremare il mondo dalla presenza ingombrante del pensiero[57];
2) per poter accedere alla “cosa in sé” di matrice kantiana, al “mondo” come qualcosa che non si determini nella correlazione con un soggetto, a un “mondo senza soggetto”, all’essere senza pensiero, occorre introdurre il “principio di fattualità”: esso annuncia la tesi della necessità della contingenza a partire dalla rivendicazione dell’esistenza di un altro del pensiero, di qualcosa che non possa essere ricondotto alla correlazione tra pensiero ed essere, dunque l’esistenza assolutizzata di un assoluto («il principio di fattualità non consiste nel sostenere che la contingenza è necessaria, ma esige di pensare che solo la contingenza è necessaria»[58]); esistono essenzialmente due forme di assoluto, secondo il filosofo francese, quella “realista” per cui esiste una realtà non pensante al di là del nostro accesso pensante ad essa (anche se inconoscibile – in questo senso Kant sarebbe l’ultimo dei “realisti” oltre a essere il primo degli “idealisti”), quella “idealista” per cui l’assoluto è l’assolutizzazione della correlazione (Meillassoux guarda a Hegel, ma anche alle varie forme di panpsichismo e vitalismo); se Kant, allora, ammette ancora l’esistenza di una cosa in sé, Hegel, riconducendo l’essere alla relazione tra pensiero ed essere, negherebbe l’esistenza di questo altro del pensiero: il correlazionismo, dunque, ha due strumenti, uno contro il “realismo” asserendo che ogni proposizione contro il correlazionismo e a favore del realismo è sempre un’asserzione che nasce in un contesto, a partire da un pensiero che è il prodotto di un’epoca o di una cultura, ed è dunque già “correlata” (“l’argomento del circolo”[59]), e uno contro l’“idealismo” mediante l’imposizione del “principio di fatticità”, cioè l’impossibilità della determinazione di un principio di ragione sufficiente come fondamento per l’esistenza di tutto ciò che è; il “principio di fattualità” di Meillassoux interviene a questo punto: l’unica possibile confutazione delle due forme di correlazionismo non può che avvenire mediante un’assolutizzazione del principio di fatticità, asserendo la necessità della contingenza, andando dunque con Hume oltre Kant – la necessità della contingenza è l’unica speranza per il pensiero di andare oltre il pensiero e incontrare infine il “mondo”.
Ma il rifiuto del correlazionismo e contemporaneamente l’affermazione di una necessità della contingenza (il “principio di fattualità” come assolutizzazione del “principio di fatticità” utilizzato dal correlazionismo contro l’idealismo e il vitalismo) pongono alcuni problemi di notevole complessità quando si tratta di analizzare la questione del “mondo” e della sua possibile disgregazione.
Innanzitutto, se è vero che il mondo, per Meillassoux, è indipendente dal pensiero e la sua indipendenza è data dalla necessità di pensarne la contingenza come assoluta e scevra da ogni posizione di pensiero o di azione, se dunque il “mondo” acquisisce una consistenza “nuova”, è anche vero che questo “mondo” oltre la correlazione sembra essere un mondo morto, non vitale: per tornare al “mondo”, occorre effettuare un lavoro di de-realizzazione da ogni forma di pensiero, sensazione, emozione, azione su di esso – il “mondo” per esistere non deve contenere punti di vista né essere contaminato da potenze di agire (agency) viventi ed extraviventi, deve essere un “mondo morto”.
Procedendo, poi, si nota un problema di carattere epistemologico: come si concilia la necessità della contingenza con la produzione del discorso scientifico? Per Meillassoux «le leggi sono solo dei fatti e non è possibile dimostrarne la necessità»[60] e se questo punto, secondo il filosofo, è stato dimostrato ampiamente da Hume (il quale, va sottolineato, partiva da una forma specifica di correlazione tra pensiero ed essere mediato dalle impressioni), il modo per andare oltre Hume è quello di ritenere che la non accessibilità a leggi necessarie non derivi dai limiti della ragione umana, bensì dal fatto che il “mondo” è dominato dalla necessità della contingenza per cui le leggi, che non sono necessarie, rappresentano soltanto dei fatti e «i fatti sono contingenti, ovvero possono cambiare senza ragione»[61]. Il filosofo si rende conto che questo è uno dei passaggi più complessi della sua riflessione ed è su questa complessità che asserisce di volersi fermare per il momento: in discussione non è soltanto la fisica classica newtoniana, ma la stessa possibilità di un’attività scientifica. Il più che giusto problema sollevato da Meillassoux – la necessità del superamento di una scienza che ritiene che le leggi siano necessarie e che l’impossibilità di una prevedibilità assoluta sia soltanto una questione tutt’al più di limiti umani – deve essere declinato altrimenti, nei termini di una pensabilità allo stesso tempo di un “mondo” che si fondi su una non-prevedibilità (superare il dispositivo Laplace), ma allo stesso tempo un “mondo” che non sia in balia di un’assenza di qualunque sistematicità (superare il dispositivo Meillassoux), che sia imprevedibile nella misura in cui è comunque vincolato da determinate possibilità – ed è quello che fa la scienza dei sistemi complessi: «c’è una ragione ontologica […] per cui alcuni fatti possono verificarsi piuttosto che altri, ma non c’è nessuna ragione per pensare che qualcosa debba assolutamente verificarsi, né di sostenere che qualunque cosa possa accadere in ogni istante»[62].
Possiamo dedurre dunque una prima formulazione positiva sul “mondo”: il “mondo” è il reale contingente, ma non in maniera necessaria – la necessità è il mortuum –, la cui contingenza ha a che vedere con la variabilità di sistemi che hanno una potenzialità di agire (agency) a partire da specifiche caratteristiche ontologiche. Il mondo di Meillassoux è un mondo morto, proprio perché non ha alcun orientamento all’azione, non influenzato né influenzabile da alcuna potenzialità di agire o di pensare. L’ipotesi di Meillassoux assume tonalità nichiliste e il compito etico-politico che presenta l’Antropocene non può e non deve muovere dal nichilismo.
Ed è proprio sul versante etico-politico che l’opzione Meillassoux sembra perdere ogni possibile efficacia: se il suo testo principale, Dopo la finitudine, ha l’andamento di un saggio di filosofia teoretica che programmaticamente si tiene lontano da ogni questione di carattere etico-politico, è possibile comunque affermare, a partire invece dall’Inesistenza divina, tesi di dottorato mai pubblicata per intero (e dalla quale è stato tratto proprio il saggio Dopo la finitudine), che la sua filosofia complessiva ha invece un forte connotato etico-politico, che, come è stato notato, avrebbe al centro una critica ai fanatismi dell’azione propri del XX secolo in vista di una nuova visione etica di carattere speculativo[63]. Del resto, è la sua stessa impostazione filosofica a porre la questione in questi termini, per cui possiamo trovare due premesse e una conclusione: il mondo funziona nei termini di una necessità della contingenza (prima premessa), la necessità della contingenza implica che non esista agency che possa influenzarlo (seconda premessa), un nuovo “mondo” può sorgere sicuramente – la contingenza – ma indipendentemente dall’azione umana ed extraumana (conclusione). Semplificando al massimo, il principio di fattualità e la necessità della contingenza distruggono ogni prospettiva teleologica: nessun progetto è pensabile né tantomeno realizzabile. Ha ragione dunque Coombs quando afferma che «questa è una battaglia per restituire alla filosofia speculativa il suo ruolo guida e dirigere il malcontento verso l'introspezione etica individuale, rimuovendo la ricerca della giustizia dal regno della contestazione politica» per cui «è coerente, nella migliore delle ipotesi, con una mite politica riformista […] Nel peggiore dei casi, è coerente con una forma di autoritarismo idealista che emette direttive arbitrarie dall'alto», si arriva dunque al paradosso per cui il materialismo speculativo «ci porta molto lontano da qualsiasi politica che potrebbe legittimamente essere definita materialismo»[64].
Ma l’epoca della crisi economica ed ecologica implica un impegno di carattere differente, un vero ripensamento del “rapporto al mondo” che non disgreghi la nostra (e non solo) presenza e riattivi da un lato la necessità del conflitto e dall’altro la possibilità del cambiamento radicale.
- Tesi n. 3. Il “mondo” e il “rapporto al mondo” (umano e vivente) devono essere ripensati nei termini di una relazionalità profonda non più binaria né soltanto intra-specifica, al di là della dicotomia tra “parti discrete” e “Tutto indiscreto”, come un rapporto vivente e non gerarchico – resta il problema del che fare?
Se il progetto complessivo della filosofia di Meillassoux sembra andare verso il superamento della logica binaria costruzionista ma in vista di una assolutizzazione anti-vitale del mondo (anti-vitalismo che si traduce, in termini politici, in una sorta di ripiegamento individuale, essendo l’intervento de jure e de facto irrilevante), sembra necessario muoversi in un’altra direzione per comprendere come affrontare la crisi simbolica, economica ed ecologica che giorno dopo giorno diviene sempre più pervasiva: ripensare il “rapporto al mondo” come rapporto vivente e non gerarchico, come impegno in una vita activa e non come introspezione in una vita contemplativa. La critica al costruzionismo della logica binaria occidentale non è certo una novità, era stata già proposta da tempo e soprattutto sul versante del pensiero femminista: Donna Haraway, già negli anni ‘80 del secolo scorso e in maniera “visionaria”, aveva raccontato il mito del cyborg proprio come metafora fondamentale del superamento del binarismo che attraversa il campo dei saperi della modernità – binarismo che non pone soltanto una questione di organizzazione dei saperi (problema epistemologico), ma anche e soprattutto una questione di organizzazione del campo di forza politico. Una delle conquiste fondamentali del clima culturale del postmoderno (e dei post in generale) è che l’epistemologia non è mai neutra, ma ha sempre una posizione all’interno di un campo di forze – i regimi discorsivi di un’epoca sono appunto dei “regimi”, dei risultati di una “lotta” nei processi di veridizione; l’epistemologia in questo senso è sempre una polemologia, la rappresentazione del risultato di un conflitto, con tanto di vincitori e di vinti. «Nella tradizione occidentale» sostiene la filosofa americana «sono esistiti persistenti dualismi e sono stati tutti funzionali alle logiche e alle pratiche del dominio sulle donne, la gente di colore, la natura, i lavoratori, gli animali»[65]: il dualismo Natura/Cultura, da cui fondamentalmente discenderebbero ideologicamente tutti gli altri, propone un modello interpretativo complesso per cui da un lato esso rappresenta il paradigma fondamentale della gerarchizzazione antropocentrica – che si posiziona su più livelli di complessità discendenti: l’Uomo superiore alla Natura (antropocentrismo), all’interno dell’Uomo: l’Uomo superiore alla Donna (fallocentrismo), l’Uomo Bianco superiore all’Uomo Altro (occidentalismo), l’Uomo Civilizzato superiore all’Uomo Primitivo (evoluzionismo) e così via –, dall’altro la rappresentazione epistemologica di una falsa alternativa tra universalismo e differenzialismo, la quale rischierebbe di porre il pensiero (e l’azione, ovviamente) dinanzi al bivio, se continuare a pretendere un universalismo, che poi rischia sempre di essere di matrice fallocentrica, occidentale e imperialista, o un relativismo decostruzionista e postmoderno che rischia di non poter essere più propositivo, in quanto si pone come un vero e proprio «elettroshock epistemologico»[66] incapace di condurre il pensiero verso nuove forme di oggettività situata. La teoria cyborg – questo “ibrido” di dimensione naturale e intervento tecnico – non nega il fatto che i corpi siano i luoghi di inscrizione del potere (come vuole giustamente il pensiero decostruzionista e postmoderno), ma la costruzione dell’identità avviene attraverso un percorso che va sì al di là dei dualismi ma soprattutto in vista dei saperi situati, che rappresentano un superamento allo stesso tempo dell’universalismo e del differenzialismo, nella direzione di «conoscenze, quelle parziali, localizzabili, critiche, che sostengono la possibilità di reti di relazioni chiamate in politica solidarietà e in epistemologia discorsi condivisi»[67]. Solidarietà e discorsi condivisi, dunque, per una nuova epistemologia che vada al di là della dicotomia tra universalismo e differenzialismo ma anche oltre la costruzione del campo del sapere mediante scissioni gerarchizzanti: se è sicuramente postmoderna l’idea che i saperi vanno costruiti anche politicamente (la solidarietà), è indubbiamente “ecologica” la posizione di superamento delle scissioni mediante costruzioni di ibridazione tra saperi e pratiche. Anche in questo senso, l’ecologia è sempre politica.
E allora il “mondo”, non essendo più semplice «materia prima per l’umanizzazione»[68], oggetto inerte per l’unica vera e propria attività vivente e trasformatrice, l’attività umana, diviene qualcosa che «resiste a essere ridotto a risorsa perché è non madre/materia/balbettio preverbale ma coyote, una figura del legame sempre problematico e potente tra significato e corpi», il mondo deve essere letto «come trickster codificatore con cui dobbiamo imparare a conversare»[69]. Il nodo decisivo, allora, è l’ambiguità di fondo che sussiste tra ciò che è definito come processo di costruzione di un oggetto di conoscenza e quella che viene proposta come fedeltà a un mondo reale: se per Meillassoux il “mondo reale” è un mondo disincarnato e indipendente da ogni prospettiva umana e in generale vivente, al di là di ogni potenza di azione (agency) umana ed extraumana, per Donna Haraway, per superare davvero la dicotomia soggetto-oggetto, costruzione-realtà, occorre immaginare l’oggetto come capace di agire, portatore di una vera e propria agency nella produzione della conoscenza. Il “mondo” diviene ciò che è capace di azione nel processo conoscitivo, e in questo senso occorre sempre mediare e negoziare le costruzioni concettuali umane con le realtà contingenti del mondo (la contingenza, come abbiamo visto, in quanto azione regolata da vincoli e possibilità): siamo davvero agli antipodi di Meillassoux, il “mondo” è attraversato costantemente e formato plasticamente da potenzialità di azioni, da flussi temporali e viventi di durata e vita, il “mondo” è un agente vitale e davvero contingente, nella misura in cui non solo presenta un certo grado di imprevedibilità, ma anche e soprattutto in quanto questa imprevedibilità nasce da negoziazioni costanti tra gli agenti oltre il troppo semplicistico rapporto tra caso e necessità[70]. In questo senso ha ragione anche Timothy Morton, pensatore dal mood profondamente antropocenico ed ecologico, quando parla della necessità di pensare, oltre la distinzione soggetto-oggetto, a partire da ciò che definisce iperoggetti, cioè fenomeni talmente vasti e intrecciati nello spazio-tempo (come il surriscaldamento globale, ad esempio) da mettere in discussione tutte le categorie classiche che hanno definito l’abitare dell’uomo nel mondo: non solo il sospetto riguardante la strutturazione epistemologica fondata sulla relazione soggetto-oggetto e le rappresentazioni lineari del tempo e dello spazio, ma anche e soprattutto il sospetto (se si vuole, tutto moderno/postmoderno) per il discorso sul “soggetto”, talmente radicale da fare sì che la soggettività venga interpretata soltanto come un caso particolare (ma uno dei tanti) di interoggettività[71].
Se per Isabelle Stengers, come abbiamo visto, il mondo è chatouilleux, per Donna Haraway, come abbiamo appena visto, può essere descritto mediante la figura della mitologia amerindiana del trickster, al tempo stesso come un procuratore di disastri e come un istitutore fondamentale di beni d’importanza vitale: il “mondo” ha una certa carica di imprevedibilità, si nasconde, è un “imbroglione”, il “mondo” è – volendo usare un lessico filosofico – contingente. Il problema del “mondo”, dunque, non è se abbia o meno un’anima, non riguarda il fatto di poter essere definito come un “soggetto” – questione ancora troppo antropocentrica –, ma come immaginare la potenzialità di agire (agency) al di là dello schema teologico-metafisico, proprio dell’Occidente, dell’anima individuale.
Il mondo è un agente vitale, dunque, ed è ciò che Bruno Latour si sforza di chiamare Gaia, seguendo e prendendo sul serio la cosiddetta “ipotesi Gaia” di James Lovelock[72]. Il ragionamento latouriano è come sempre profondamente provocatorio: innanzitutto, si tratta di opporre in maniera decisa il “mondo” della scienza della prima modernità, fondamentalmente galileiano, alla Gaia di Lovelock, nella misura in cui l’idea di un “mondo” come un tutto agente e vitale renderebbe nuovamente unica la Terra, costituirebbe nuovamente una sorta di mondo “sublunare”, una differenza (comunque la si voglia intendere) di natura rispetto al resto del cosmo. Se il “mondo” di Galileo era divenuto un pezzo di roccia vagante nell’universo, e che risponde alle medesime leggi che muovono tutti gli altri pezzi di roccia vaganti nell’universo, dunque ponendo fine alla differenza qualitativa di origine aristotelica tra il mondo abitato dall’uomo e gli altri pianeti e cieli, l’ipotesi Gaia, che secondo Latour va presa decisamente sul serio, segna l’inizio di una nuova epoca, in cui il “mondo”, la Terra rappresentano nuovamente un sistema a sé stante nell’universo. Quella che Ingold chiama “cosmologia meccanico-teorica” propria della modernità occidentale[73], un’epistemologia che è già-sempre una cosmologia che è già-sempre una cosmopolitica, potrebbe essere definita nei termini latouriani come una “cosmologia galileiana”, mediante la quale si è effettuata «una strana operazione che ha permesso di dis-animare una sezione del mondo, dichiarata oggettiva e inerte, e di sur-animare un’altra sezione, dichiarata soggettiva, cosciente e libera»[74].
Se ha ragione Latour quando invita a pensare il “mondo” come Gaia al di là delle metafore tutte occidentali e moderne connesse alla rivoluzione scientifica e al suo immaginario, occorre analizzare le cosmologie connesse di meccanismo e organismo (esigenze e atteggiamenti, come avrebbe detto Canguilhem[75]) e aggiungere che entrambe queste “metaforiche” decisive, che per secoli si sono contese il “possesso” epistemologico del mondo e della “vita” (e che hanno dato avvio a cosmopolitiche tipicamente occidentali e moderne), hanno in definitiva una base comune: una visione meccanicista della realtà e della vita resta sempre irrisolta perché resta irrisolta la questione fondamentale del “costruttore” della macchina (dunque: il meccanicismo necessita sempre di una trascendenza, di un principio trascendente, di un Dio come orologiaio ad esempio), mentre una visione vitalista o organicista della realtà e della vita resta sempre irrisolta perché resta irrisolta la questione fondamentale della “coordinazione” (a tratti “magica”) tra le parti (dunque: il vitalismo o organicismo necessita sempre, nelle sue forme più raffinate, di un’immanenza, di un principio immanente di coordinazione, qualcosa che si aggiunga alle parti per farne un Tutto aggregato e indiscreto). Meccanicismo e vitalismo sono fondamentalmente speculari, nella misura in cui sono strutturati entrambi a partire dal medesimo ragionamento: il “mondo”, comunque lo si voglia intendere, è formato da “parti” discrete e separate (prima premessa), le parti discrete e separate presentano un certo schema di coordinazione in un “mondo” come “Tutto” (seconda premessa), lo schema di coordinazione che è il “mondo” è guidato da un principio divino e trascendente, il “costruttore”, o da un principio (altrettanto) divino ma immanente, la “vita” come di volta in volta principio o forza (conclusione). Il ragionamento, allora, si basa sull’idea che il “mondo” consista di parti discrete ma allo stesso tempo sia un Tutto: in questo senso, anche l’ipotesi olistica è fallace, perché muove dal medesimo presupposto, per cui il principio di coordinazione risulta essere sempre e comunque di natura latamente teologica. Se l’ipotesi Gaia, nelle versioni di volta in volta di Lovelock, Latour o Stengers, può avere una sua importanza, sta nel fatto che deve invitare a pensare oltre le metaforiche di macchina e organismo, dunque al di là di un immaginario formato da “parti discrete” e “Tutto indiscreto”. Al di là della cosmologia propria della modernità occidentale. Immaginare o raccontare il “mondo” come un agente vitale può e deve essere sì un compito per il pensiero, ma rischia allo stesso tempo di presentarsi come un pericolo: il problema è che ci si trova dinanzi a una carenza di linguaggio adeguato per la descrizione di ciò che si intende dire. Quando si afferma che il “mondo” è un agente vitale, il rischio connesso al linguaggio stesso è che lo si immagini (e del resto anche in Lovelock è fondamentalmente così) come un organismo unitario: se ci si fermasse a questo, non si farebbero grandi passi in avanti, ma si rischierebbe davvero di piombare in una visione new age, per cui si dovrebbe nuovamente trovare quello che abbiamo definito “principio di coordinazione”, la “ragion sufficiente” (trascendente o immanente, è secondario) di questa “organizzazione”.
Donna Haraway, con la sua proposta di definire la nostra “epoca” come Chthulucene, cerca di delineare i contorni di una nuova cosmologia per l’età che è caratterizzata dal trouble, parola che si traduce comunemente con “problema” e che indica, per la filosofa, il «vivere sulla Terra in tempi confusi, torbidi e inquieti»[76]. Al di là di ogni principio di ragion sufficiente, non è più tempo né di meccanicismo né di vitalismo, ma neanche dell’ipotesi cyborg come superamento delle dicotomie in un’ulteriorità che abbia al centro la potenza liberatrice della tecnologia: i tempi sono irrimediabilmente cambiati e adesso si tratta di “sopravvivere su un pianeta infetto” (come recita il sottotitolo della traduzione italiana del libro in questione). Nell’immaginario che la filosofa americana cerca di costruire, lo staying with trouble, tradotto con “restare a contatto con il problema”, implica il vivere completamente nel presente, senza leggerlo come una strana articolazione di un passato, che di volta in volta si interpreta come idilliaco o come terribile, e di un futuro, che di volta in volta si interpreta come possibilità di salvezza o Apocalisse: «bisogna essere presenti nel mondo in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni aperte fatte di luoghi, epoche, questioni e significati»[77]. L’armamentario immaginifico della proposta di Haraway insiste su una serie di configurazioni che descrivono cos’è il “mondo” e come si dovrebbe strutturare il nostro “rapporto al mondo”. Il “mondo” non esiste, non deve esistere nella misura in cui, nello stesso pronunciare la parola, si starebbe indicando una sorta di sostanza a sé stante separata dai flussi tentacolari e simpoietici di co-produzione e co-evoluzione tra viventi umani, viventi nonumani e ambiente; esiste invece il wordling, tradotto come “mondeggiare” (ma l’assonanza heideggeriana è puramente di superficie), con il quale si intende il farsi comune del mondo nell’intreccio complesso di differenti potenzialità d’azione (agency). Si tratta di decomporre in un certo modo il “mondo”, l’idea di “mondo”, e del resto una delle immagini predilette del libro, il “compost”, è essa stessa rappresentazione di “decomposizione” e “ricomposizione” intrecciata in qualcosa che da scarto diviene ciò-che-nutre: esso è la rappresentazione definitiva della necessità di andare oltre il postumano, nella misura in cui al centro – o nel decentramento – non c’è più l’umanità, ma l’humosità, il decomporsi costante e intrecciato delle realtà nel mondeggiare. Anche in questo caso, a nostro avviso, è possibile parlare di materialismo (nuova e rinnovata esigenza nell’età dell’Antropocene, dopo l’eccesso costruzionista e decostruzionista del moderno/postmoderno), ma di un materialismo che non ha come fonte e punto di arrivo il soggetto umano, ma neanche la profonda e inquietante estraneità nichilista di Quentin Meillassoux: il mondeggiare significa la costante co-produzione di mondi da parte di differenti entità, per cui il mondeggiare ha come suo correlato il mattering (sempre nella forma sostantivante che indica una potenza di agire data dal suffisso -ing), il divenire-materia come dimensione connettiva e affettiva, vivente e creativa.
In questo senso (e profondamente contro Meillassoux), il “mondo” è già-sempre “rapporto con il mondo” e, per descriverlo nei termini di Donna Haraway, è necessario introdurre una certa terminologia, ripresa soprattutto dagli studi della biologa radicale Lynn Margulis[78]. La filosofa americana opera una vera e propria torsione a partire da questa concettualizzazione biologica, portandola alle estreme conseguenze. Si può iniziare, innanzitutto, con il termine simpoiesi: il “mondo” non è un sistema autopoietico, ma un complesso sistema di sistemi simpoietici, il mondeggiare è sempre un mondeggiare-con, nella misura in cui i viventi sono già sempre compenetrati tra di loro, «si mangiano, fanno indigestione, si digeriscono in parte e in parte si assimilano a vicenda, e così definiscono degli ordini simpoietici altrimenti noti come cellule, organismi e assemblaggi ecologici»[79]. Un altro termine fondamentale è olobionte: sempre sulla scorta degli studi biologici di Lynn Margulis, deve intendersi l’elemento centrale che costituisce il mondeggiare, il fatto fondamentale che la relazione precede la sostanza, anzi, al limite, che esiste soltanto la relazione mentre le “sostanze” sarebbero soltanto effetti precari e già-sempre decomponentisi in altre e continue relazioni; al centro dell’olobionte c’è la simbiosi, non nel senso comune che muove dall’idea dell’esistenza di due sostanze individuali e indipendenti che si uniscono per un vantaggio reciproco (immaginario quanto mai utilitarista e fiaccamente moderno), ma come «assemblaggi simbiotici, su qualsiasi scala spaziale o temporale, che assomigliano più a nodi di relazioni intra-attive diversificate […] che a entità di una biologia composta da unità preesistenti»[80]. Il mondeggiare simbiotico non è da intendersi con l’immaginario del “mutuo beneficio”, va inteso in senso ontologico e non meramente utilitaristico e individualistico. L’elemento decisivo è dunque la simbiogenesi: secondo la teoria biologica radicale di Lynn Margulis, l’evoluzione naturale non è mossa dalla mutazione individuale, la quale giocherebbe soltanto un ruolo modesto e secondario, ma dalla selezione naturale seguita alla fusione dei genomi che si realizzano nelle simbiosi; il divenire-vita del “mondo” – la nascita di nuovi tipi di cellule, tessuti, organismi e specie – avviene mediante la composizione e la relazione; l’eroe della configurazione mondeggiante del mondo sono il “batterio” e l’“archeobatterio” che, fondendosi tra di loro, hanno dato vita a tutta la “complessità” della realtà vivente.
Si tratta di una costruzione cosmologica sicuramente affascinante e per certi versi determinante nel superamento di alcune abitudini di pensiero e incrostazioni concettuali, ma è il passaggio successivo a fare comunque problema: in che modo questo armamentario biologico, mitologico e cosmopolitico può permettere di affrontare la crisi simbolica, economica ed ecologica che determina il “mondo” e il “rapporto al mondo” nel qui e ora? Su questo punto, Donna Haraway, che mostra una strana mescolanza di pessimismo apocalittico e ottimismo ecologico, pur partendo dall’idea che occorra “sopravvivere su un pianeta infetto”, introduce una sorta di racconto di science-fiction, I Bambini del Compost, all’interno del quale racconta la vicenda di un simbionte, Camilla, metà donna e metà farfalla, nell’arco di circa 400 anni. In quelle che vengono chiamate Comunità del Compost, la vita scorre in maniera fortemente resistenziale: non c’è conflitto, ma soltanto resistenza dopo l’inevitabile; in queste nuove dinamiche di socialità non solo intra-specifica ma anche e soprattutto inter-specifica, si tratta di inventare nuove forme di simbiosi e simbiogenesi con gli animali e con la Terra (un divenire-animale e un divenire-Terra), in maniera tale da mettere in campo una serie di soluzioni in vista della cura nei confronti di un pianeta oramai infetto: alcuni innesti bio-ingegneristici fanno sì che si sviluppino ibridi di viventi umani e viventi nonumani, “compost” di un nuovo mondeggiare consapevole. Quello che potrebbe sembrare un classico jingle da “ritorno alla natura” mediante l’immagine di una simbiosi rispettosa del “mondo” e della “natura”, non rappresenta assolutamente un ripiegamento verso un immaginario new age di una Terra Madre da imparare ad amare e rispettare: il “mondo” è infetto, occorre trovare nuove forme del “mondeggiare”, ri-attivare il processo di co-evoluzione tra simbionti, all’interno di un “mondo” apocalittico sicuramente, ma in cui pian piano è possibile riattivare il processo simbiotico, realizzando un “mondeggiare” sostenibile in co-produzione tra viventi umani, viventi nonumani e ambiente. Le Camille che attraversano i prossimi 400 anni di storia umana invitano a un nuovo modo di intendere la relazione, un nuovo modo di creare relazioni e parentele (kin) al di là del bisogno individualistico di generare bambini (l’incubo della sovrappopolazione umana è ben presente nel libro della Haraway, tant’è vero che lo schema del making kin si basa su un principio di sostituzione di 3 a 1, per ridurre notevolmente la popolazione).
Se in Latour c’è l’idea che, per superare la crisi, si debba rimettere in campo una dinamica del conflitto, mediante la convocazione dei “terrestri”, dinamica comunque inafferrabile nel momento in cui la si volesse tradurre immediatamente in progetto politico, rappresentazione di un “collettivo” che sarebbe comunque tutto da creare[81], in Donna Haraway non c’è alcuna rappresentazione di un possibile “conflitto” per superare la crisi: il pianeta è irrimediabilmente infetto, occorre posizionarsi nel centro dell’infezione, e attivare nuove pratiche relazionali che vadano al di là di ogni distinzione, perché la distinzione presuppone sempre e comunque che esista qualcosa al di là della relazione; la proposta di Haraway è in continuità con certa science-fiction che lavora e rielabora il tema dell’utopia, è una cosmologia “nuova”, ma la dimensione del politico sfuma completamente sullo sfondo: se negli anni ‘80 la filosofa parlava di una nuova scienza/tecnologia che potesse andare oltre universalismo e differenzialismo, di un “sapere situato” fondato sulla solidarietà e la condivisione come possibilità di reinventare il socialismo, in questa ultima opera permane soltanto l’idea di una solidarietà elementare e intra- e inter-specifica, meramente resistenziale, le cui coordinate temporali sfumano e il nuovo possibile inizio si ha direttamente nel momento in cui l’infezione ha raggiunto il suo punto di non-ritorno, quando l’apocalisse è definitivamente accaduta. Resta allora soltanto un mondeggiare infetto e forme-di-vita simbiotiche che possono condurre a circoscrivere sempre più, nei secoli a venire, l’infezione. Nonostante l’ottimismo (l’umanità e la vita sopravvivranno perché la simbiosi creativa è il motore del “mondo” e del “mondeggiare”), si sente nell’aria la percezione dell’oramai è tardi.
- Tesi n. 4. La riattivazione del “rapporto al mondo” (umano e vivente) per procedere oltre la crisi simbolica, economica ed ecologica necessita della riattivazione del conflitto che, mettendo in discussione gli assunti binari e gerarchici della modernità, metta nuovamente in discussione il modo di produzione capitalistico
È ancora possibile fare qualcosa contro la crisi simbolica, economica ed ecologica della nostra contemporaneità? In che senso un determinato immaginario sul “mondo” e sul “rapporto al mondo” implica già-sempre una determinata posizione sulle strutture politiche e sui modi produzione? Il logos non può che essere ideologia? Si è fatto già tardi o c’è ancora la possibilità di intervento? Immaginare una possibilità di intervento significa ancora una volta rinnovare l’antropocentrismo, scrivendo una nuova pagina della grandezza e dell’eccezionalismo umano? Oppure, per essere davvero anti-antropocentrici, occorre ammettere di essere entrati in un’epoca che, di fatto e dal punto di vista simbolico, impone di restare a guardare sia perché ogni intervento è oramai inutile (l’Apocalisse sta già avvenendo, è in corso) sia perché occorre ripiegarsi nell’interiorizzazione del proprio sé e cercare una via di salvezza individuale?
Il nodo fondamentale che ha guidato questo studio sulla nozione di “mondo” e di “rapporto al mondo” nella filosofia del XXI secolo riguarda l’analisi e la mappatura di uno Zeitgeist che analizzi opzioni teoriche in connessione con possibilità di intervento nel e con il “mondo”: in una visione realmente “ecologica” – ed è questo, a nostro avviso, uno dei pregi del mantenere la nozione di “Antropocene” – la riflessione teorica e se si vuole teoretica non può che essere immediatamente declinata anche in termini etico-politici, in quanto si tratta dal punto di vista epistemologico e simbolico di saperi già-sempre situati, e che implicano immediatamente l’idea di una rassegnazione o di un intervento, di un’assenza o di una presenza di una possibilità di azione. Contro ogni rappresentazione anti-vitale (che non è anti-antropocentrica) del “mondo” che ha come correlato la necessità ontologica della non-azione, occorre riaffermare la possibilità di un intervento nel reale, come rispecchiamento di un compito per il pensiero che sorge da una problematizzazione epocale: se il “mondo” è costituito dalla relazione costante tra prospettive e potenze di agire (agency), il vivente umano deve identificare, all’interno di questo complesso intreccio, quale sia la sua possibilità di azione, le direzioni da imboccare, gli interventi da mettere in atto, sempre mantenendo fermo il principio di una co-produzione del “mondo” con gli altri esseri viventi umani e nonumani.
Si cita spesso – e, a nostro avviso, a ragione – una sorta di aforisma, che si richiama di volta in volta a Fredric Jameson o Slavoj Žižek, quello secondo il quale sarebbe più facilmente pensabile la fine del mondo che non la fine del capitalismo, al quale si potrebbe aggiungere, come corollario, che, al limite, è pensabile la fine del capitalismo soltanto nella misura in cui deve finire con esso anche il mondo. Si tratta dell’aspetto più inquietante e nichilista della nostra epoca: un misto di rassegnazione e accettazione, un dominio simbolico che sembra frenare ogni possibilità di azione e trasformazione radicale dell’esistente, una vittoria dal punto di vista della modernità capitalistica su ogni possibilità di pensare e agire altrimenti. Se la potenza di agire (agency) è, sin dalla sua matrice biologica, libera e creatrice – oltre ogni forma di determinismo biologico e/o sociale – occorre allora riattivare in maniera innovativa un “rapporto al mondo” che tenga conto delle densità di questa relazione vivente intra- e inter-specifica, in vista del superamento di ogni forma binaria di gerarchizzazione e di dominio dell’Uomo sulla Natura, dell’Uomo (come specie) sull’Uomo (come specie), dell’Uomo sulla Donna, dell’Uomo Occidentale sull’Uomo Altro e così via. Non si tratta più semplicemente di importare un modello biologico di interpretazione all’interno del dominio sociale (che ha assunto spesso la forma di una riproposizione onto-teologica di una necessità per definire la giustizia dello status quo): si tratta, piuttosto, di interpretare il “mondo” al di là di ogni relazione che tenda a essenzializzare i relati, come un qualcosa che si plasma costantemente attraverso la relazione, in maniera tale da leggere le forme di articolazione di viventi umani, viventi nonumani e realtà extraumana come una rete della vita fondata su un piano di immanenza reale e costitutivo che implichi la fine dello sfruttamento della Natura e dell’Uomo in quanto risorse.
Il percorso che è stato svolto all’interno di queste tesi provvisorie sulla nozione di “mondo” e di “rapporto al mondo” nella contemporaneità intendono indicare allo stesso tempo gli errori di lettura da evitare e alcune possibilità di azione in vista della costruzione di un “finale” alternativo alla “fine del mondo”. Riassumendo, dunque, quanto detto fino ad ora, è possibile affermare:
1) la nozione di “mondo” deve essere tanto più mantenuta quanto più si starebbe andando verso la sua fine: la nozione di “mondo”, scrostata da ogni interpretazione moderna e riduzionista, è fondamentale nel suo rinnovamento perché, come mostrato, essa determina fondamentalmente anche la nozione di vivente umano e nonumano che intendiamo ammettere e accogliere, nonché una rappresentazione della realtà come “relazione” determinante tra differenti forme di vita e potenzialità di azione (agency) – non solo va mantenuta l’idea di “mondo” ma anche quella di “rapporto al mondo”, anzi è possibile affermare che una nozione di “mondo” davvero innovativa ed efficace debba posizionarsi proprio come “rapporto al mondo”, all’interno del quale la relazione precede e produce, come forme metastabili e già sempre destinate alla decomposizione, i relati: all’interno di questa vicenda, l’uomo, anch’esso ovviamente prodotto di determinate relazioni e forme già-sempre mutevoli e decomponentisi, può avere e deve darsi ancora un “compito”, la determinazione di una potenza di agire che vada oltre il binomio fine del mondo-fine del capitalismo;
2) per riformare la nozione di “mondo” occorre andare oltre e volere fino in fondo la fine della natura, così come è stata pensata e strutturata a partire dall’evento fondamentale della modernità: se l’immaginario simbolico era stato preparato già dall’avvento della visione cristiana del mondo – e rinsaldato prima dall’idea di mondo come macchina e successivamente da equivoci costrutti naturalizzanti, l’evento decisivo è stato l’avvento del modo di produzione capitalistico, scandito prima dall’inversione della relazione terra/lavoro nella costruzione del “profitto” e poi dall’astrazione (ed estrazione) di una natura a buon mercato completamente a disposizione della cultura/società umana: per questo motivo, anche le ipotesi della green economy risultano essere inefficaci oltreché mostrare una bizzarra modalità di rimozione profonda del problema (quasi la manifestazione di una pulsione di morte) – in questo senso, accelerare la fine della natura significa accelerare la fine del capitalismo, ma la natura deve finire come dominato così come deve finire l’uomo come dominante, per riattivare la potenza di agire (agency) sia del vivente umano che del vivente nonumano in una relazione che sia già-sempre solidale;
3) per accelerare la fine del capitalismo occorre premunirsi da ogni seduzione nichilista nei riguardi di una “decomposizione” del “rapporto al mondo” che renda il “mondo” un “mondo morto”: affermare che il “mondo”, in quanto natura, non è a nostra disposizione, imparare a comprenderlo come una complessità del tutto vivente, come un tutto agente intrecciato in processi di co-evoluzione e co-produzione, significa di contro rivitalizzare e ripotenziare il “mondo”, dopo i dispositivi di devitalizzazione e depotenziamento messi in atto sin dall’avvento del Cristianesimo e riprodotti dall’ambiguità della concezione della natura nella modernità capitalistica – il “mondo” non è la “natura” nella misura in cui non è la “natura” alla quale pensiamo da uomini moderni e occidentali, ma dire che il “mondo” non è la “natura” (in quanto fittizia e ideologizzata) della modernità non significa che occorra andare oltre ogni visione latamente naturalistica del “mondo”, facendo di esso un qualcosa di inerte e morto, al di là di ogni potenza di costruzione e azione: ripensare il “rapporto al mondo” significa evitare le seduzioni di un assoluto anti-vitale e anti-umano, all’interno del quale anche un’azione rivoluzionaria e trasformativa non avrebbe senso – un pensiero che non tenga conto delle potenzialità metamorfiche e trasformative dei viventi umani e nonumani, sempre imbricati in un ambiente, rappresenta un paradigma che ha la sua maggiore pericolosità, non soltanto sul versante filosofico, ma anche e soprattutto sul versante “politico”: un mondo (che si vuole definitivamente) morto, affinché possa esistere, sembra il complemento riduzionista di una cadaverica ammissione di impotenza;
4) per accelerare la fine del capitalismo, senza cadere nell’immaginario cadaverico di un “mondo morto”, occorre rilanciare, dal punto di vista del logos, l’idea seminale dei “saperi situati”, da fondarsi (come si è visto) su dinamiche di solidarietà e discorsi condivisi, in cui il sapere diviene funzionale a un processo di emancipazione dei viventi umani e nonumani, e, dal punto di vista del “mondo”, una lettura delle sue manifestazioni più immediate, come un agente vitale complesso che trova nell’immagine mitologica del trickster la sua rappresentazione come fondamentalmente “contingente” (di una “contingenza”, comunque, connessa alla relazione tra “vincoli” e possibilità”), capace di andare oltre le cosmologie e cosmopolitiche fondate su meccanicismo e vitalismo – occorre, dunque, uscire da quella che abbiamo definito con Tim Ingold “cosmologia meccanico-teorica” della modernità occidentale in vista dell’uscita dal capitalismo: la crisi simbolica, economica ed ecologica nella quale siamo immersi rappresenta a pieno la complessità storica di questo momento e la duplice necessità (duplice, perché interconnessa) di una rivoluzione simbolica e una rivoluzione politico-economica;
5) per accelerare la fine del capitalismo occorre essere profondamente ecologici, nella misura in cui l’ecologia è l’unico orizzonte discorsivo che permetta di definire un piano unico di intervento laddove la modernità ha prodotto allo stesso tempo distinzioni e ibridazioni ideologiche, per cui a essere potenziato deve essere il “rapporto al mondo” letto in una chiave che ha come fondamento la solidarietà intra- e inter-specifica – occorre affermare che il “mondo” è un concetto normativo;
6) per accelerare la fine del capitalismo non bisogna temere la riattivazione di dinamiche di conflitto in seno alle società globali, ma cercare di promuovere una connessione costante (perché determinante) tra istanze di lotta contro il capitale e istanze di lotta contro il surriscaldamento globale, al di là della falsa alternativa tra “lavoro” e “ambiente” – se è vero che oggi sembra più facile pensare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, è anche vero che lottare in vista della fine del capitalismo significa sicuramente (e mai come oggi) lottare contro la fine del mondo.
[1] Non è possibile esaurire all’interno di una nota una complessa, articolata e davvero ricchissima bibliografia sul concetto di Antropocene. Ci permettiamo di rinviare innanzitutto al dossier tematico sull’Antropocene Umano, troppo (poco) umano, a cura di P. Amodio, V. Carofalo, D. Salottolo, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 21, 2019, pp. 6-198 (consultabile al seguente link: https://www.scienzaefilosofia.com/wp-content/uploads/2019/07/revSF_21.pdf). Diamo poi soltanto alcune indicazioni di base sugli studi che possono permettere un primo approccio alla questione: 1) la nascita del concetto: cfr. P.J. Crutzen, E. F. Stoermer, The Anthropocene, in «IGPB Newsletter», 41, 2000, pp. 17-18; 2) lo stato del dibattito: cfr. Y. Malhi, The Concept of the Anthropocene, in «Annual Review of Environment and Resources», 42, 2017, pp. 77-104, J. Lorimer, The Anthropo-scene: A guide for the perplexed, in «Social Studies of Science», 47, 2017, pp. 117-142; 3) il problema della temporalità specifica: cfr. D. Chakrabarty, The Climate of History: Four Theses, in «Critical Inquiry», 35, 2009, pp. 197-222, Id., Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change, in «New Literary History», 43, 2012, pp. 1-18, Id., Anthropocene Time, in «History and Theory», 57, 2018, pp. 5-32; 4) la questione politica: cfr. A. Malm, A. Hornborg, The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative, in «The Anthropocene Review», 1, 2014, pp. 62-69, S. Barca, L’Antropocene: una narrazione politica, in «Riflessioni sistemiche», 17, 2017, pp. 56-67; 5) alcuni libri importanti (dalla nostra prospettiva): D. Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, tr. it. Nero, Roma 2019, B. Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le Nouveau Régime Climatique, La Decouverte, Paris 2015, J.W. Moore, Ecologia-mondo e crisi del capitalismo. La fine della natura a buon mercato, tr. it. ombre corte, Verona 2015, Id., Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell’era della crisi planetaria (2016), tr. it. ombre corte, Verona 2017.
[2] «Antropocene alla moda: un modo specifico di pensare le origini e l’evoluzione della crisi ecologica moderna […] ha funzionato non solo in ragione della sua plasticità, ma anche perché ben si adatta a una visione di popolazione, ambiente e storia governata dall’uso delle risorse (alimentari e non) e astratta dalle classi e dagli imperi (tra le altre cose)» (J. W. Moore, Antropocene o Capitalocene?, cit., p. 30).
[3] Il mondo artistico e letterario si sta confrontando con le questioni connesse all’Antropocene e al suo correlato, il surriscaldamento globale, in maniera continuata: non solo le mostre si stanno susseguendo (anche in Italia, dove il concetto è certamente meno alla moda che in USA o in altri paesi europei), ma si sta facendo avanti anche una riflessione intorno a quello che si vorrebbe definire “romanzo dell’Antropocene”, anche oltre i limiti della sci-fi e della sua sottocategoria, cli-fi (Climate-Fiction), ma sempre in linea con la letteratura speculativa (cfr. ad esempio https://lagrandestinzione.wordpress.com/).
[4] Ci riferiamo a una delle definizioni per noi più pregnanti di ecologia: «l’ecologia non è una scienza di funzioni: le popolazioni di cui descrive le “ingarbugliate modalità” di esistenza, non sono del tutto definite dai rispettivi ruoli giocati nel groviglio, così da poterne dedurre l’identità di ciascuna in funzione del suo ruolo» (cfr. I. Stengers, La guerra delle scienze. Cosmopolitiche I (1996-1997), in Cosmopolitiche (1996-1997), tr. it. Luca Sossella Editore, Roma 2005, p. 45).
[5] Cfr. M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica (1983), tr. it. Donzelli, Roma 2005. Sempre in termini di un analisi del divenire problema dell’Antropocene, potrebbe essere interessante sottolineare da un lato come il termine fosse stato “inventato” già negli anni ’80 del secolo trascorso dal microbiologo Stoermer e dall’altro come tanta riflessione di cui oggi è esso stesso il segno sia nata ben prima della diffusione di questo termine, come si noterà da alcuni testi che verranno discussi e citati in questo saggio, quando questo termine-concetto non era ancora né di moda né utilizzato normalmente. La genealogia di questo divenire problema eccede i limiti di questo scritto ma non si può non notare una multitemporalità ambigua e spiazzante delle evidenze e dei regimi discorsivi: l’allarme sul surriscaldamento globale è stato lanciato – e recepito ad esempio da tanta letteratura sci-fi – più di 40 anni fa.
[6] Utilizziamo il termine farmacologia a partire dall’impostazione epistemologica di Isabelle Stengers: «C'è una “Grande partizione” che ci separerebbe, noi Occidentali […] da tutte le altre culture? Per una figlia della tradizione filosofica, questo dovrebbe essere un dato di fatto, appreso nutrendosi al biberon dei testi sacri di questa stessa tradizione. Partizione: questa è, continuamente, la questione in Platone; partizione fra l'opinione e il sapere razionale, partizione fra i sofisti e i filosofi, partizione fra la verità che, come il sole, ha il potere di fare l'unanimità, e il pharmakon, la droga ambigua, temibile, perché i suoi effetti possono mutarsi nel loro contrario a seconda del dosaggio, delle circostanze, delle intenzioni. Partizione fra coloro che si compiacciono fra le ombre mutevoli e poco affidabili della caverna e colui che sa, per esserne uscito, perché quelle ombre sono ingannevoli» (I. Stengers, La Grande partizione (1994), tr. it. in «I fogli di ORISS», 29, 2008, pp. 47-61, qui p. 47; è possibile leggere il saggio online al seguente link: http://stefaniaconsigliere.it/incroci.html).
[7] Si tratta della proposta teorica di Jason W. Moore (cfr. J. W. Moore, Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, cit., e Id., Antropocene o Capitalocene?, cit.), ma la questione è più “complessa”: Donna Haraway racconta che «stando ad alcune comunicazioni via mail tra Jason Moore e Alf Hornborg nel tardo 2014, Malm ha proposto il termine Capitalocene in un seminario a Lund in Svezia nel 2009 […] io l’ho usato la prima volta in una serie di conferenze a partire dal 2012» (D. Haraway, Chthulucene, cit., p. 237 – questa contemporaneità di elaborazione anche terminologica rappresenta davvero una prova della pervasività di questo Zeitgeist!).
[8] Si tratta, come già visto, della ultima proposta di Donna Haraway, cfr. D. Haraway, Chthulucene, cit.
[9] Cfr. ad esempio G. Mittman, Reflections on the Plantationocene: A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing, consultabile su https://edgeeffects.net/haraway-tsing-plantationocene/.
[10] Molto duro il giudizio di Bruno Latour, anche perché emesso quando non era ancora assolutamente di moda criticare il postmoderno, quando afferma che «il postmoderno è un sintomo e non una soluzione nuova. Vive sotto la Costituzione moderna, ma non crede più alle garanzie che offre […] Razionalisti pentiti, i suoi adepti avvertono la fine della modernità […] Si sentono venuti “dopo” i moderni, ma con la sgradevole sensazione che non ci sia più un “dopo”. No future: ecco la parola d’ordine [..] Che cosa rimane per loro? Istanti slegati e denunce infondate, perché i postmoderni non credono più alle ragioni che permetterebbero loro di denunciare o di indignarsi» (B. Latour, Non siamo mai stati moderni (1991), tr. it. elèuthera, Milano 2016, pp. 68-69).
[11] B. Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Decouverte, Paris 2015, p. 148. Questa traduzione e le successive sono nostre.
[12] Sul tema si è interrogato e si continua a interrogare Dipesh Chakrabarty (Cfr. D. Chakrabarty, The Climate of History: Four Theses, in «Critical Inquiry», 35, 2009, pp. 197-222; Id., Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change, in «New Literary History», 43, 2012, pp. 1-18; Id., Anthropocene Time, in «History and Theory», 57, 2018, pp. 5-32).
[13] Ci permettiamo di rinviare, per la continuità tra le riflessioni, al nostro D. Salottolo, L’esperienza allargata. Riflessioni sull’Antropocene, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 21, 2019, pp. 50-75.
[14] Cfr. K. Löwith, Dio, Uomo e Mondo nella metafisica da Cartesio e Nietzsche (1967), tr. it. Donzelli, Roma 2000.
[15] Una delle rappresentazioni più inquietanti di questa Apocalisse senza Regno, in stretta connessione con il tema dell’ambiguità della “bontà” come estrema resistenza, lo si trova nello splendido romanzo La strada di Cormac McCarthy: «Volevi sapere come erano fatti i cattivi. Adesso lo sai. Potrebbe succedere di nuovo. Io ho il dovere di proteggerti. Dio mi ha assegnato questo compito. Chiunque ti tocchi, io lo ammazzo? Hai capito? Sì. Il bambino se ne stava intabarrato nella coperta. Dopo un po’ alzò gli occhi. Siamo ancora noi i buoni?, disse. Sì. Siamo ancora noi i buoni. E lo saremo sempre. Sì. Lo saremo sempre. Ok». (C. McCarthy, La strada (2006), tr. it. Einaudi, Torino 2014, pp. 59-60).
[16] K. Löwith, Dio, Uomo e Mondo, cit., p. 6.
[17] Cfr. ibidem.
[18] Ci permettiamo di rinviare al nostro D. Salottolo, Solidarietà e modernità. Saggio sulla “filosofia” di Émile Durkheim, Meltemi, Milano 2018.
[19] K. Löwith, Dio, Uomo e Mondo, cit., p. 7.
[20] Ibid., p. 8.
[21] Cfr. ibid., pp. 8-9.
[22] Ibid., p. 10. La sottolineatura è dell’autore.
[23] Ibid., p. 12.
[24] Cfr. ibid., 13.
[25] «La conoscenza e la tecnologia, applicate con giudizio, possano conseguire l’avvento di un positivo, persino superlativo, Antropocene […] Un Antropocene generoso con la specie umana implica che gli uomini applichino con padronanza i loro crescenti poteri sociali, economici e tecnologici per migliorare il benessere dei loro simili, stabilizzare il clima e proteggere il mondo naturale» (si tratta di un passaggio del Manifesto Ecomodernista, che è possibile consultare al seguente indirizzo: http://www.ecomodernism.org/italiano). Per una critica molto efficace cfr. C. Hamilton, Anthropocene as rupture, in «The Anthropocene Review», 32, 2016, pp. 93-106.
[26] Si tratta di una riflessione profondamente influenzata da Henri Bergson (ma non pretendiamo di far dire a Bergson qualcosa che non ha detto), il quale tratta la questione del rapporto tra “corpo”, “spirito” (oggi, forse, diremmo “mente”) e “mondo” all’interno di una delle sue opere indubbiamente più importanti (e nella quale davvero ci troviamo lontani da ogni riduzionismo di tipo “spiritualistico”), cfr. H. Bergson, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito (1896), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2006.
[27] Molto efficacemente – e già nel 1999 – Bruno Latour mostra come la natura, in quanto «amalgama di politica greca, di cartesianesimo francese e di parchi americani» (cfr. B. Latour, Politiche della natura: per una democrazia delle scienze (1999), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2000, p. XV) deve essere assolutamente superata per mettere in campo un progetto di ecologia che sia davvero (cioè in senso latouriano) “politica”.
[28] B. Latour, Face à Gaïa, cit., p. 16.
[29] Ibid.
[30] J. W. Moore, Antropocene o Capitalocene?, cit., p. 41.
[31] Evitiamo chiaramente di discutere le posizioni di chi auspica un ritorno all’età delle caverne, anche se rappresenta indubbiamente un aspetto che rientra pienamente nello Zeitgeist dell’Antropocene.
[32] Cfr. I. Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, La Découverte, Paris 2013. L’intero libro della filosofa è un atto d’accusa a coloro che vengono definiti “responsabili” e che invitano tutti alla “responsabilità” senza distinzione di classe, genere, razza; il libro è attraversato da una tensione etico-politica davvero importante. Ma chi sono i “responsabili”? «Quanto agli Stati, noi sappiamo che, in un grande slancio di rassegnazione entusiasta, essi hanno rinunciato all’insieme dei mezzi che avrebbero permesso loro di prendersi le proprie responsabilità e hanno affidato al libero mercato mondializzato il carico dell’avvenire del pianeta. A costo di “regolare” – è ormai all’ordine del giorno – per evitare gli “eccessi”. È per questo motivo che io li chiamo i “nostri responsabili”» (p. 20); più avanti l’attacco è ancora più diretto: «“Ma che avreste fatto voi al nostro posto?” Al che solo una risposta si impone: “Noi non siamo al vostro posto”, risposta ben poco educata, ma salubre. Rifiutare di mettersi al “loro” posto, significa, in effetti, rifiutare l’anonimato che rivendicano coloro che si sentono responsabili […] è senza mandato che essi hanno definito i limiti dell’azione politica in relazione a una sottomissione integrale a ciò che definiscono come leggi del mercato» (p. 113). La traduzione è nostra.
[33] «Primo paradosso. La natura non è una nostra costruzione: è trascendente e ci travalica infinitamente. La società è una nostra costruzione: è immanente al nostro agire. Secondo Paradosso. La natura è una nostra costruzione artificiale in laboratorio: è immanente. La società non è una nostra costruzione: è trascendente e ci travalica infinitamente» (Cfr. B. Latour, Non siamo mai stati moderni, cit., Figura 2, p. 52).
[34] Sul tema è molto preciso e radicale il sociologo francese Razmig Keucheyan quando afferma, in relazione alle tematiche del razzismo ambientale negli USA, che «wilderness e whiteness sono dunque due categorie – o meglio, due istituzioni – che si sostengono a vicenda. La natura statunitense è “pura” solo nella misura in cui quel gruppo sporco e oscuro per eccellenza che sono i nativi ne è stato estirpato. Insieme ai neri, ma in modi diversi, sono i grandi esclusi dalla “natura” in via di costruzione in quest’epoca» (R. Keucheyan, La natura è un campo di battaglia. Saggio di ecologia politica (2014), ombre corte, Verona 2019, p. 53).
[35] I. Stengers, Au temps des catastrophes, cit., p. 130
[36] La categoria di “intrusione” la si deve a Isabelle Stengers, se ne parlerà più diffusamente nel corso della trattazione (cfr. I. Stengers, Au temps des catastrophes, cit.).
[37] La nozione di “natura a buon mercato” la si deve a Jason W. Moore. Cfr. J. W. Moore, Ecologia-mondo e crisi del capitalismo, cit., in particolare il saggio La fine della natura a buon mercato. Come ho imparato a non preoccuparmi dell’ambiente e ad amare le crisi del capitalismo, pp. 91-123.
[38] B. Latour, Face à Gaïa, cit., p. 51.
[39] J. W. Moore, La fine della natura a buon mercato, cit., pp. 114-115.
[40] Id., Antropocene o Capitalocene?, cit., p. 57.
[41] Sulle questioni connesse alla riproduzione sociale e su quello che viene definito “separatismo critico” tra dimensione economica, ecologica e politica è molto puntuale N. Fraser, La fine della cura. Le contraddizioni sociali del capitalismo contemporaneo (2016), tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2017.
[42] D. Danowski, E. Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine (2014), tr. it. nottetempo, Milano 2017, p. 36.
[43] Si tratta di un termine molto caro a Isabelle Stengers, cfr. I. Stengers, Cosmopolitiche, cit.
[44] È il termine con cui Isabelle Stengers, ironicamente, parla dell’intrusione di Gaia come fenomeno cosmopolitico fondamentale, cfr. I. Stengers, Au temps des catastrophes, cit.
[45] Cfr. Q. Meillassoux, Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contingenza (2006), tr. it. Mimesis, Milano-Udine, 2012.
[46] Cfr. B. Latour, Non siamo mai stati moderni, cit.
[47] Cfr. I. Stengers, Cosmopolitiche, cit.
[48] Cfr. D. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (1991), tr. it. Feltrinelli, Milano 2018.
[49] Cfr. D. Danowski, E. Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire?, cit., pp. 76-87.
[50] Cfr. B. Latour, Face à Gaïa, cit., e I. Stengers, Au temps des catastrophes, cit.
[51] Cfr. D. Haraway, Chthulucene, cit.
[52] Q. Meillassoux, Tempo senza divenire (2008), tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 9.
[53] Cfr. D. Haraway, Saperi situati: la questione della scienza nel femminismo e il privilegio di una prospettiva parziale, in Manifesto cyborg, cit., pp. 103-134.
[54] Cfr. R. Brassier, I. Hamilton Grant, G. Harman, Q. Meillassoux, Speculative Realism, in «Collapse», 3, 2012, pp. 307-450.
[55] Cfr. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari, 2012.
[56] Q. Meillassoux, Tempo senza divenire, cit., p. 17.
[57] Su questi passaggi hanno indubbiamente ragione Viveiros de Castro e Danowski quando affermano che «il tutto procede come se la negazione di questo punto di vista fosse un requisito di cui il mondo ha bisogno per esistere – curioso idealismo negativo, strano soggettivismo cadaverico» (Cfr. D. Danowski, E. Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire?, cit., p. 84).
[58] Q. Meillassoux, Dopo la finitudine, cit., p. 101
[59] «Non può esserci X senza che X sia data e nessuna teoria che riguardi X senza che X sia posta» (cfr. Q. Meillassoux, Tempo senza divenire, cit., p. 10).
[60] Q. Meillassoux, Tempo senza divenire, cit., p. 31.
[61] Ibidem.
[62] Cfr. A. Longo, Contingenza e libertà: un confronto tra materialismo speculativo e scienza sperimentale, in Q. Meillassoux, Tempo senza divenire, cit., pp. 37-68, qui p. 61.
[63] Cfr. N. Coombs, Speculative Justice: Quentin Meillassoux and Politics, in «Theory and Event», 17, 2014 (consultabile al seguente link: https://www.research.ed.ac.uk/portal/files/17941244/Speculative_Justice_071014.pdf).
[64] Ibid., p. 24. La traduzione è nostra.
[65] D. Haraway, Un manifesto per Cyborg: scienza, tecnologia e femminismo socialista nel tardo Ventesimo secolo, in Manifesto cyborg, cit., p. 78.
[66] Id., Saperi situati: la questione della scienza nel femminismo e il privilegio di una prospettiva parziale, in Manifesto cyborg, cit., p. 107.
[67] Ibid., p. 115.
[68] Ibid., p. 125.
[69] Ibid., p. 128.
[70] Ci riferiamo, ovviamente, al titolo (e al contenuto) del famoso saggio di J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea (1970), tr. it. Mondadori, Milano 1971.
[71] Cfr. T. Morton, Iperoggetti (2013), tr. it. Nero, Roma 2018. Il testo, indubbiamente suggestivo, pone non pochi problemi di carattere storico-filosofico – uno su tutti: gli iperoggetti sono la realtà stessa e l’uomo ne avrebbe raggiunto la consapevolezza soltanto nel qui e ora del surriscaldamento globale, oppure si tratta di un “evento” epocale, di un “passaggio”, di una “trasformazione” nella storia del “mondo” e del “rapporto al mondo”? Su questo punto, ad esempio, il filosofo americano è molto oscillante.
[72] Cfr. ad esempio J. Lovelock, Gaia. Nuove idee sull’ecologia (1979), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2017. L’autore è tornato comunque più volte sul tema in un numero consistente di opere: in questo saggio non si intende discutere questa evoluzione interna al suo pensiero, ma l’efficacia che la sua immagine ha sulla filosofia contemporanea ai tempi dell’Antropocene.
[73] Cfr. T. Ingold, Una passeggiata nel regno delle tecniche (1997), in T. Ingold, Ecologia della cultura, tr. it. Meltemi, Milano 2016, pp. 141-187.
[74] B. Latour, Face à Gaïa, cit., p. 114.
[75] Cfr. G. Canguilhem, La conoscenza della vita (1965), tr. it. Il Mulino, Bologna 1976, in particolar modo i saggi Aspetti del vitalismo (pp. 125-147) e Macchina e organismo (pp. 149-183).
[76] D. Haraway, Chthulucene, cit., p. 13.
[77] Ibid.
[78] Per comprendere l’impatto degli studi della biologa radicale Lynn Margulis e le prospettive che apre cfr. S. F. Gilbert, J. Sapp, A. I. Tauber, A symbiotic view of life: we have never been individuals, in «The Quarterly Review of Biology», 87, 2012, pp. 325-341. Nell’articolo, scritto da un filosofo e due biologi, si dimostra innanzitutto in che modo la biologia ispirata a una teoria della “simbiosi” metta in discussione (dal punto di vista anatomico, embriologico, fisiologico, genetico, immunologico ed evolutivo) il concetto di “individuo” come unità base dell’analisi biologica e alcune dicotomie tipiche della riflessione occidentale (self/nonself, subject/object); dopodiché si sottolinea come il superamento della vecchia visione individuale e individualistica possa aprire nuove frontiere di studio ma anche nuove applicazioni pratiche all’analisi delle malattie e alle eventuali terapie. L’articolo si conclude con una citazione tratta da un dibattito tra Dawkins e Margulis, dove lo scienziato, sottolineando l’economicità della teoria classica dell’evoluzione di contro all’anti-economicità della teoria simbiogenetica della Margulis, chiede perché bisognerebbe seguire quest’ultima, al che la biologa radicale risponde con un laconico “perché è così”. Individualismo ed economicismo si accompagnano sempre in una visione del “mondo” complessiva e fortemente influenzata da quella specifica cosmologia moderna e occidentale che si sta tentando di analizzare in questo scritto (da intendersi sempre come intreccio di razionalità riflessiva e modo di produzione capitalistico).
[79] D. Haraway, Chthulucene, cit., p. 89.
[80] Ibid., p. 90
[81] Cfr. B. Latour, Face à Gaïa, cit., pp. 285-328. Il problema fondamentale della proposta del prolifico pensatore, che qui non possiamo affrontare in tutta la sua ampiezza, riguarda una serie di questioni che, per semplicità, possiamo riassumere in una sola domanda: per quale motivo – grazie a quale mutamento radicale di visioni del mondo, simbologie, politiche, economie – dominanti e dominati dovrebbero, nel nome della conservazione del “suolo”, riunirsi per un progetto comune che, di fatto, porrebbe fine proprio alle categorie di “dominanti” e “dominati” in nome di una umanità rinnovata e pacificata con il “mondo”? Per un intervento in cui la costruzione teorica latouriana incontra problemi attuali e concreti C. Riquier, Una Terra senza popolo, dei popoli senza Terra: intervista a Bruno Latour, consultabile al seguente indirizzo: http://effimera.org/terrasenza-popolo-dei-popoli-senza-terra-intervista-bruno-latour-camille-riquier/.