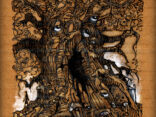Autore
Indice
- Lo straniero
- Contro il Fedro
- La natura originaria della mancanza e la matrice inautentica della correlazione
S&F_n. 21_2019
Abstract
Dominant and recessive Characters. Michelstaedter on the Genesis of Correlation
The aim of this paper is to outline the criticism of the notion of correlative in Michelstaedter, referring to the differences between the role of relationship in Plato’s Phaedrus and in La persuasione e la rettorica. Michelstaedter believes that will represents the essence of man. Man’s will, as infinite, must remain unsatisfied and devoid of object in order to be what really it is. At the same time, as a will, man projects objects that seem to delimit him out of itself. From this the illusion of correlation arises.
A quegli aeronauti dello spirito che, un tempo temerari uccelli, finirono con l’arrestarsi, vinti dalla stanchezza.
- Lo straniero
Allorché individuò il nocciolo della ricerca nella conoscenza di sé, Socrate lanciò, a chiunque avesse deciso di intraprendere il cammino accidentato di un’indagine teoretica che fosse, al tempo stesso, l’accertamento pratico di una scelta di sapienza e di vita, la sfida della risoluzione di un autentico enigma. Se ogni forma di sapere esige che un oggetto, quale che esso sia - fosse anche il soggetto medesimo - si offra a un ente affinché questi sperimenti, per il tramite dell’esercizio dinamico del pensiero, il movimento di rimbalzo che gli restituirà l’avvertimento di un’alterità finalmente posseduta, anche il conoscersi sarà sempre marchiato dai caratteri della spinta centrifuga della propria identità, faticosamente costruita attraverso una relazionalità che si vela e disvela in virtù della stessa struttura duale del pensiero. Non importa la natura dello specchio la cui superficie riflettente ci racconterà qual-cosa su di noi; l’identità resterà, comunque, una meta che sfugge. Che il rivelarsi di noi a noi stessi avvenga attraverso un simile o un dis-simile, il margine che allontana dall’identificazione non sarà colmato, e il confronto rinvierà, in ogni caso, a uno straniero. A meno che, naturalmente, l’approssimazione progressiva e tangenziale al tautò, rispetto al quale simile e dissimile restano gradi di maggiore o minore adeguamento, non postuli una struttura non auto-predicativa, che incarni il criterio trascendente del nostro identificarci con noi stessi attraverso l’altro, in ragione, anche, dello scoprire l’impossibilità empirica dell’uguale[1].
Nel caso, però, in cui si rifiuti la soluzione platonica - e, con essa, la garanzia di un paradigma in grado di inverare la natura delle immagini, mostrandone la comunanza con un originale-eterno -, l’alterità, nel suo perenne oscillare tra somiglianza e dissomiglianza, resterà un fuoco eccentrico: essa, resistente alla pretesa che si rinvenga, nel sé (altro-per-l’altro) e nell’altro-da-sé (sé-per-l’altro), una uni-forme radice, conserverà sempre i caratteri di una falsificazione del sé, miscelata alla scoperta di un’individualità irriducibile, causata da una fuga che non trova arresto in una misura comune. E se lo specchio restituisce immagini che, private della misura platonica, restano parvenze liminali alla negazione di sé, l’esperienza del pensarsi non potrà esimersi dalla constatazione di un’aporia esente da soluzione: il riflesso potrebbe non rappresentarci, pur nel suo annunciarsi simile a noi; o, all’inverso, la dissonanza prodotta da un rinvio dissimile potrebbe istanziare la scoperta più profonda della nostra identità. In assenza di un metron, il simile e il dissimile tenderanno a equivalersi nel loro potenziale raccontarci il nostro essere o quello altrui, lasciando, a un tempo, che si insinui, in entrambi i casi, la dissimulazione reciproca. Dunque, il riflesso potrà ugualmente mostrare o celare noi a noi stessi e, specularmente, ingannare l’altro.
Pertanto, sia che l’immagine contribuisca alla ricerca genuina da parte del sé di se stesso, sia che lo decentri e lo addensi attorno a una falsa conquista, l’eikon resterà, per così dire, uno zingaro, invitato nella casa del nostro essere, come di quella altrui, per una comparsa accidentale, che mai reca con sé la certezza di un racconto veritiero. Se infatti noi, invisibili a noi stessi, diventiamo (in parte) visibili attraverso quei simili - o dissimili - per cui acquistiamo trasparenza, lo specchio di quel pozzo senza fondo nel quale ci specchiamo sarà un atto riflesso doppio, nel quale riconoscersi e perdersi. E, allora, non potremo mai escludere che a restare latente, per non essere diventato luminoso, sia stato l’aspetto di noi che avrebbe meritato diritto all’espressione. Analogamente a quei caratteri recessivi che, se pure ereditati, non determinano segni evidenti ed emergenti, il fondo del nostro sé potrebbe sfuggirci, in ragione dell’assenza di una superficie attraverso la quale determinarsi. O, forse, per l’impossibilità strutturale di rivelarsi attraverso una superficie corrispondente.
- Contro il Fedro
Il Fedro difende l’idea che, solo allorché ci si apra al dolore e al furore prodotti da una relazione erotica, soltanto quando sia stato avviato il riflesso reciproco degli sguardi, si attiveranno, infine, le condizioni in assenza delle quali mai si verificherà quella viva percezione della mancanza e quella fame di comunanza che sono premessa al salto nel nucleo stesso della visione di sé, dell’altro e della radice comune a entrambi[2]; nella relazione tra-due-simili - capace di riempire il vuoto di ciascuno e, al tempo stesso, di rinviarlo oltre se stesso verso un fondamento il quale, in sé perfetto, non esige più di essere colmato - finalmente l’ente si ritrova e stabilmente si conosce.
Commentando questa convinzione platonica, secondo la quale sarebbe possibile vedere in un’anima affine, come allo specchio, se stessi, Carlo Michelstaedter rileva come l’«amplesso dei due organismi» non comporti, necessariamente, una reciproca scoperta; al contrario, il correlativo tende a ridursi a sola «materia alla propria vita»: ne consegue che, se proprio esiste un atto speculare, questo consisterà nell’essere anche noi «mezzo materiale» per l’altro[3].
In una peculiare declinazione teoretica del volontarismo schopenhaueriano, che contamina l’anassimandrea colpa del nascere con l’hegeliano scontro fra le autocoscienze, ogni esistere-individuo si afferma negando: quanto chiamiamo somiglianza e crediamo essere l’esito di un’armonia reciproca o è l’affermazione di qualcosa ai danni di qualcos’altro - che, pur di non morire a causa della mancata corrispondenza, ha preferito cedere, nell’attesa di determinarsi e scoprirsi altrove, in un ulteriore e meglio corrispondente correlativo - o risulta dal casuale incastro fra i denti di due ruote che, nel loro accidentale muoversi all’unisono, mascherano, comunque, un originario atto di violenza, individuabile nella pretesa stessa della correlazione tra simili. Una violenza che, nel caso dell’amore - nome che cela il supremo atto distruttivo -, può sfiorare il suicidio/omicidio: qualora, infatti, accada di imbattersi in quella forma di relazione che, più di tutte, pare sfamare, essa, sfamando, priverà le parti coinvolte del fondo oscuro da cui si attinge la vita; è nel correlativo perfetto, ovvero in quell’altro-mondo-a-sé costituente l’orizzonte della soddisfazione della nostra deficienza, che si trova, insomma, la morte[4].
L’aspetto violento che Michelstaedter intravede nella psicologia platonica è certamente rintracciabile nelle Leggi. Qui, a proposito di una puntualizzazione che riguarda la funzione politica della paura, Platone consegna al lettore una descrizione dell’uomo che sottopone il modello tripartito dell’anima a una revisione: questa, universalmente, fa soggiacere ogni essere dotato di vita all’azione di due affezioni contrarie, riconducibili al piacere e al dolore, rispetto alle quali il vivente si muove come un burattino tirato da fili; non è in potere dell’uomo evitare di rispondere agli stimoli determinati da tali passioni; egli può solo indebolire la pressione di uno dei due fili, rinforzando l’altro, nel tentativo di sotto-ordinare quello che crede essere il peggio al meglio[5]. Platone confida nell’accorto legislatore affinché egli contribuisca, con opportune strategie, a rinforzare nel cittadino le affezioni migliori[6]; ciò non fuga, tuttavia, il dubbio che dipenda da fattori esposti alla contingenza lo sviluppo di sé e che, in presenza di situazioni ambientali inadeguate, o di fronte all’opera di legislatori meno accorti, il cosiddetto meglio possa essere sopraffatto dal peggio. In particolare, sorge il sospetto che, a meno che non si accolga come indubitabilmente vera la visione organicistica che fa del singolo la riproduzione olografica dell’intero, ciò che dell’individuo si cerca di far emergere sia non l’oggettivamente migliore ma, semplicemente, quanto sarà più facilmente riconducibile a produrre incastri con ciò che nell’altro si è contribuito a far risaltare.
Ciò precisato, non si può escludere che, in verità, anche il modello erotico-educativo delineato nei dialoghi non sia del tutto esente dal rischio di rivelare una matrice violenta, celata dietro la considerazione, costruita attraverso l’analogia con l’arte delle levatrici, che la maieutica ricorre a filtri e incantamenti per produrre tanto nascite, quanto aborti[7].
Possiamo almeno sospettare che la smisuratezza di Alcibiade nel Simposio e la mania difesa nel Fedro come via d’accesso al vero lambiscano una soglia critica, che lascia adito a dubbi circa la possibilità di una netta demarcazione tra lo scoprire se stessi e il perdersi, tra lo specchiarsi nell’altro e il dominarlo?
È possibile che l’innamorarsi incarni l’acceleratore di uno stato potenzialmente proiettivo, in cui l’amante e l’amato, anziché scoprire un oggetto condiviso e reale, si fanno reciprocamente e illusoriamente eco, in un infinito rinvio di specchi paralleli che porta alla luce non il sé, ma ciò che, nell’altro, il sé voleva vedere di se stesso, nell’atto riflesso dell’apparente confronto?
- La natura originaria della mancanza e la matrice inautentica della correlazione
Il gioco del dominare-e-soccombere è possibile solo dove la vita si riduca, come accennato, a un mero relazionarsi, qui o altrove, senza che mai avvenga di trarre da sé il proprio vero sé; ciò in nome di cui, in altri termini, la vita venga davvero messa in gioco in sé e per sé[8].
Cosa dà cominciamento, in ultima istanza, alla correlazione, cui sembra impossibile sottrarsi, tanto che l’allievo di Socrate avrebbe edificato, a sua eterna giustificazione, il luminoso edificio delle idee? Sulla scia di Platone, Michelstaedter schizza un ritratto dell’uomo che, ancorandolo all’antro oscuro della persuasione, individua nella «mancanza» ciò che, di fatto, rappresenta la vita di ciascuno[9]. Obiettando alla retorica platonica, egli ritiene, però, tale mancanza originaria e ineludibile, per cui nessun contenuto - comunque si intenda il contenuto - potrà mai colmarla, se è vero che la natura non etero-fondata dell’insufficienza rinvia al fatto che l’uomo esiste in quanto-vuole, senza, tuttavia, mai trovare un correlativo che dia veramente ragione stabile e oggettuale al proprio volere; al tempo stesso, per il fatto di e-sistere, l’ente occupa uno spazio, e ciò implica che egli abbia un peso; ma, come puntualizza Michelstaedter, ogni «peso pende e quanto pende dipende» proprio da quella superficie prodotta dall’illusione speculare del (ri)trovarsi oltre: quindi, il volere proverà a realizzarsi su una struttura ontica la quale, circolarmente, nell’atto di affermarlo negherà la sua intrinseca struttura infinita e mancante. Nasce da questa tensione insanabile tra l’indeterminazione e la determinazione la ricerca di specchi correlativi che, quando trovati, contribuiscono a oscurare la verità dell’uomo. La perdita di sé, che condanna nell’attimo medesimo in cui la fame inesauribile della volontà appare placata, è generata dalla costruzione di una delimitazione a opera del volere medesimo: questa lega, all’indeterminato volente, un voluto a esso momentaneamente commisurato e, in tal modo, rinchiude il sé, bloccandolo di fronte alla scoperta di un oggetto che sembra corrispondere alla sua infinita ricerca. Nasce il correlativo retorico o, in termini platonici, lo specularmente simile[10].
Lo scoprirsi conforme all’altro, e il confondere questo con il conoscersi, è generatore di una duplice illusione, giacché è operante da entrambe le parti dello specchio la dissimulazione del darsi di una superficie, perciò produttrice di menzogna: come rinvenire affinità rispetto a noi stessi, nel momento in cui il sé, in-quanto-volere, ma non volere-questo, sfugge a una determinazione? La solitudine e la diversità originaria inverano, così, la fonte paradossale della comunanza: l’essere simili nell’assoluta alterità, l’essere del tutto unici e, in questo, scoprirsi cionondimeno simili, non è se non una situazione ossimorica, che persiste nel negare proprio ciò che vorrebbe affermare. E non c’è affermazione-negativa più dolorosa di quella che si rivela nella relazione, se il rapportarsi è un tendere e tendersi e questo, ancora una volta, è un fuggire e un perdersi[11].
Il correlativo, scaturente dalla pretesa reciproca di individuarsi e, finalmente, stabilizzarsi in una cosa in grado di saziare il proprio intrinseco non trovarsi, incarna, nel vacuo tentativo di fissare una corrispondenza, un dilatarsi spazio-temporale del sé in un’ulteriorità che, appena trovata, saturerà con un veleno mortale la mancanza, che deve restare tale per rappresentarci in modo vero e primitivo. Questo saziarsi, a propria volta - mai completo, ma soltanto lucentezza temporanea di ciò che appare adeguato a sé «nella nebbia indifferente delle cose» -, incatena la fame a dei richiami che infinitamente si rinviano e quasi-soddisfano, fino ad annullare l’avvertimento della deficienza, sostituendola con un movimento «nel giro delle cose che […] fanno piacere» e con una proiezione che conduce al «cerchio senza uscita dell’individualità illusoria», giacché è solo in un quadro finito che si smette di ascoltare quell’oscuro demone interiore il quale, rammentandoci a tratti la nostra indeterminabilità in un correlativo preciso al nostro voler vivere, lancia nuovamente il sé nell’infinito caos dell’assenza di oggetti[12].
Quello della volontà, che invece rinuncia a consumarsi negli oggetti e ritorna in sé, è, come con una bella immagine suggerisce Andrea Bellantone, una sorta di «processo autoimmune», in cui essa, tornata infinita perché indeterminata, recupera il suo essere-volere senza volere-qualcosa, lasciando, così, che «la vita vada da se stessa, […] si viva» e, vivendosi, torni al buco nero da cui ha tratto origine, ritrovando, in un collasso privo di correlazione, la sua più puntuale individualità[13]. La strada della persuasione è, in tal senso, «un cammino che si apre nel deserto e non preesiste a chi lo percorre»: privo di un tracciato preterito o futuro, è, proprio per questo, «risanato dalla malattia del tempo» e «guarito dalla contingenza» e, nel suo costituirsi solo allorché si costituisce, guadagna un’identità a tal punto condensata tautologicamente in se stessa, da non necessitare più di specchi[14].
A questo deserto spoglio di un’eco molti preferiscono il ritorno a casa, per riflettersi nella consueta, consolante certezza della trasmissione genetica del dispositivo sociale.
L’idea di noi stessi come tenebra vuota di corrispondenza resterà, una volta che si sia rientrati nella gabbia che ottunde il dolore sotto l’ammanto rassicurante delle cose, per sempre latente, salvo risvegliarsi, a volte, con la stessa debolezza di un suono lontano, facile a dimenticarsi, non appena l’assordante ritmo a cui siamo stati addestrati ci richiami ai nostri specchi; tutti, infinitamente, repliche dell’immagine che abbiamo costruito di noi; immagine che rincuora; allele dominante approvato dalla maschera autoritaria di una civiltà che reputa ogni trauma inferto al nostro io-schema - perfettamente integrato nel super-allele sociale - un incidente, un pericolo o un sogno.
La genetica e i sistemi correlativi si alimentano in tal senso della ripetizione: essi si cibano della nostra pretesa retorica di rintracciare continue repliche corrispondenti al nostro volere. Ma, finché saremo visibili a noi stessi attraverso un’immagine che risponde a ciò che crediamo soddisfarci, saremo padroni della nostra superficie, ma mai potremo intravedere il fondo da cui proveniamo.
È solo quando il volere resta indeterminato, rinunciando a possedere e a essere posseduto, che il perimetro nel quale è stato ingabbiato il racconto su noi stessi viene deviato e trascinato fuori della prigione autoindotta[15].
[1] Cfr. Plat. Phaed. 74 e sgg.
[2] Cfr. Plat. Phaedr. 251 e sgg.
[3] Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a c. di S. Campailla, Adelphi, Milano 2010, p. 63. Sulla valenza negativa dell’immagine dello specchio in Michelstaedter, cfr. F. Baldassarre, L’“apparato” della retorica, in Carlo Michelstaedter e il Novecento filosofico italiano, a cura di D. Calabrò-R. Faraone, Le Lettere, Firenze 2013, pp. 152-153.
[4] Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., pp. 46-48 e 63-66. Cfr., a proposito di tali questioni, C. Maggi, La scena filosofica. Note su Platone, Schopenhauer, Nietzsche, Michelstaedter, in Platone nel pensiero moderno e contemporaneo, a cura di A. Muni, vol. IX, Limina Mentis, Villasanta 2016, pp. 89-91; R. Motta, La “Rettorica” come tecnica della violenza, in Carlo Michelstaedter e il Novecento filosofico italiano, cit., pp. 131-133.
[5] Cfr. Plat. Leg. 643 b sgg. Sul tema del dominio di sé cfr. anche Resp. IV 430 e sgg. Sulla possibilità di far risalire il tema del conflitto tra desideri contrari alla nota critica, presentata nel Fedone, alla dottrina dell’anima-armonia cfr. H. Lorenz, Plato on the Soul, in The Oxford Handbook of Plato, ed. by G. Fine, Oxford University Press, Oxford-New York 2008, pp. 243-266 e rinvii. Per una contestualizzazione del passo cfr. C. Maggi, Socrate e la piazza. Sull’amore immaginato, «Sinestesie on-line (Supplemento della Rivista Sinestesie)» 2, 2013, pp. 8-10.
[6] Cfr. Plat. Leg. 647 e sgg.
[7] Cfr. Plat. Theaet. 149 e sgg. Sulla vis seduttiva della maieutica e della relazione erotica, che non si può escludere conduca chi ne sia affetto alla rovina, cfr. il cap. 4 di G. Flamigni, Presi per incantamento. Teoria della persuasione socratica, Edizioni ETS, Pisa 2017.
[8] Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., pp. 65-66.
[9] Ibid., p. 40.
[10] Ibid., pp. 39-40. Sul ruolo della volontà nel singolo cfr. Th. Harrison, Carlo Michelstaedter and the Metaphysics of Will, «MLN», 5, 1991, p. 1022. Sulla natura retorica del correlativo cfr. R. Peluso, Postille postumane, in Carlo Michelstaedter e il Novecento filosofico italiano, cit., pp. 97-100. Sulla identificazione tra volontà e soggettività in Michelstaedter e sulla costruzione dell’oggetto come proiezione illusoria del volere cfr. A. Bellantone, Michelstaedter: la forza del pensiero, in Carlo Michelstaedter e il Novecento filosofico italiano, cit., pp. 187-190. Sugli echi (criticamente mutuati) schopenhaueriani cfr. R. Peluso, L’identico e i molteplici. Meditazioni michelstaedteriane, Loffredo, Napoli 2011, pp. 103-105; R. Visone, «Visse tutta una lunga vita a fare professione di pessimismo»: Michelstaedter vs Schopenhauer, Federico II University Press, Napoli 2018.
[11] Cfr. C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., pp. 41-42.
[12] Ibid., p. 47 sgg.
[13] A. Bellantone, Michelstaedter: la forza del pensiero, cit., p. 195 e 197.
[14] R. Peluso, Postille postumane, cit., p. 103 e 106. Sull’immagine del deserto cfr. R. Motta, La “Rettorica” come tecnica della violenza, cit., pp. 144-145.
[15] Sull’idea del dispositivo sociale cfr. R. Motta, La “Rettorica” come tecnica della violenza, cit., pp. 134 e 127-130.