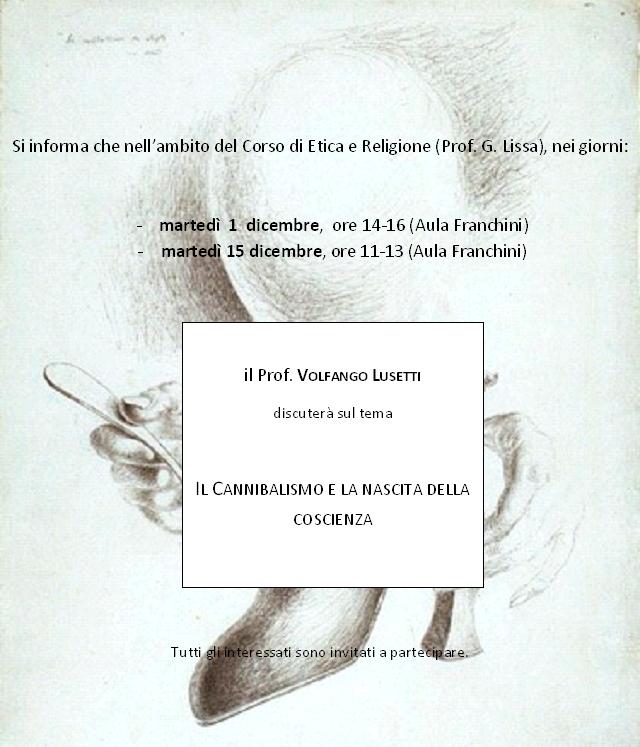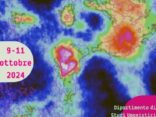Autore
Volfango Lusetti
Reparto psichiatrico Ospedale di Tivoli (Roma)
Psichiatra, è stato Primario del reparto psichiatrico (SPCD) dell’Ospedale di Tivoli (Roma)
Indice
Una nota e un testo di un seminario
- Il problema della coscienza
- L’uomo è l’unico cannibale in natura?
- Il pericolo di estinzione e gli equivalenti cannibalici
- Il collettivo: categoria logica o rinnovata istanza metafisica?
- Per una genealogia della morale
- L’ebraismo e il dio predatore
S&F_n. 02_2009
- Il problema della coscienza
Dove collocare l’origine del linguaggio e dell’autocoscienza? Le peculiari e inedite caratteristiche della specie umana sono il frutto di un miracoloso salto ontologico nella catena dell’essere, o vanno ricercate nella lunga storia di evoluzione e selezione naturale della nostra specie? Se è così quali sono gli eventi, gli accadimenti concreti che hanno condotto l’umano all’utilizzo della parola e all’ininterrotta riflessione circa se stesso? Sono le domande cui tenta di rispondere lo psichiatra Volfango Lusetti nell’ambito del seminario svoltosi a Napoli, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nei giorni 1 e 15 dicembre, sul tema Il cannibalismo e la nascita della coscienza, titolo del testo che l’autore ha pubblicato per Armando Editore nel 2008. La teoria di fondo che Lusetti chiarisce a partire dal primo incontro si basa su un’ipotesi precisa: nel corso di una lunga storia evolutiva, probabilmente a seguito di una catastrofe naturale, i nostri antenati hanno posto in essere pratiche cannibaliche nei confronti dei cuccioli, per sopravvivere alla carenza di cibo. Questo comportamento avrebbe presto determinato l’estinzione della specie, se non fossero intervenute una serie di pratiche antipredatorie, soprattutto a opera delle femmine, volte a ostacolare l’uccisione dei piccoli. La sessualità permanente della femmina è stata la prima moneta di scambio per la sopravvivenza; linguaggio e autocoscienza furono ulteriori strumenti utilizzati come misure difensive: la parola, il suono della voce come potente ipnotico, nenia che incanta, seduce e ammansisce il predatore; l’autocoscienza come struttura di vigilanza, che tiene a freno il cannibale mentre lo interiorizza. L’analisi di Lusetti rimanda inoltre al mito e alla nascita delle religioni monoteistiche, intese come reiterazione incruenta dell’evento cannibalico e sua risoluzione nell’ambito della matrice simbolico-rituale.
Di seguito riportiamo il testo di Volfango Lusetti in merito alle domande e alle obiezioni rivolte dai partecipanti durante il primo incontro.
- L’uomo è l’unico cannibale in natura?
Nell’ambito del primo incontro i partecipanti hanno posto interrogativi circa la presunta rarità in natura, al di fuori della nostra specie, di comportamenti cannibalici in senso stretto (fatta salva la frequente presenza di comportamenti infanticidi dell’animale adulto, specie di sesso maschile, sulla prole, finalizzati a vantaggi di tipo soprattutto genetico), e circa la presunta peculiarità e eccezionalità del cannibalismo umano rispetto a quello animale: mi ero limitato a rispondere che comportamenti cannibalici in senso stretto, in natura, non solo esistono, ma non sono neppure così infrequenti; successivamente però, obbedendo al popperiano “principio di falsificabilità” cui cerco in genere di ispirarmi, sono andato a riguardare la letteratura in proposito e ho trovato numerose conferme di quanto affermavo, ma anche delle importanti limitazioni e precisazioni, le quali rendono la domanda per niente scontata e anzi piuttosto interessante, almeno come spunto di riflessione. Ho trovato numerosi esempi di comportamenti cannibalici fra gli animali, almeno in condizioni di sovraffollamento e di scarsità di risorse, ma alcuni di essi sono decisamente disfunzionali e presentano gravi rischi: David Plennig, zoologo americano che ha effettuato uno studio approfondito sull’argomento, ha studiato un esempio dei rischi connessi al cannibalismo fra le larve di una salamandra, la Ambystoma Tigrium, i cui girini, una volta divenuti cannibali, presentano un tasso di mortalità più elevato degli altri a causa della virulentazione di alcuni germi che in condizioni ordinarie convivono con questa specie, ma che in condizioni non ordinarie (ad es. se ingeriti), divengono molto più pericolosi del solito.
L’epidemia di “kuru”, ossia di una forma di encefalopatia spongiforme da “prioni” (proteine replicabili) che afflisse, fra il 1920 e il 1960, la popolazione cannibale dei Fore in Papua Nuova Guinea, costituisce un secondo esempio del meccanismo potenzialmente tossico del cannibalismo, ma è anche un indizio potente di una sua misteriosa universalità e utilità: questa popolazione secondo studi antropologici universalmente accreditati, aveva inaugurato, a partire dalla metà del secolo diciannovesimo, una forma di cannibalismo rituale che consisteva nell’abitudine di divorare il cervello dei defunti in banchetti funebri: in particolare, agli uomini adulti era riservato il cervello, alle donne e ai bambini altre parti del cadavere. Durante l’epidemia di kuru si riscontrarono alcune centinaia di morti: a un certo punto l’epidemia (pur essendo rimaste invariate le usanze cannibaliche dei Fore), si affievolì misteriosamente scomparendo di colpo nella metà del Novecento, e in particolare nei nati dopo il 1950. Il fenomeno è stato studiato da vari punti di vista; per quanto riguarda l’eziologia e la patogenesi della malattia, D. Carleton Gajdusek e Vincent Zigas hanno stabilito il suo indubitabile nesso con il cannibalismo: essi infatti hanno notato che l’abitudine rituale dei Fore di onorare i propri defunti mangiandone il cervello, faceva sì che un agente infettivo proteico detto “prione”, ove fosse stato introdotto per ingestione da parte della stessa specie che lo ospitava, tendeva a “virulentarsi”, divenendo mortale e dando luogo a una forma encefalopatica; ciò avveniva per un motivo ben noto ai neuro-scienziati: il tessuto nervoso è il meno capace di auto-replicarsi, almeno in età adulta, ma l’ingestione di tessuto nervoso in misura massiccia aumentava la probabilità che si manifestasse un processo di auto-replicazione di quelle proteine maggiormente in grado di farlo, innescando un meccanismo a catena che il sistema nervoso, date le sue caratteristiche “statiche” e non portate allo sviluppo ulteriore in età adulta, non era affatto in grado di controllare; ora questo meccanismo, nel caso del kuru, conduceva all’addensamento delle proteine che si erano prodotte in numero anomalo per auto-replicazione incontrollata (le quali in condizioni ordinarie si collocano, in minor numero e ordinatamente, alla superficie dei neuroni), nella profondità dei neuroni stessi, fino a formarvi delle cavità che conferivano al tessuto nervoso un aspetto spugnoso (donde il nome di “encefalopatia spongiforme”). Il processo portava alla fine a incoordinazione motoria, ad atassia, e alla demenza. Un altro ricercatore, Simon Mead, ha studiato lo stesso fenomeno da un punto di vista completamente diverso, concentrandosi sull’aspetto genetico, e in particolare sui motivi dell’acquisita immunità dei Fore nei confronti dei prioni dal 1950 in poi; ha perciò deciso di studiare il patrimonio genetico di questa popolazione, e ha individuato, nei soggetti divenuti immuni, un gene protettivo rispetto alla malattia da prioni: si trattava di un gene assente negli altri membri di quella popolazione, quindi evidentemente insorto dopo il 1950. Lo studio di Simon Mead ha proseguito su diversi campioni della popolazione mondiale, scoprendo che un gene protettivo molto simile, anche se non esattamente uguale a quello insorto nei Fore, era presente a livello universale, ossia praticamente in tutti i ceppi della popolazione umana mondiale che gli era stato possibile esaminare (e che provenivano da tutti e cinque i continenti). Infine, con studi ancora più approfonditi e inerenti la frequenza di variazione spontanea di tale gene nelle varie popolazioni, lo studioso ha concluso che esso sembrava essersi stabilizzato nel nostro genoma almeno cinquecentomila anni fa. Tutto ciò suggerisce l’ipotesi che il cannibalismo sia stato anticamente una pratica universale fra gli umani. Un tipo molto simile di malattia da prioni, del resto, ha preso recentemente a diffondersi in Europa, dapprima fra le mucche d’allevamento e poi nell’uomo, sotto forma di “morbo della mucca pazza”: per la precisione, ciò è avvenuto alcuni anni fa a partire dalla Gran Bretagna, a seguito dell’abitudine degli allevatori inglesi di dar da mangiare alle mucche (animali notoriamente erbivori) un pastone proteico d’origine animale, definibile in senso tecnico come “cannibalico”, perché formato, fra le altre cose, dai residui delle carcasse di altre mucche. L’ingestione di questi residui proteici appartenenti alla propria stessa specie aveva dato luogo alla virulentazione di quelle particolari proteine auto-replicantesi dette “prioni”, che erano ordinariamente presenti in forma relativamente pacifica nel loro organismo, ma che si erano successivamente rivelate in grado di trasmettersi anche all’uomo in forma virulenta. Tuttavia, anche la diffusione del “morbo della mucca pazza” (detta anche “malattia da prioni”), pur essendo stata assolutamente imponente fra le mucche (più di trecentomila capi, fra quelli morti spontaneamente e quelli abbattuti nella sola Inghilterra), nella popolazione mondiale umana è stata molto più limitata di quanto si temesse, malgrado l’alto allarme iniziale: insomma, essa si è comportata esattamente come il kuru in Nuova Guinea. Tutto ciò dimostra che esistono nella nostra specie dei precisi fattori di protezione dal cannibalismo e dalle patologie da esso indotte: fattori di protezione che la nostra specie, più di altre, sembra essere stata costretta ad acquisire, pur di poter continuare le pratiche cannibaliche che evidentemente mostravano una qualche utilità, anche se la natura di tale utilità risulta in prima istanza misteriosa; l’ipotesi, ad esempio, che l’evoluzione umana sia stata innescata specificamente dalla pratica di mangiare il cervello delle vittime (poiché esso poteva contribuire alla nutrizione del cervello del divoratore), oltre a essere assai riduttiva, ci sembra contrastare con un elementare postulato darwiniano: quello che un eventuale “vantaggio alimentare specifico” che risulti tale per l’individuo (ad esempio un miglioramento della sua dieta), non può tradursi in un analogo vantaggio per la sua discendenza, poiché una tale “spiegazione” rientrerebbe in uno schema di ragionamento assai più lamarckiano che darwiniano: l’uso e non uso di un organo, infatti, non si trasmette alla linea seminale, ovvero al genoma, dato che Weissmann ha da molto tempo dimostrato l’impossibilità del passaggio di una variazione fisica individuale che non riguardi il genoma (come ad esempio la miglior nutrizione del cervello, o di altri organi) dalla linea somatica a quella sessuale (la quale è l’unica abilitata a produrre “mutazioni genetiche” di per sé trasmissibili alla progenie). Perciò, nell’indagare sui possibili motivi (a parte l’ovvio ma occasionale miglioramento della dieta in caso di penuria “catastrofica” di risorse, oppure l’occasionale concorrenza genetica) di quella misteriosa e persistente “utilità” del cannibalismo che sembra avere indotto la nostra specie a immunizzarsi stabilmente contro le sue conseguenze negative al fine di potere continuare a praticarlo, non si può fare a meno di andare nella direzione da me indicata (almeno se si vuole rimanere su un terreno darwiniano): solo se il cannibalismo ha creato un ambiente umano altamente e durevolmente selettivo per l’uomo stesso e per la sua intelligenza, esso può avere costituito un vantaggio di lungo periodo per la nostra specie. Tornando ora, per un momento, agli animali, esistono numerosi altri esempi, oltre a quello della Salamandra studiata da Plennig, di comportamenti che non sono soltanto “infanticidi”, ma cannibalici in senso stretto. I comportamenti cannibalici sono abbastanza frequenti in natura, malgrado le limitazioni postevi dalla natura stessa: atti di cannibalismo si osservano nei felini (ad es. fra i leoni, che non solo uccidono, ma mangiano i cuccioli di un altro maschio, sia al fine di fare spazio ai propri geni, sia allo scopo di nutrirsi, e anche al fine di rendere la femmina disponibile al coito “mandandola in calore” proprio attraverso l’eliminazione dei suoi piccoli, come è stato descritto da etologi quali Giorgio Celli); si osservano fra gli uccelli (vedi l’osservazione di Ivo Tiberio Ginevra su coppie di passeri del Giappone che in cattività divorano i propri piccoli malformati); si osservano fra i criceti, o vari roditori di sesso femminile, i quali uccidono e mangiano i loro piccoli ove questi siano stati concepiti in situazioni di stress (ne parla il farmacologo Giorgio Racagni, direttore del Centro di neuro-farmacologia dell’Università di Milano); si osservano fra gli insetti (come nel caso delle api, che in caso di scarsità del polline uccidono le larve più giovani per utilizzare le loro proteine a vantaggio delle larve più vecchie, oppure l’esempio della mantide religiosa che divora il partner tagliandogli la testa e recidendogli le vie nervose che ne inibiscono la sessualità); si osservano in alcuni ragni femmina, che divorano il maschio subito dopo la fecondazione; si osservano fra i vermi (vedi il caso del comune baco della mela, che se incontra un “concorrente” nello stesso frutto, lo divora). Occorre poi osservare che tutti questi casi di cannibalismo, al contrario di quanto avviene nei girini della salamandra studiati da Plennig, o nel caso del kuru umano, non sembrano accompagnarsi a particolari svantaggi, pericoli o malattie: però occorre anche precisare che essi sono comunque causati da circostanze di emergenza, quali il sovraffollamento e la scarsità di risorse, e questa limitazione è dovuta all’ovvio motivo evoluzionistico che una specie che divora di preferenza se stessa, con il tempo tende fatalmente a estinguersi. Insomma, anche se a disincentivare il cannibalismo non intervengono malattie, è sufficiente l’auto-protezione delle specie, il loro dover puntare sulla predazione delle altre specie e sull’auto-riproduzione, più che sull’auto-predazione, a costituire un potente disincentivo verso una pratica che di per sé non avrebbe, in natura, nulla di eccezionale (o tanto meno di “simbolico”, quindi di riservato alla specie umana).
Il cannibalismo, in definitiva, è frequentemente osservabile fra gli animali e può essere collegato sia alla concorrenza riproduttiva (mangiare i cuccioli per ragioni di concorrenza genetica con i rivali), sia al sovraffollamento e alle ragioni alimentari legate alla penuria di risorse; però esso appare come qualcosa che, se da un lato si produce spontaneamente e abbastanza di frequente (data la sua semplicità e la sua relativa economicità rispetto alle più impegnative forme di predazione extraspecifica), dall’altro viene frenato nel suo sviluppo da numerosi fattori, perciò alla fine si afferma solo in circostanze di emergenza.
Perciò, pur essendo vero che il cannibalismo in natura è abbastanza frequente, è anche vero che il cannibalismo umano ha qualcosa di speciale che gli ha consentito di divenire un fatto abituale e sistematico (malgrado la sua origine probabilmente eccezionale e “catastrofica”); solo l’uomo ha avuto la capacità di aggirare sistematicamente i limiti che la natura ha dovuto porre per gli altri animali, al naturale dilagare della sua pratica: e ha aggirato questi limiti, ad esempio, immunizzandosi nei confronti delle malattie collegate al cannibalismo, come abbiamo visto nel caso della “malattia da prioni”. Detto questo, si deve però anche escludere che il cannibalismo sia presente solo nell’uomo, o ancor più che esso sia nato in lui già pre-formato come pratica simbolico-rituale, dato che, come si è detto, il fenomeno è presente nell’insieme del mondo animale: lo è, per fare un ulteriore e ultimo esempio, nelle forme di vita più elementare, come dimostrano gli studi di Jean Paul Ameisen e altri autori sulla cosiddetta apoptosi, o “Morte Cellulare Programmata”, che è presente non solo nell’economia degli organismi complessi (si vedano i tumori, che derivano proprio da un’alterazione dell’apoptosi), ma anche in popolazioni assai primitive di unicellulari. L’uomo, peraltro, ha superato i limiti biologici intrinseci connessi con il cannibalismo e legati al pericolo d’auto-estinzione, non solo auto-immunizzandosi, come abbiamo visto, dalle sue “complicazioni” più pericolose (ad es. quelle d’ordine infettivo), ma soprattutto ritualizzandolo, ossia trasformandolo in una serie di suoi equivalenti, che posseggono un carattere ugualmente predatorio, ma meno cruento, e sono molto più frequenti e abituali del cannibalismo in quanto tale. Questi “equivalenti cannibalici”, di tipo dapprima biologico, poi rituale e infine simbolico, sono essenzialmente quelli che ho tentato di analizzare nel mio libro: essi sono serviti a evitare che la nostra specie, in virtù dell’attitudine predatoria che l’ha afflitta in maggior misura rispetto alle altre, potesse gradualmente estinguersi per puro e semplice “auto-divoramento”.
- Il pericolo di estinzione e gli equivalenti cannibalici
Gli equivalenti cannabilici tesi a evitare la predazione dei cuccioli da parte del maschio e dunque l’estinzione della specie sono: la sessualità perenne, tendenzialmente perversa, quindi predatoria come il cannibalismo, ma capace di neutralizzarlo con il “piacere” sessuale), e un’intelligenza basata sul linguaggio simbolico (ugualmente predatoria, perché adatta a influenzare e ad asservire in mille modi i propri simili). Sessualità perenne e intelligenza simbolica appaiono due strumenti di relazione intra-specifica di carattere predatorio, tali da rendere i membri della nostra specie perfettamente idonei a servirsi degli altri alla stregua di strumenti, e anche a selezionarli, senza però distruggerli “in toto”. Sessualità perenne e intelligenza simbolica consentono a ciascun individuo di servirsi degli altri come principale risorsa per la propria sopravvivenza: ciò, da un lato attraverso lo strumento della mescolanza sessuale con l’altro e dell’identificazione di tipo linguistico-simbolico con lui, dall’altro attraverso l’eliminazione più o meno spietata di chi non è in grado di rapportarsi con gli altri membri della propria specie in questo modo. Sessualità perenne e intelligenza simbolica, dunque, nell’indurre una vera e propria mescolanza biologica, nonché un interscambio intensivo di tipo cognitivo e a carattere influenzante fra membri di una stessa specie, sembrano essere a tutti gli effetti degli equivalenti para-rituali del cannibalismo. Ma essendo per loro stessa natura affini al cannibalismo, sessualità perenne e intelligenza simbolica, se per un verso contrastano il cannibalismo, neutralizzandolo, per l’altro lo incorporano, lo agiscono in prima persona e in definitiva lo sostituiscono. Ancora, sessualità perenne e intelligenza simbolica neutralizzano e allo stesso tempo veicolano il cannibalismo istituendo (analogamente alla socialità, da cui in definitiva derivano), un meccanismo a circuito con esso, attraverso il quale sono spinte a differenziarsi in infinite forme e derivati simbolico-rituali, quindi si auto-implementano sempre di più: in tal modo questi due strumenti garantiscono, alla specie che li adotta, di poter continuare a considerare i propri simili come una risorsa, fruendone appieno senza distruggerli, ma soprattutto, senza auto-distruggersi.
In conclusione, la predazione cannibalica intra-specifica sembra essere un atto in genere molto pericoloso per la specie che lo compia e tuttavia foriero di spettacolari sviluppi evolutivi e simbolici, ove l’ostacolo di una siffatta pericolosità venga in qualunque modo aggirato e superato: ciò al punto che l’uomo, per potere continuare a compierlo, ha addirittura dovuto acquisire una mutazione genetica che lo proteggeva dalla malattia da prioni.
In particolare, la predazione spinge la socialità e la sessualità a evolversi. Per quanto riguarda la socialità, essa è spinta a evolversi nei suoi derivati linguistici e intellettuali, che servono soprattutto alla comunicazione collettiva e di gruppo (occorre ricordare, a tale proposito, che la socialità, a sua volta, è un derivato della primordiale riproduzione di se stessi in forma invariata, ovvero della mitosi, che è una ripetizione infinita dell’uguale, nell’ambito di un collettivo di specie più o meno omogeneo e intercomunicante, difesa, questa, che come si è detto è stata forse la prima risposta della vita nei confronti della morte). Per quanto riguarda la sessualità, essa è una specie di ponte, di mediazione fra la socialità e la predazione; se ricordiamo che la socialità rappresenta la difesa primaria della vita contro la morte, e che consiste nel numero come arma vincente e nella riproduzione infinita e senza variazioni di se stessi, mentre la predazione rappresenta la seconda risorsa a disposizione della vita nella sua lotta contro la morte, ed è essenzialmente fruizione dell’altro, possiamo vedere facilmente come la sessualità, nella sua struttura meiotica, non sia altro che una combinazione di queste due primordiali armi di lotta: essa mette insieme la riproduzione con l’appropriazione predatoria dell’altro, senza però giungere a risultati distruttivi per l’individualità; perciò si presta in maniera eccellente a combinare fra loro e a “mettere in circuito” socialità, mitosi, numero e ripetizione infinita dell’uguale, da un lato, e predazione, incorporazione dell’altro, alterazione e potenziale distruzione di esso, dall’altro. Tirando le somme, occorre osservare che un insieme così imponente e insolito di fattori auto-selettivi – la predazione, in special modo cannibalica, la socialità con i suoi derivati linguistico-simbolici e infine la sessualità, specie nei suoi aspetti perenni – è destinato a produrre un ambiente altamente selettivo, ambiente che a un certo punto prende il posto, fatalmente e in gran parte, dell’ambiente naturale. Insomma, l’elemento predatorio e persecutorio di tipo cannibalico, nel divenire “fattore selettivo intraspecifico”, si presta perfettamente a potenziare la potente ed efficacissima linea auto-selettiva e auto-evolutiva che fu a suo tempo inaugurata, in campo biologico, dalla sessualità; una linea che è proseguita con lo sviluppo spettacolare del sistema nervoso un po’ in tutti gli animali sessuati (sviluppo basato, come ha dimostrato Robin Dunbar, sullo scambio intensivo con l’ambiente sociale inteso come “fattore di corticalizzazione”). Il cannibalismo in definitiva funge, tanto per la sessualità come per lo sviluppo dell’intelligenza, da fattore di implementazione, anzi da vero e proprio “motore”: esso spinge in avanti, verso un’ulteriore evoluzione, questi due potenti strumenti di lotta per la vita, esaltandone gli aspetti selettivi e sospingendoli alla massima potenza. Il cannibalismo spinge inoltre l’intelligenza a divenire un sistema di monitoraggio dei pericoli ambientali di ordine persecutorio, sempre più interattivo e sensibile, e alla fine a “volgersi su se stessa”, ancora una volta trattando se stessa alla stregua di una risorsa, come avviene con l’auto-coscienza riflettente. Sembra essere proprio questo, peraltro, il meccanismo che ha indotto la sessualità, nella nostra specie, a divenire qualcosa di perenne, e l’intelligenza qualcosa di sempre più astratto e generalizzabile a ogni situazione nuova, ossia di auto-cosciente e di reversibile dalla preda al predatore e viceversa, insomma di simbolico. Abbiamo a che fare, sia nel caso del cannibalismo, sia in quello della sessualità e dell’intelligenza simbolica, con una linea evolutiva unica, che porta comunque una specie a volgersi verso se stessa come a una risorsa e ad auto-selezionarsi, ovvero a mescolarsi profondamente con se stessa e allo stesso tempo ad attrezzare delle difese contro se stessa, nonché delle molteplici forme di sofisticata auto-percezione e auto-monitoraggio: in altre parole, il cannibalismo, tendenzialmente, spinge ogni specie a essere allo stesso tempo nutriente e tossica per se stessa, quindi perennemente disponibile, ma anche perennemente vigile e iperpercettiva nei confronti della propria stessa natura. Quest’attitudine auto-predatoria primaria dell’uomo, veicolata e potenziata dapprima dalla sessualità e poi dall’intelligenza simbolica (e tale da potenziarle a sua volta), può dunque essere stata la base evolutiva, ossia il vero e proprio “motore dinamico”, sia dello sviluppo della coscienza sia di quello dell’auto-coscienza riflettente (viste nel loro duplice significato di “vigilanza esterna”, di ordine cognitivo, e di vigilanza interna, fatta essenzialmente di “coscienza morale” e di sacrificio “per gli altri”).
L’attitudine auto-predatoria di tipo cannibalico, infine, può avere prodotto i suoi effetti evolutivi maggiori proprio nell’uomo, e non in altri animali ugualmente soggetti al cannibalismo, per un concorso abbastanza casuale di circostanze: i nostri progenitori, probabilmente, oltre a essere sin dall’inizio eccezionalmente dotati di attitudini predatorie, erano dei soggetti molto inclini alla pratica della sessualità, e avevano inoltre un’ottima intelligenza di tipo strumentale e sociale; insomma possedevano già in misura cospicua tutte e tre le linee evolutive (predazione cannibalica, sessualità, socialità-intelligenza) che secondo la nostra ipotesi possono spingere una qualsivoglia specie ad auto-selezionarsi in forma intensiva. Ora, proprio questa compensazione sessuale e linguistica della predazione, esercitata da caratteristiche che erano a loro volta auto-selettive e tendenzialmente predatorie (quali la sessualità e l’intelligenza) ha consentito all’uomo di incorporare in forma stabile, in tutte le proprie armi auto-selettive (e quindi di conservare e di perpetuare, sia pure in forma diversa e meno distruttiva), proprio quei pericolosissimi comportamenti cannibalico-predatori “primari” che erano interdetti, almeno nella loro forma più generalizzata, a tutte le altre specie, e che però erano i soli a potere assicurare a ogni specie un tragitto evolutivo sufficientemente continuativo e intensivo. Questi aspetti predatorio-cannibalici, dunque, in quanto elementi “catastrofici” interni e permanenti, sono divenuti degli altrettanto permanenti “motori evolutivi” per la specie che li ha saputi far propri.
- Il collettivo: categoria logica o rinnovata istanza metafisica?
Una seconda precisazione risulta necessaria in merito all’uso del concetto di collettivo: nel corso del primo incontro si è messo in evidenza l’ambiguità intrinseca all’utilizzo del termine collettivo, che sembrerebbe rimandare a una matrice metafisica. Il collettivo in effetti non deve essere inteso come un soggetto “reale”, né in filosofia (se la filosofia vuole mantenersi su un terreno non spiritualistico) né in biologia (se la biologia vuole muoversi in un’ottica darwiniana): infatti l’attribuzione di “realtà” a una categoria logica di ordine generale sarebbe metafisica. Detto in un altro modo non esiste mai, né può esistere, un “soggetto collettivo”, per il semplice motivo che solo l’individuo ha un corpo, ed è dunque un soggetto biologico reale che reagisce alle stimolazioni e si evolve sulla base di esse; ciò contrariamente all’idea di inconscio collettivo simbolico e archetipico che ci fornisce Gustav Jung, che sconfina palesemente in una visione religiosa della realtà. Parimenti non può sussistere, in quanto “soggetto” di evoluzione, neppure un ipotetico “collettivo biologico”, perché anch’esso rientrerebbe, malgrado tutto, in un modo di argomentare metafisico. Questa limitazione al solo individuo della possibilità biologica di lottare per la sopravvivenza, peraltro, corrisponde pienamente al concetto di evoluzione di Charles Darwin, il quale, come è noto, riservava al solo individuo la possibilità di produrre “variazioni” utili a essere selezionate dall’ambiente e a produrre evoluzione, e ne escludeva il gruppo. Debbo però precisare che, almeno nel mio caso, l’uso del termine “collettivo” è solo metaforico e non di sostanza, poiché non considero affatto il collettivo come un soggetto più o meno intenzionale, bensì semplicemente come un fattore selettivo esterno all’individuo, in sé e per sé a-finalistico e “cieco”, quindi in linea di principio perfettamente assimilabile all’ambiente naturale. La novità della mia impostazione, rispetto a quella darwiniana, sta nel sottolineare che l’ “ambiente naturale selettivo”, nel caso dell’uomo, presenta qualcosa di assai particolare: si tratta infatti, innanzi tutto, di un ambiente fatto di esseri viventi, e in secondo luogo composto da viventi che appartengono alla nostra stessa specie. Insomma per la nostra specie il principale ambiente selettivo è il collettivo umano: è proprio il gruppo umano, infatti, il particolarissimo “ambiente naturale” che, più di ogni altro fattore, ha selezionato e seleziona tuttora la nostra natura (come ha giustamente intuito Robin Dunbar, con il suo concetto di “fattore sociale di corticalizzazione”). La differenza fra un semplice “ambiente naturale” e un ambiente naturale costituito da viventi, e in particolare da propri simili, è di non poco conto, e risiede nel carattere molto più interattivo con l’oggetto da selezionare. Andando ancora più a fondo, per ciascun essere vivente la particolarità di un ambiente naturale costituito da esseri viventi appartenenti alla sua stessa specie è per definizione rappresentata dal fatto che un tale ambiente è un gruppo; però il gruppo, in quanto tale, è necessariamente composto da individui che in virtù della loro natura omo-specifica interagiscono continuamente e intensivamente fra di loro, quindi anche con l’individuo che costituisce l’oggetto della selezione: ma ciò fa sì che il gruppo (a differenza dell’ambiente naturale puro e semplice) spinga ciascun membro a un’evoluzione “direzionata” e modellata su se stesso e sulle proprie esigenze, quindi, almeno all’apparenza, finalizzata e “intelligente”. La nostra specie perciò è stata caratterizzata probabilmente da un’evoluzione molto rapida, basata su un meccanismo a feed back, imperniato sulle due principali caratteristiche dell’essere umano: la sessualità perenne e il linguaggio simbolico. Se si considerano le proprietà fortemente interattive sia della sessualità che del linguaggio, deve essersi trattato di un’evoluzione che si è mossa in una direzione omologa all’interesse della maggioranza dei membri del gruppo (o meglio, della sua èlite), e questi l’hanno determinata con la propria particolarissima “pressione ambientale”, volta essenzialmente alla ricerca della propria sopravvivenza (e con essa, della sopravvivenza dell’intero gruppo). Occorre dire, a questo proposito, che se il gruppo selettivo di per sé non possiede una propria autonoma intelligenza, un’intenzionalità e una volontà di sopravvivenza, ciò nondimeno intelligenza, volontà di sopravvivenza e intenzionalità la possiedono certamente gli individui che lo compongono: ma questa è appunto la principale differenza (in sé assolutamente innegabile) fra l’ambiente “naturale” rappresentato da un gruppo umano e un ambiente “naturale” di qualunque altro tipo. Come le ricerche di Jean Claude Ameisen sull’apoptosi cellulare tendono a mostrare, l’interazione fra membri di uno stesso gruppo, anche se molto primitivi (come gli unicellulari da lui studiati), sviluppano in alcuni membri del gruppo stesso la capacità di inviare agli altri dei segnali di “Morte Cellulare Programmata”, ovvero di ucciderli tramite l’innesco in loro di un meccanismo di auto-distruzione programmata: ciò sia per ridurre la popolazione e aumentare le risorse a disposizione degli altri, sia per cibarsene direttamente. In questa situazione di individualità così elementari tuttavia, la lotta per la vita, pur essendo qualcosa che continua ad appartenere interamente all’individuo, transita così rapidamente verso altri individui e torna così rapidamente da questi ultimi all’individuo stesso, da rendere l’interesse del gruppo un comportamento completamente automatico che si insinua nel funzionamento dell’individuo, e alla fine, almeno a certi livelli, ne prende il comando. Insomma, si tratta di un meccanismo talmente potente da prevalere sull’interesse dell’individuo alla sopravvivenza, per il semplice motivo che il patrimonio genetico di un individuo appartenente a una specie molto effimera, passa ad altri individui e sopravvive tanto più facilmente quanto più quell’individuo mostra una plasticità così spinta da indurlo a sacrificarsi, almeno parzialmente, per il gruppo. Questo significa che esiste un vero e proprio “soggetto collettivo” che conduce in proprio la battaglia per la vita? A me non pare proprio: anche il più primordiale meccanismo di difesa della vita, quello basato sul numero, sulla mitosi, sull’infinita riproduzione dell’uguale e sull’espulsione-escrezione di ciò che è nocivo (precursori, questi, di ciò che chiamo socialità), appartiene totalmente all’individuo: tale meccanismo, però, ha la caratteristica di prendersi cura in via prioritaria delle probabilità che l’individuo possiede di trasmettere il proprio patrimonio genetico alla propria progenie, o semplicemente alla posterità (e ciò, anche a scapito dell’individuo stesso). Questa modalità “mitotica”, riproduttiva, è basata in prima istanza sull’infinita replicazione dell’uguale, che possiamo indifferentemente definire come “collettiva” oppure come “sociale” (io preferisco il termine “sociale”, perché fa riferimento a un preciso e differenziato istinto, e non dà luogo a equivoci circa una presunta “intenzionalità, o a una “soggettività collettiva”, concetti che possono farci scivolare nella metafisica); essa svolge dunque la propria lotta per la sopravvivenza essenzialmente attraverso la riproduzione, ossia attraverso la contrapposizione alla morte, del numero dei membri di cui una specie o un gruppo possono disporre, e che possono fare da vettori al patrimonio genetico di un dato individuo, consentendogli di trasmettersi alla progenie. La modalità mitotica e collettiva, o riproduttivo-escretoria, però, già nell’apoptosi studiata da Ameisen, è affiancata, nell’individuo, da un secondo tipo di comportamento che la bilancia e che è di carattere più marcatamente individuale, poiché punta sulla sopravvivenza dell’individuo anziché sulla sua riproduzione-escrezione di tipo mitotico e a vantaggio della specie: si tratta di quello che io chiamo “comportamento predatorio”, che in alcuni casi giunge a essere cannibalico e si basa, anziché sulla riproduzione, sul nutrirsi dell’altro. “Socialità” e “predazione”, riproduzione-escrezione (o riproduzione infinita dell’uguale) e cannibalismo, mitosi (o uso di se stessi) e uso dell’altro, sembrano insomma le due principali e più antiche armi di lotta contro la morte che la vita possegga: esse dirigono l’individuo, alternativamente, contro se stesso (come fa la mitosi, che conduce al sacrificio di se stessi per riprodursi), oppure contro gli altri membri del mondo vivente, o ancora contro i membri del proprio stesso gruppo (come fanno, rispettivamente, la predazione e quella particolare “predazione interna alla specie” che è il cannibalismo). E’ proprio quest’aspetto interattivo basato sull’alternanza fra riproduzione-escrezione, o in senso lato socialità (che spinge l’individuo a volgersi contro se stesso a usare se stesso e a sacrificarsi a vantaggio della propria riproduzione), e predazione nei confronti degli altri viventi (che lo spinge a volgersi contro altri esseri, talora della propria stessa specie, al fine di sopravvivere individualmente), ossia sull’alternanza intensiva e a circuito fra i due più potenti strumenti di lotta contro la morte che la vita abbia inventato, l’elemento che caratterizza l’ambiente “naturale” in cui si muove l’essere umano, e che più d’ogni altro lo ha selezionato così com’è: infatti questa modalità interattiva, nell’uomo, è intercorsa fra derivati altamente differenziati, e in alcuni casi rituali e metaforici, della predazione e della mitosi (o riproduzione-escrezione), quali sono, rispettivamente, il cannibalismo (specie nei suoi aspetti più ritualizzati) e la socialità (specie nei suoi aspetti comunicativi e riferibili alla coscienza e al linguaggio simbolico); la sessualità, poi, specie nella sua forma di sessualità perenne, ha più che altro consentito di “mettere in circuito”, ossia di modulare reciprocamente a seconda delle circostanze, queste due armi di lotta per la vita più antiche, fondamentali e “di base”, che sono appunto la mitosi e la predazione, l’auto-sacrificio per la riproduzione e il sacrificio dell’altro per la propria sopravvivenza individuale. Tale “circuito”, a sua volta, ha consentito alla nostra specie di rendere molto più rapida tutta la sua evoluzione: infatti attraverso un’interazione sociale di carattere predatorio (di per sé molto più rapida, violenta e intensiva di qualunque altra) le caratteristiche, o “variazioni”, che in termini darwiniani vengono prodotte dall’individuo, potendo configurarsi alternativamente sempre in due soli modi fondamentali, ossia come predazione (la quale è veicolata principalmente dall’individuo) oppure come socialità (la quale è veicolata principalmente dal gruppo), sono state rapidissimamente selezionate dal gruppo stesso e sono perciò ritornate all’individuo: ciò, o sotto forma di premio (la sopravvivenza), oppure di punizione (l’estinzione). Ora, come si può intuire, nell’ambito di questo vorticoso circuito (che all’apparenza intercorre fra individuo e gruppo, ma nella realtà è fra ciascun individuo e gli altri individui che compongono il gruppo), ogni individuo che non ha risposto alle caratteristiche richieste dal particolare “ambiente naturale” che il gruppo a lui circostante rappresentava (specie se si trattava di un gruppo cannibalico), è stato eliminato in tempi molto più rapidi che non in altre circostanze, e anche in modi molto più “mirati” di quanto non sia mai potuto avvenire nel contesto di un qualunque altro “ambiente naturale”. Questa “selezione di gruppo” su base cannibalico-predatoria, poi, è avvenuta essenzialmente all’interno della stessa “linea evolutiva”, ossia avvalendosi di strumenti sostanzialmente omogenei fra loro, poiché le armi che la specie ha elaborato e affinato per combattere e allo stesso tempo utilizzare la predazione cannibalica (ossia la sessualità perenne e il linguaggio simbolico), condividono con il cannibalismo la caratteristica di essere capaci di incorporare l’altro all’interno di sé, nonché di utilizzarlo. Difatti queste due armi antipredatorie per eccellenza (sessualità e linguaggio), proprio perché già in partenza accomunate al cannibalismo dalla proprietà di sapere utilizzare l’altro da sé, hanno potuto operare, entrambe, incorporando la predazione cannibalica e sostituendovisi, ovvero agendola a propria volta in forma diversa. Ma la selezione di gruppo può anche avvenire attraverso la valorizzazione della socialità, delle capacità comunicative e della sessualità che sono proprie di un dato individuo (oppure attraverso la sua eliminazione, qualora questi non possegga queste attitudini in misura sufficiente, ad es. se è carente di una sufficiente dotazione comunicativa e linguistica). Insomma, mentre il rapporto fra la specie e l’ambiente naturale “non umano” è tendenzialmente asimmetrico e scarso di “feed back”, ciò non vale fra individuo e individuo: fra queste due istanze, infatti, si stabilisce un rapporto a circuito di tipo interattivo, quindi più o meno simmetrico, nel quale le “proposte” dell’individuo (ad esempio di natura predatoria) generano “risposte” da parte di altri individui (ad esempio di natura sessuale, o linguistica, o sociale), e queste “risposte” fanno proprie le “proposte” stesse, le neutralizzano nei loro aspetti più cruenti e le ripropongono in forma parzialmente modificata, oppure le eliminano quando sono troppo rigide e impossibili da modificare. Insomma, quando è un gruppo di “pari” a svolgere la funzione di ambiente selettivo, si crea una sorta di dialogo fra l’individuo oggetto di selezione e il gruppo stesso (o meglio, gli individui che nel gruppo svolgono un ruolo selettivo, quali ad es. i genitori, o i capi): a questo punto però, nell’ambito di tale “dialogo”, i due ordini di “risposta”, essendo già in partenza simili, non solo si selezionano a vicenda (anche per via genetica), ma mutuano ciascuno le caratteristiche dell’altro, evolvendo rapidamente in qualcosa di sempre più funzionale alla vita del gruppo stesso. Il “circuito selettivo” che ipotizziamo, tuttavia, a un certo punto dell’evoluzione della specie, proprio in virtù del suo carattere fortemente comunicativo e interattivo, è fatalmente fuoriuscito dalla dimensione della pura “diffusione genetica” fra le generazioni e ha preso a interiorizzarsi, ossia a strutturarsi nella mente individuale, sotto forma di un circuito mentale fatto di persecuzione e di antipersecuzione: ciò è avvenuto semplicemente perché l’alternarsi vorticoso, nella lotta contro la morte, dell’utilizzazione di se stessi e degli altri, ha indotto l’individuo a mescolarsi con gli altri e a interiorizzarli, quindi a potenziare in maniera esponenziale ciascuna delle due modalità per mezzo dell’altra. Si è strutturato a questo punto, nell’interiorità di ciascun soggetto individuale, una sorta di carosello persecutorio i cui termini, o polarità, erano la predazione e la socialità, e nel quale ognuna di tali polarità giocava alternativamente la parte della persecuzione predatoria oppure della risposta socializzante (linguistica o sessuale che essa sia): in tale carosello persecutorio l’individuo può giocare la parte del predatore, ad esempio di tipo delinquenziale, caratteriale o “eroico”, oppure quella dell’oggetto della predazione altrui, che deve rispondere alla predazione stessa in termini sessuali o socializzanti (tramite quella che io chiamo “predazione socializzata”); analogamente il gruppo, o collettivo, può giocarvi la parte dell’oggetto della predazione (come avviene nelle forme di martirio) oppure quella del predatore, come avviene in alcune religioni a carattere cruento (tramite ciò che chiamo “socialità predatoria”). Ancora, ognuna delle due polarità del suddetto carosello persecutorio muta continuamente la sua connotazione (di volta in volta prevalentemente vitale o mortifera) a seconda delle esigenze dell’individuo o del gruppo e delle loro alterne prevalenze. Questa plasticità e interscambiabilità di ruoli fra predazione e socialità, nell’ambito del circuito mentale mediato dalla sessualità, da un lato è resa possibile dal fatto che entrambe le istanze appartengono sia all’individuo che è fatto oggetto di selezione, sia all’ambiente selettivo (che è il gruppo umano); dall’altro dal fatto che nessuna delle due polarità è identificabile con un’istanza “pura” e assoluta (quali sono ad esempio Eros e Thanatos, morte e vita), poiché contengono entrambe sia la morte che la vita in proporzioni perennemente variabili e cangianti. La relazione a circuito fra predazione e socialità per raggiungere e mantenere il suo carattere plastico e cangiante, si è storicamente avvalsa della mediazione della sessualità (in particolare della sessualità pre-maturata, o neotenica), che in virtù della sua natura di ponte fra mitosi (o riproduzione-escrezione) e predazione (in particolar modo cannibalica) ha potuto mescolare con molta facilità predatore e preda, soggetto e oggetto della selezione, dando così luogo a forme di sessualità intrise però di predazione e di morte, ovvero di perversione. La sessualità, quindi, non rappresenta certo quella panacea vitale che si oppone sempre alla morte, quale era l’Eros immaginato da Freud, bensì semplicemente un varco, una via di invasione, un tramite, un innesco, che permette all’elemento estraneo potenzialmente vitale o mortifero di incunearsi dentro di noi e di mescolarsi con le parti omologhe che possediamo e che sono chiamate a fronteggiarlo. Insomma il circuito mentale morte-vita, contrariamente alle speranze della psicoanalisi di derivazione freudiana (in gran parte fondate sulla presunta carica vitale e liberatoria della sessualità), si istituisce fra due polarità molto diverse dalla sessualità e dalla “morte”: e poiché queste due polarità sono rappresentate, invece, dalla socialità e dalla predazione (specie cannibalica), il circuito che esse stabiliscono si avvale della sessualità solo in qualità di innesco primordiale, quindi di tramite. La ragione di ciò secondo noi, è molto semplice: la sessualità di tipo meiotico non è né la prima né la più potente forza che è stata chiamata dall’evoluzione della vita a contrapporsi alla morte e alla predazione, poiché è nata relativamente tardi nella storia biologica: la sessualità e la meiosi, infatti, da un lato posseggono alcune caratteristiche predatorie (mescolarsi con l’altro significa anche invaderlo e depredarlo), dall’altro lato rappresentano una semplice e tardiva variazione (e complicazione) della mitosi, della moltiplicazione indifferenziata, del numero, e come abbiamo visto è proprio il numero, ovvero la moltiplicazione indifferenziata (lontana progenitrice della socialità e della vita di gruppo), che insieme alla predazione ha costituito la coppia di difese più potenti e “primordiali” che la vita abbia potuto opporre alla morte.
Concludendo, la configurazione a circuito della mente umana è resa possibile dal fatto che le due polarità in gioco, quella predatoria e quella sociale, sono complementari, basate entrambe sulla predazione: l’unica differenza è data dal fatto che la prima si basa sull’utilizzo predatorio dell’altro, e la seconda sull’utilizzo predatorio di se stessi, quindi sull’auto-sacrificio a vantaggio della riproduzione. Per queste ragioni profondamente strutturali, basate sulla fondamentale similitudine fra le difese predatorie e quelle sociali di cui dispone, l’uomo è un animale capace di convertire la predazione su se stesso in predazione sull’altro e viceversa, e per questa via di alimentare un perenne circuito predazione-antipredazione: in esso ciascuna delle due istanze, nel momento in cui su un certo piano modula e frena l’istanza contrapposta, su un altro piano la implementa, incorporandola e avvalendosene in quanto istanza similare e complementare, quindi perpetuandola. In tal modo, ovvero esperendo la morte e reagendovi in tutte le forme possibili, l’uomo interiorizza la lotta contro di essa, trasformandola in una struttura mentale persecutoria ad articolazione predatorio-sociale, ossia configurata a circuito fra queste due polarità, le quali difatti s’inseguono perennemente e si mescolano: esse lo fanno, in particolare, avvalendosi dell’innesco iniziale e della mediazione della sessualità. Tutto ciò, peraltro, è dimostrato dalla configurazione ciclica di quasi tutte le forme di sofferenza mentale che il più delle volte, sul piano formale, sono configurate “a circuito” (si vedano il disturbo bipolare e quello “borderline”, la complementarietà e alternanza fra anoressia e bulimia, quella fra sadismo e masochismo sessuale, quella fra allucinazioni e delirio, ecc.), mentre riguardo al loro contenuto hanno un pressoché costante riferimento alla predazione e alla socialità, solo sporadicamente inframmezzato da accenni a tematiche di carattere sessuale. Quanto poi al carattere apparentemente “finalistico” della selezione naturale per interazione fra individui che abbiamo ipotizzato, tale selezione, lo ripetiamo, non possiede in realtà nulla di realmente finalistico: tutto si svolge, nell’auto-selezione praticata dalla nostra specie, in maniera assolutamente automatica, ossia in base alla maggiore o minore pressione esercitata da un ambiente particolarmente severo e “catastrofico” quale quello umano di derivazione cannibalica, sull’individuo che produce variazioni genetiche, e su una “scelta” di queste ultime da parte dell’ambiente, ossia del gruppo (scelta che deve essere il più possibile conforme all’ambiente stesso, pena l’estinzione dell’individuo, e un tempo, dell’intero gruppo). In questo senso, la selezione ambientale di tipo predatorio che si svolge all’interno del gruppo umano cannibalico assomiglia molto alla selezione ambientale di tipo “catastrofico” ipotizzata da due teorici dell’evoluzione che si situano in posizione eterodossa rispetto al darwinismo ufficiale, Eldredge e Gould (i quali si rifanno a loro volta alle formulazioni di G. G. Simpson): si tratta di un tipo di selezione che abbrevia e semplifica di molto l’evoluzione postulata dal darwinismo tradizionale. In base a questa teoria, detta anche “teoria degli equilibri punteggiati”, o teoria delle catastrofi, la stagnazione evolutiva che si riscontra usualmente, per lunghissimi periodi, almeno nelle forme viventi più complesse (una stagnazione che misteriosamente si “sblocca” solo in corrispondenza di periodiche estinzioni di massa, o di “catastrofi” naturali ricorrenti), porta a formulare l’ipotesi che l’unico elemento in grado di “interagire” in maniera costruttiva con le variazioni spontaneamente prodotte dall’individuo, sia costituito dalla pressione intensiva di condizioni ambientali estremamente severe ma per lungo tempo omogenee (che nel nostro modello corrisponde alla pressione esercitata dal gruppo): queste condizioni lungamente e intensivamente “severe”, infatti, conducendo periodicamente la vita sull’orlo dell’estinzione, la spingono anche, con modalità solo apparentemente finalistiche, verso un risultato adattivo che in qualche modo deve modellarsi sullo stimolo mortifero che minaccia di estinzione la specie, al semplice fine di contrapporvisi con una qualche efficacia. In questo senso, le specie evolverebbero solo a partire da una condizione di maladattamento (condizione che G. G. Simpson fa coincidere con la denominazione immaginosa di “valli evolutive”), e solo se spinte con urgenza indifferibile (pena l’estinzione), in direzione della riacquisizione di una condizione di adattamento ambientale (condizione che lo stesso Simpson fa invece corrispondere a dei “picchi evolutivi”). Perciò l’uomo, creando un ambiente sociale cannibalico (quindi trovandosi a essere selezionato da un gruppo dotato di caratteristiche predatorie), secondo la nostra ipotesi non avrebbe fatto altro che realizzare una condizione di maladattamento permanente, ovvero di “catastrofe ambientale interiorizzata”, che lo avrebbe spinto costantemente in avanti, in una condizione di perenne e instabile equilibrio fra le “valli” e i “picchi” evolutivi: il vantaggio evolutivo che da ciò derivava, lo avrebbe poi indotto a non rinunciare a tali caratteristiche predatorie, bensì a limitarsi a ritualizzarle e trasformarle, rendendole via via sempre più metaforiche e incruente. Insomma, il modello “catastrofico” e cannibalico dell’evoluzione renderebbe conto del fatto che l’evoluzione stessa ci appare, specie per l’uomo, “finalizzata” al conseguimento di alcune caratteristiche (quelle inerenti la sessualità e l’intelligenza simbolica), pur non essendolo assolutamente, almeno in primis: essa infatti procede in una maniera che, pur non essendo “a piccoli passi”, e nemmeno “cieca”, dato che l’interazione individuo-individuo, quindi individuo-gruppo non è mai totalmente cieca, può dirsi assolutamente a-finalistica e “naturale”, proprio come è previsto dal modello darwiniano.
- Per una genealogia della morale
La terza questione sollevata nell’ambito del primo incontro riguarda la mia idea che la morale possa essere stata anticamente determinata da una motivazione biologica, e in particolare dall’esigenza concreta di una difesa della vita. È stato rilevato che quest’idea mette radicalmente in discussione il concetto kantiano di una morale “assoluta” e “categorica”, ovvero “sciolta” da qualunque contenuto, vincolo o motivazione di carattere utilitaristico e contingente. La prima tentazione che ho avuto, di fronte a una questione così importante, e all’apparenza così “imbarazzante”, è stata quella di “cavarmela” rispondendo che così come, in base alla mia indagine, sul piano evoluzionistico, dagli istinti si sia passati gradualmente alle formazioni post-istintuali e ai codici simbolici (quindi al carattere plastico e “storico” del comportamento umano), analogamente la mia indagine sulla coscienza non si riferiscca tanto alla morale in sé, quanto alla sua lunga genesi evolutiva; perciò il prodotto finale di questa complessa genesi può essere molto più plastico dei punti di partenza iniziali: conseguentemente a ciò la coscienza, nel suo carattere astratto, può essere quasi totalmente svincolata, quasi “dissociata”, dalle proprie determinanti biologiche primarie, e possedere un certo margine di “libera scelta”. In questo senso, la distanza che separa la coscienza auto-riflettente di noi uomini moderni da quella che ho ipotizzato essere stata la primitiva “coscienza integrata” (a carattere ciclico e “bipolare”) che legava fra loro i derivati post-istintuali della socialità e della predazione, e che si poneva “dal punto di vista del predatore”, è davvero enorme: la coscienza moderna come io la intendo, infatti, è molto diversa dal “super-Io” freudiano (il quale è poco più che un istinto, almeno quanto a rigidità e mancanza di libertà), poiché si basa su una radicale dissociazione della parte cosciente e simbolica della mente dalle determinanti biologiche degli istinti cui si contrappone, quindi implica un’enorme distanza delle istanze morali dalla sfera istintuale, nonché un’identificazione quasi totalmente “disinteressata” del proprio sé con quello degli “altri” (ossia, con elementi della realtà assai simbolici e astratti, quali ad esempio le esigenze superiori del gruppo, il “collettivo universale”, il “bene dell’altro”, ecc.). Non a caso ho ipotizzato che a una tale radicale dissociazione della mente cosciente dalla biologia debba fare da contrappeso il persistere, in qualche zona “inconscia” della mente stessa, di un “piccolo circuito antipredatorio” di tipo caratteriale e vagamente delinquenziale, finalizzato a riportare continuamente “con i piedi per terra” tutto ciò che la coscienza ha dissociato dalla biologia e reso astratto e impersonale, collettivo e “morale”, oltre che leggero, impalpabile, etereo e quasi “kantiano”: vedi ad esempio quello straordinario prodotto della coscienza moderna, e delle cognizioni a essa collegate, che è la logica di tipo formale e matematico. Successivamente però, riflettendo più a fondo, mi sono reso conto che l’obiezione resta in piedi nella sostanza, poiché non si può negare che per quanto grande sia la distanza che separa la nostra recente coscienza dissociata, ultra-morale e ultra-simbolica, dalle sue fonti biologiche, questa distanza non è comunque infinita, ovvero “assoluta” e “a priori”, come pretende Immanuel Kant. Infatti, la mia idea di coscienza è che essa si sia originata dall’esigenza di auto-controllo della preda posta di fronte al predatore (un auto-controllo basato essenzialmente sulla colpa e sul senso dei propri limiti, e volto a controllare i derivati dell’istinto predatorio anzitutto in se stessi, al fine di imparare per questa via a controllare anche il predatore e a identificarsi con lui, ovvero ad auto-osservarsi e ad auto-controllarsi ponendosi dal suo punto di vista); però, intendendolo in questo senso, l’auto-controllo del soggetto non è mai un “a priori” categorico, ossia completamente disinteressato e “assoluto”, poiché passa sempre, necessariamente, attraverso il controllo del predatore, quindi attraverso una qualche “utilità”. Insomma, mentre per quanto riguarda la questione del processo di dissoluzione degli istinti ci si può accontentare di un risultato non “assoluto” (la natura umana è “storica”, ma tale “storicità” si sostanzia necessariamente di alcune determinanti molto concrete e materiali, ed è perfettamente logico che sia così, come è stato colto benissimo sia da Marx che da Heidegger), per quanto riguarda la morale, invece, ciò non è possibile: la morale, almeno se definita in senso kantiano o è o non è. Insomma, per quanto grande possa essere la distanza che si è creata, nel corso dell’evoluzione, fra le determinanti biologiche del comportamento individuale e la coscienza nei suoi aspetti dissociati e collettivi (con la sua astrazione, con il suo carattere auto-osservante e con le sue caratteristiche morali, auto-riflettenti e giudicanti), quest’ultima risponde comunque all’esigenza di controllare se stessi al semplice fine (prettamente auto-difensivo) di controllare il predatore; a questo punto, la costruzione di Kant crolla fatalmente: infatti se la vigilanza interiore, anche nei suoi aspetti più disinteressati e astratti, serve all’interesse vitale dell’individuo (o anche soltanto del gruppo), essa alla fine refluisce nella vigilanza che la preda rivolge all’ambiente esterno e alle sue minacce; ma di conseguenza, anche la coscienza morale viene di nuovo a identificarsi con la coscienza intesa come vigilanza esterna e come “utilità”. A questo punto insistere nel postulare un carattere “assoluto” e categorico, della morale in sé, attraverso cui il soggetto può giungere alla fine di un lungo tragitto evolutivo, equivale a nascondere la necessità pratica (tutt’altro che disinteressata) dell’auto-controllo, che corrisponde all’esigenza di controllo dell’altro. In altre parole, è inutile nascondere che la mia ricerca svela (o pretende di svelare) proprio a quel soggetto che dovrebbe, in base all’imperativo categorico, percepirsi come “disinteressato”, il motivo recondito del proprio “disinteresse” (motivo che è in realtà utilitaristico), per cui alla fine si ritorna al punto di partenza: se si sa che il proprio fine ultimo (o il proprio punto di partenza evolutivo) non è disinteressato, non si può più neppure percepirlo come tale, e a questo punto ogni “a priori” scompare, anche come semplice ipotesi di lavoro. Detto questo rimane ancora, è vero, la questione dell’esigenza di un’universalità, almeno tendenziale, della coscienza morale, e quindi della necessità, almeno pratica, di un suo svincolo da determinanti individuali o di gruppo più particolari; però, anche in questo campo, pur non essendo un filosofo, mi sembra che la filosofia morale abbia fatto parecchia strada dopo Immanuel Kant (e non si è trattato precisamente di una strada volta in quel senso “progressivo” che da molti era stato sperato). Pensatori come Nietzsche e Heidegger hanno ridimensionato di molto le pretese di assolutezza della morale kantiana, sebbene sembra che, almeno dal punto di vista morale, questi pensatori non abbiano elargito un contributo del tutto positivo.
In conclusione, mi sembra che sia molto più onesto portare alla luce gli elementi biologici che impediscono alla morale di essere “assoluta”, ovvero affrancata da vincoli utilitaristici, e tentare attraverso questo riconoscimento di padroneggiare la spinta e la potenza davvero spaventose che derivano da tali vincoli e condizionamenti (i quali sono di natura inconfondibilmente persecutoria), che non fingere una condizione di autonomia morale dell’uomo (in particolare, di autonomia dalla sua biologia predatoria), incapace di reggersi in piedi.
- L’ebraismo e il Dio predatore
Infine, vorrei rispondere alle obiezioni sollevate sulla mia interpretazione “colpevolizzante” della religione e della divinità monoteistica ebraica e sulla relazione a mio avviso presente tra le radici ebraiche di Freud e la sua idea di “istinto di morte”.
Questa critica parte da un chiarimento filologico assolutamente corretto, che si è prodotto quando si è ricordato che l’idea del peccato originale non sia contenuta nella Genesi, ma rappresenti un’invenzione cristiana, precisamente frutto dell’esegesi di S. Paolo; ciò è assolutamente esatto, però devo confessare che non mi sembra che quest’elemento cambi sostanzialmente i termini della questione, almeno per come io l’ho posta: il Dio unico della Genesi, e in generale il Dio della Bibbia è terribilmente persecutorio; e lo è non solo perché, nell’assoluta strapotenza della propria “unicità”, perseguita le sue creature non appena esse aspirano a un minimo di libertà, ma soprattutto perché attenta alla vita dell’intero genere umano (fatto salvo Noè e pochissimi altri), perseguitandolo senza pietà, prima con la cacciata dal Paradiso Terrestre, poi con il Diluvio Universale, e infine con altri innumerevoli strumenti (le piaghe d’Egitto, Sodoma e Gomorra, ecc.), per cui nel complesso appare pronto a sterminare chiunque ardisca disubbidirgli, o semplicemente porsi al di fuori della sua obbligatoria “protezione”. Devo anche precisare, però, che questa mia valutazione circa il carattere persecutorio della religione ebraica, non è in sé affatto negativa, poiché ritengo che l’alto tasso di persecutorietà della religione ebraico-cristiana nel suo insieme, e anche la sua carica di criticità nei confronti dell’uomo e della sua imperfezione, rappresentino dei punti forti, non certo dei limiti, per la spiritualità che ne consegue: Mircea Eliade soleva dire che la religione ebraico-cristiana è una singolare “religione capovolta”, che parte da un mito delle origini totalmente negativo (la cacciata dal Paradiso Terrestre), per dirigersi verso un esito escatologico altrettanto positivo (la salvezza), al contrario di quanto fanno le religioni più arcaiche e tradizionali (anche se poi sottendeva a tale connotazione un giudizio negativo, quasi che il monoteismo “sfruttasse” a fini di potere il senso del peccato che di proposito instillava negli uomini). Io ritengo, al contrario, che questo capovolgimento del negativo delle origini nel positivo della redenzione, rappresenti per l’appunto l’elemento di grandezza delle religioni monoteistiche, poiché è precisamente attraverso la trasformazione della predazione e della persecuzione nel suo contrario (ossia in eros e in amore, in salvezza e in riscatto), che esse ci rappresentano magistralmente quella metamorfosi della predazione cannibalica in senso antipredatorio (ossia in un senso da un lato simbolico, dall’altro amoroso e basato sul perdono, sulla riconciliazione padre-figlio e sul riscatto della colpa relativa al conflitto originario), che io ipotizzo essere il principale prodotto della strenua lotta antipredatoria e anticannibalica condotta dalla nostra specie: una lotta che l’ha condotta a superare almeno parzialmente se stessa e ad approdare, attraverso la tappa intermedia della sessualità perenne e dell’amore erotico, ai codici simbolici e al linguaggio, all’idea di amore universale e di disinteresse, alla coscienza morale e all’auto-coscienza. Dante Alighieri ci ha insegnato che non si può giungere al Paradiso se non passando per l’Inferno: ora, questo è appunto il cammino che l’uomo ha compiuto partendo dal cannibalismo e dalla persecuzione predatoria, per giungere alla fine all’intelligenza simbolica, al patto padre-figlio e alla coscienza morale.