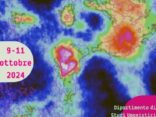Autore
Indice
Note a margine del colloquio introduttivo del Meeting Internazionale Transdisciplinare “Inquietudini nella Modernità” (2010)
Firenze, 12 aprile 2010
S&F_n. 03_2010
Giunto alla sua quarta edizione, il Meeting Internazionale Transdisciplinare “Inquietudini nella Modernità”, tematizzato intorno alle complesse relazioni circoscritte dal titolo “Ethics And Epistemology in Human and Social Science: Education, Psychology, Politics, Prevention-Forecast, Economy, Communication”, ha conosciuto una sua importante tappa preliminare nel colloquio introduttivo svoltosi il 12 Aprile scorso a Firenze, presso il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi”. E in effetti non poteva essere scelta sede più adatta per ospitare un seminario pensato per fotografare lo stato dell’arte su una delle questioni che più sta interrogando la contemporaneità, il postumanesimo. Da Darwin in poi la biologia sta infatti smentendo uno a uno i postulati della tradizione umanistica. Non solo è in crisi l’egolatria di una specie naturalmente narcisistica ma sta vivendo tempi assai difficili anche e soprattutto la cornice epistemologica attraverso cui l’uomo ha sempre pensato a se stesso, perlomeno da duemila, duemilacinquecento anni a questa parte. Da quando, cioè, i filosofi hanno pensato bene (?) di istituire quella che amano tanto indicare come la “differenza ontologica” tra l’Uomo e l’Animale. Che dietro l’invenzione di questa particolare divaricazione dell’essere, per cui da un lato ci sarebbe l’Uomo e dall’altro l’Animale, si nasconda un’operazione assai interessante, forse il gesto fondativo di tutta la tradizione metafisica e, a seguire, di tutto quell’intreccio di teorie dell’umano racchiuse sotto l’etichetta di “umanesimo”, non lo pensa soltanto qualche gazzettiere à la page (il che comunque sarebbe da tenere in considerazione) ma lo ha suggerito da par suo Jacques Derrida nel testo che purtroppo non ha fatto in tempo a veder pubblicato. Ne L’animale che dunque sono Derrida affronta con ostinazione un’unica questione, la questione dell’animale. E non si pensi a una sua tarda conversione alla filosofia animalista. La questione dell’animale è per Derrida il gancio cui far aggrappare ogni radicale critica alla metafisica razionalista e all’umanesimo da essa partorito. La questione dell’animale è a suo dire talmente importante da offrire un «indispensabile filo conduttore per leggere le filosofie e accedere a una sorta di “architettura” segreta nella costruzione, dunque nella decostruzione di un dispositivo discorsivo, di una coerenza se non di un sistema. Non si capisce un filosofo – sentenzia Derrida – se non cercando di capire bene ciò che intende dimostrare, e in verità non dimostra, sul limite tra l’uomo e l’animale»[1]. Non si tratta, aggiunge Derrida, «di contestare il limite di cui ci si riempie la bocca, il limite tra l’Uomo con la U maiuscola e l’Animale con la A maiuscola. Non si tratta di attaccare frontalmente o antiteticamente la tesi sia del senso filosofico sia del senso comune su cui si è costruito il rapporto a sé – l’auto-presentazione della vita umana, l’autobiografia della specie umana […]»[2], piuttosto si tratta di piegare, ripensare, trasfigurare il limite a partire da cui l’uomo ha potuto costruire questo rapporto. Si tratta cioè di pensare, pensare per davvero, un’eteroreferenza. L’Animale diventa allora un nome collettivo che racchiude ogni Altro: l’angelo, la macchina, il pc, il robot.
Dall’antropologia cognitiva alla psicologia, dalla filosofia morale alla filosofia del diritto, dalla teoria dell’informazione all’ingegneria, nel corso della giornata fiorentina hanno provato a sciogliere alcuni nodi della diade “Umano/Postumano” pensatori e studiosi appartenenti a discipline che solo ieri avremmo ritenuto accomunate esclusivamente dalla burocrazia del Miur e che invece oggi cominciano a dialogare per davvero. Magari non solo per volontà, quanto soprattutto per necessità. La necessità dettata dal moltiplicarsi di fatti condannati a rimanere illeggibili alla luce dei saperi tradizionali. Dove collocare, tanto per fare un esempio, l’animale «senza parola» di Heidegger nel momento in cui gli etologi armati di apparecchiature neuroscientifiche ci spiegano che non solo l’uomo, ma anche alcune specie di uccelli, per non dire delle scimmie antropomorfe, sono capaci di verbalizzare i propri pensieri? Dove collocare i “sistemi autonomi” progettati dagli attuali ingegneri robotici, vale a dire quei sistemi che diversamente dai robot “sorvegliati” (supervised systems) e da quelli automatici, non solo possono fare a meno di un operatore che dia loro degli ordini, ma possono persino imparare da sé come comportarsi nei diversi contesti ambientali? Come negare che questi animali e che queste macchine comincino a mostrare degli inequivocabili segni di intelligenza? Come negare delle “porzioni” di umanità anche a ciò che tradizionalmente è stato posto al di fuori dell’umano?
Introdotti da Mario Pissacroia, curatore del colloquio e direttore del LA.R.P. “International Mind Laboratory Research”, hanno cominciato a dare delle risposte a questi interrogativi Paolo Amodio, docente di Antropologia Filosofica alla Federico II di Napoli, Roberto Marchesini, zooantropologo e autore dell’ormai classico Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Massimo Bergamasco, docente di Meccanica applicata alle macchine della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Roberta Igliozzi, psicoterapeuta presso l’Istituto Scientifico I.R.C.C.S. “Stella Maris” di Pisa, Anna Borghi, docente di Psicologia generale presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, Paolo Sommaggio, docente di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e Mario Pireddu, docente di Teoria dell’Informazione e Comunicazione presso l’Università di Roma Tre.
Nel corso del suo intervento, dal titolo “L’appello del post-umano e gli affanni della filosofia”, Amodio ha messo in evidenza le incertezze dell’antropologia filosofica nel suo pur meritorio tentativo di misurare la teoria e la prassi filosofica alle scienze e, in particolare, alla biologia. Il nesso biologia/filosofia viene fatto immediatamente ricadere in quello uomo/mondo e questo, a sua volta, viene fatto esplodere nell’ormai canonica definizione dell’uomo come animal rationale. Il punto, ha sottolineato Amodio, è che questa stessa definizione è sintomatica di un problema, quello per cui è la questione stessa del rapporto uomo/mondo (e quindi del nesso biologia/filosofia) a risentire di un’aporia, di una sorta di peccato originale insieme concettuale e metodologico. «Nel momento in cui si mettono in rapporto i due termini – ha spiegato il filosofo – la frazione uomo/mondo tradisce una frattura originaria il cui risultato non potrà che essere una dicotomia, anche là dove il risultato sembra univoco». Insomma, gli strumenti offerti dalla tradizione filosofica per teorizzare intorno all’umano rischiano di tenerci ingabbiati in una sorta di fallacia metafisica: si dice “cultura”, ma il termine sembra assumere sostanza solo se contrapposto a “natura”; si dice “spirito”, ma il termine sembra assumere sostanza solo se contrapposto a “corpo”. Nel teorizzare intorno all’uomo si dice animal rationale ma si pensa solo alla ratio, come se l’aggettivo non potesse avere che un significato avversativo rispetto all’animalitas sostantivale. Consapevole di tali difficoltà, l’antropologia filosofica novecentesca ha provato a superare il radicale antropocentrismo della filosofia ma, in fondo, senza grossi risultati. «L’antropologia filosofica – ha osservato Amodio – cerca l’uomo integrale, prova a trascinare il logos verso il bios, ad avvicinarsi al “regno della vita”, ma alla fine non fa che ritrovare la prudente suggestione herderiana dell’uomo come animale carente». Niente di nuovo sotto il cielo, verrebbe da dire. La complessità del vivente e delle sue forme, la questione del logos che nasce dal bios e che non per questo ha qualcosa da farsi perdonare è allora una questione ancora tutta da pensare, probabilmente sotto il segno di una nuova teoria dell’umano.
Roberto Marchesini nella sua “Proposta postumanistica” ha insistito soprattutto sui concetti di eteroreferenza e di ridondanza. «Il post-umanismo – ha evidenziato Marchesini – respinge l’idea di una natura umana esaustiva, così come respinge l’idea di una natura che si definisce per contrasto o che magari è ininfluente nel processo di antropo-poiesi». Per lo zooantropologo non si tratta di trovare una via mediana tra queste due visioni ma di superare del tutto le tradizionali interpretazioni dell’uomo e dell’umano in modo che l’uomo, in quanto entità biologica determinata, e l’umano, in quanto dimensione in divenire, stiano sempre in un rapporto biunivoco. «È necessario riconoscere una natura umana in grado di dar conto dell’antropo-piesi ma non dell’esito di tale processo». Quindi, contrariamente a quanto insegnato dall’umanesimo, non si tratta di spiegare i predicati (indubbiamente) eccezionali dell’uomo negandone ogni tipo di retaggio, ma si tratta di individuare proprio nel suo retaggio filogenetico le potenzialità di far nascere quei predicati che (indubbiamente) lo trascendono. Il retaggio filogenetico diventa così al contempo ciò che ci accomuna con l’Alterità animale e ciò attraverso cui abbiamo potuto definire la nostra spuria identità.
Citando recenti studi della biologia evoluzionistica e delle neuroscienze, Marchesini ha inoltre messo in evidenza che la natura umana, proprio per la sua complessità, tende a processi ibridativi. Due gli esempi riportati: 1) la particolare struttura neurobiologica dell’uomo; 2) la dimensione epimeletica della nostra specie. Le neuroscienze hanno ormai dimostrato quello che gli specialisti definiscono dei processi di ridondanza, vale a dire l’incredibile plasticità dei circuiti neurali; ora, tanto più intensa è questa plasticità tanto più intenso sarà il bisogno di un cervello del genere di essere plasmato dall’esterno. È come se la complessità del meccanismo cerebrale non potesse realizzarsi senza uno stimolo esterno, stimolo che a sua volta non innesca un processo già definito ma dà semplicemente (si fa per dire!) il via a una rete di cui non è mai possibile conoscerne sin dall’inizio l’architettura. Detto in altri termini, un’importante dotazione filogenetica richiede un altrettanto importante apprendistato: innato e appreso si incrociano e per molti versi, per come li abbiamo intesi finora, non hanno più senso.
Quanto alla dimensione epilemetica della nostra specie, Marchesini ha ricordato come noi, al pari delle nostre cugine antropomorfe, ci distinguiamo perché accompagniamo la nostra complessa ontogenesi con altrettanto complesse cure parentali. «La dimensione epimeletica – ha osservato Marchesini – caratterizza tutti i mammiferi che per ragioni costitutive sono organismi declinati al femminile, giacché la loro prima relazione, che poi diventa l’archetipo relazionale, è quella che lega il cucciolo alla madre. Il comportamento di cura ricevuto dalla madre diviene una sorta di grammatica di base nello stile delle relazioni sociali. Se questo è vero nei mammiferi in generale, lo è ancor di più nelle antropomorfe e in Homo sapiens. La nostra specie si è infatti distinta anche per la domesticazione, cioè per l’adozione di cuccioli di altre specie, sui cui non è da escludere che siano stati inizialmente esercitati dei processi di vero e proprio maternaggio». Il processo di de-animalizzazione dell’uomo è dunque avvenuto attraverso passi di crescente ibridazione con alterità non-umane.
Di alterità non-umane appartenenti non tanto ai nostri retaggi quanto al nostro futuro ha parlato Massimo Bergamasco, che ha relazionato su “Esoscheletri ed Extenders”. Tra i primi in Italia a sviluppare dei sistemi avanzati di interfaccia, cioè dei sistemi che consentano al soggetto “interfacciato” non solo di controllare I'operazione in modo naturale in termini di comando e di movimenti, ma anche in grado di riprodurre le sensazioni sensoriali adeguate affinché egli possa sentire fisicamente l'ambiente simulato, Bergamasco ha illustrato le potenzialità ibriditative di questa nuova generazioni di sistemi robotici. I sistemi di interfaccia di questo tipo vengono definititi "interfacce aptiche” (haptic interfaces) perché consentono all'operatore di percepire le proprietà di oggetti virtuali, quali rugosità, durezza e forma, sfruttando input sensoriali cinestetici, tattili e di forza, esattamente come se ci si muovesse in ambienti reali.
«I dispositivi robotici indossabili – ha evidenziato Bergamasco – come ad esempio le ortesi attive o gli esoscheletri per l’amplificazione di forza, sono una classe emergente di robot avanzati, per i quali si prospettano nel medio termine numerose applicazioni di rilevante impatto sociale e industriale, quali la riabilitazione delle capacità motorie di pazienti con deficit neurologici, il supporto fisico degli anziani durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane e la movimentazione di materiali pesanti in ambienti non strutturati». Proprio perché caratterizzate da un elevato grado di interazione fisica con l’utente, lo sviluppo degli esoscheletri pone importanti sfide tecnologiche. «Ciò – ha detto Bergamasco – sia per quanto riguarda le componenti di attuazione e di generazione e immagazzinamento dell’energia sia per quanto riguarda le componenti elettroniche e di controllo». Lo scienziato ha quindi proceduto a illustrare dapprima le principali differenze concettuali, funzionali e architetturali dei dispositivi robotici indossabili rispetto ai robot esoscheletrici, indicando i termini delle differenti problematiche tecnologiche che devono essere affrontate per la loro concreta realizzazione, e successivamente ha indicato i principali dispositivi sviluppati più di recente in ambito di ricerca accademica e industriale e le relative applicazioni prese a riferimento per il loro sviluppo. Ha in ultimo confrontato i risultati tecnologici a oggi raggiunti con le visioni futuristiche inscenate dalla recente science fiction.
Altri interessanti sviluppi della robotica sono stati illustrati dalla dottoressa Roberta Igliozzi, psicoterapeuta presso l’Istituto Scientifico I.R.C.C.S. “Stella Maris” di Pisa, dove da anni si conducono ricerche all’avanguardia su patologie complesse, tra cui l’autismo. Igliozzi, in particolare, fa parte del gruppo di ricerca guidato dal professore Filippo Muratori, il quale ha introdotto un metodo diagnostico e terapeutico che prevede anche l’uso di androidi. In pratica, all’equipe specialistica composta da neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, terapisti del linguaggio, terapisti della motricità, tecnici esperti di elettrofisiologia, di imaging e di genetica, si sono aggiunti anche dei bioingegneri, con i quali è stata sviluppata l’idea di andare a valutare le reazioni dei bambini con autismo a un androide creato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca "E. Piaggio", dove il professore De Rossi conduce ricerche nei settori della Bioingegneria e della Robotica. «Abbiamo pensato – ha detto la Igliozzi – che l’androide, con le sue sembianze umane all’interno di un corpo non umano, potesse essere una ottima palestra per insegnare alle persone con autismo a rimarginare almeno in parte le loro difficoltà a districarsi nel complesso mondo delle relazioni umane fatte di espressioni, mimica, gesti».
L’androide si chiama FACE (Facial Automaton for Conveying Emotions) e sa ridere, rattristarsi, arrabbiarsi, impaurirsi, meravigliarsi, sa esprimere quindi una gamma assai ampia di espressioni emotive, in un modo semplice e chiaro. Proprio per queste ragioni, secondo il team di ricercatori della “Stella Maris”, FACE rappresenta uno strumento ideale per mettere in atto in un modo del tutto originale un training delle abilità sociali a partire dalla curiosità per le espressioni facciali dell’altro. «Dobbiamo pensare – ha osservato la psicologa – che la abituale espressività facciale usata nella comune comunicazione umana è estremamente complessa, probabilmente molto più complessa di quanto noi ne siamo consapevoli quando la usiamo, e probabilmente estremamente difficile da comprendere per il soggetto con autismo, il quale se ne distoglie preferendo l’attenzione e la relazione con oggetti non umani. Il non umano è infatti da questo punto di vista estremamente più semplice e prevedibile. L’ipotesi è che la curiosità, l’attenzione ed eventualmente l’imitazione di FACE possa aprire la strada ad un miglioramento dell’attenzione verso i “veri” umani da parte di soggetti affetti da autismo».
Sotto la regia di un trainer terapista umano, FACE cerca di innescare con il paziente possibili interazioni sociali. Al paziente vengono fatti indossare un berretto dotato di sistema di cattura della direzionalità dello sguardo e una maglietta per la rilevazione di parametri fisiologici (battito cardiaco, respirazione, sudorazione) indicatori del suo stato emotivo. Gli esperimenti finora condotti hanno dato buoni risultati, pare infatti che l’androide riesce a migliorare l’attenzione del paziente per il volto umano-non-umano, a riconoscerne le emozioni espresse, per poi imitarle. «Dalle nostre prime sedute pilota con bambini con autismo – ha concluso Igliozzi – abbiamo potuto constatare che essi non considerano FACE e i suoi movimenti come conturbanti o minacciosi ma piuttosto come suscitatori della sua curiosità ed attenzione; una grande suscitatrice di desiderio di conoscenza, di relazione e di comunicazione. L’interazione con l’androide appare dunque molto promettente».
Il colloquio è proseguito sul versante psicologico con Anna Borghi, che ha tenuto una relazione sulla cosiddetta “Cognizione embodied”. La Borghi ha messo in evidenza come negli ultimi anni abbia avuto luogo un profondo cambiamento nell'ambito delle neuroscienze cognitive. In contrapposizione con la visione classica per cui la mente era vista come un meccanismo di elaborazione di simboli, si è progressivamente affermata l'idea per cui la cognizione è “embodied” e “grounded” . «Secondo questa concezione – ha osservato la psicologa – c’è profonda continuità tra i processi cognitivi tradizionalmente considerati di livello “alto”, come il pensiero, e quelli di livello “basso”, come la percezione e l’azione, e la cognizione si fonda sui processi sensori motori». A partire da una prospettiva "embodied" la nozione di simulazione, basata sull’idea che gli stessi sistemi sensorimotori si attivano quando osserviamo oggetti (attivazione di neuroni canonici), o osserviamo altri compiere azioni (attivazione dei neuroni specchio), o comprendiamo il linguaggio (attivazione sia dei neuroni specchio che dei neuroni canonici), contribuisce a spiegare i meccanismi che entrano in gioco quando interagiamo con gli oggetti, quando osserviamo altri agire e quando comunichiamo con gli altri.
Fatte queste precisazioni preliminari, la studiosa ha quindi spiegato il nesso tra la prospettiva embodied e il tema del postumano. «La prospettiva embodied – ha osservato – andrebbe infatti ampliata e integrata grazie all’apporto di altri approcci. In primo luogo, andrebbe problematizzata la nozione di corpo». Il corpo, infatti, è stato spesso assunto come biologicamente dato senza metterne in luce gli aspetti complessi, biologici e sociali, e senza sottolineare il fatto che il corpo e i suoi confini sono variabili, si possono modificare ed estendere. «In secondo luogo, l’idea che la cognizione è “embodied” andrebbe integrata con quella che la cognizione è situata, quindi ancorata ad uno specifico contesto socio-culturale». In quest’ottica, secondo la Borghi, il corpo rappresenterebbe un primo modo, un primo contesto in cui essere situati. Oltre che situata, la cognizione è «estesa», come direbbe Clark e distribuita. «La cognizione, insomma, non sta solo nel cervello, né solo nel corpo, non è semplicemente influenzata dall’ambiente fisico e sociale che ci circonda. A questo proposito il linguaggio rappresenta un ottimo esempio. Le parole possono infatti rappresentare degli utensili (tools) che ampliano il nostro spazio di azione, estendono la nostra attività cognitiva, e modificano anche la stessa percezione del nostro corpo».
Su scenari squisitamente filosofici ha riportato i termini della discussione Paolo Sommaggio, che ha provato a dare una risposta all’interrogativo: “Dall’umano al postumano. Incubo o nobile sogno?”. A partire dal rapporto tra genetica ed eugenetica, Il filosofo del diritto ha distinto tre declinazioni possibili della natura umana: la natura umana come un oggetto (res), come progetto (actio) e come principio.
Secondo la prima visione, la natura umana consisterebbe in un oggetto complesso che racchiude gli elementi costitutivi ed essenziali dell’umano, tanto in termini di materiale biologico quanto in termini di informazione. Secondo Sommaggio questa visione è stata quella prevalente sino alla completa identificazione del Genoma Umano. «Sino ad allora – ha osservato – si sviluppa un’operazione mitopoietica secondo cui l'essere umano è ridotto al suo genoma». Ma questa prima concezione, per la quale l’umano viene considerato come un oggetto biologico-informazionale, comincia a essere considerata contraddittoria proprio nel momento in cui si accrescono le conoscenze sul genoma: più si procede con questa attività di analisi, più si perde la possibilità di individuare l’elemento ultimativo della natura umana. Si profila così una nuova concezione della natura umana e del vivente in generale, quella progettuale. Questo secondo approccio filosofico alla natura umana si accompagna al cambiamento dei presupposti del pensiero scientifico. «La scienza – sottolinea Sommaggio – non ritiene più di scoprire le leggi immutabili della natura ma comincia a riflettere anche sulla propria convenzionalità e sul proprio limite. Si ritiene perciò che la natura umana non abbia una consistenza oggettiva, ovvero sempre uguale a se stessa, ma possa essere considerata come uno schema di azione: l’azione di organizzazione di più parti che possono essere liberamente ordinate in unità». Nell’alveo dell’epistemologia darwiniana l’uomo appare immediatamente come un progetto e quindi non è affatto un caso se prima ancora della genetica si sia affermata una scienza come l’eugenetica, vale a dire un sapere che nasce proprio per intervenire sul progetto uomo al fine di perfezionarlo. Ricontestualizzando l’eugenetica dai suoi albori alle sue attuali potenzialità, il filosofo ha poi osservato che «la concezione di una natura umana intesa come progetto è tanto più attuale oggi che la cosiddetta tecnoscienza può fare a meno della politica e della legislazione statale per imporre i propri standards antropologici alla società. Si assiste pertanto a una situazione per cui la tecnoscienza, dopo una stagione nella quale si è servita della interfaccia giuridico-statale, può fare a meno di referenti istituzionali imponendo surrettiziamente le proprie scelte al singolo, presentando a tutti come preferibili solo quelle alternative che essa ha già preferito. Si passa dalla vecchia eugenetica di stato a una nuova eugenetica consumistica». Più precisamente, in età post-moderna, dove sembra tramontato qualsiasi tentativo di tipizzazione umana, dove sembra essere svanito qualsiasi modello antropologico, è possibile che si arrivi al parossismo per cui l modello diventi l’assenza stessa di una tipologia, ovvero il cambiamento perpetuo. «Radicalizzando questa ipotesi, non è illogico pensare che si arriverà al riconoscimento, ovvero alla tutela sociale e giuridica, solamente di quegli esseri che sono mutanti non in quanto sinonimo di “già modificati”, ma di modificantesi. L'espressione mutanti, allora, dovrebbe essere considerata come un participio presente, quale grammaticalmente è, e non un participio passato, come spesso si crede. Sembra, dunque, che la volontà individuale, elemento caratterizzante il sistema razionalistico dell’epoca moderna, possa subire un grave scacco e che, nel suo momento di apoteosi, patisca invece una contraddizione per la quale il suo trionfo si ribalta in una sconfitta».
Dal superamento di queste contraddizioni nasce la possibilità di concepire l’umano come un principio. «Sintetizzando – ha spiegato Sommaggio – considerare la natura umana come principio significherebbe considerare la possibilità che l’intero della specie umana non sia solo l’insieme dei modi nei quali la possiamo intendere (o dei progetti che intendiamo proporre o scegliere), ma sia l’insieme di queste modalità più “qualcosa d’altro” che risulta sfuggente, nascosto e che ne custodisce l’unità. Questo modo di pensare è risalente e tuttavia sempre nuovo, in quanto fa emergere, anche attraverso la testimonianza della genetica, che vi è una realtà che ci rende uomini e che sfugge sempre alla possibilità di essere imprigionata in un oggetto o in un progetto determinati».
Ha concluso il colloquio Mario Pireddu con una relazione dal titolo “The Machine is Us/ing us”. Pireddu, curatore di uno dei primi volumi dedicati alle tematiche postumanistiche, ha concentrato la sua riflessione sul rapporto tra media e mutamento sociale, a suo modo di vedere da sempre tenuto ai margini dalla matrice elitaria e tipografica del pensiero progressista da una parte e conservatore dall’altra. «L’eredità migliore del materialismo storico come metodo d’indagine – ha osservato Pireddu – spesso ha potuto dare i suoi frutti solo all’esterno delle tradizionali aree disciplinari riconosciute. Ecco perché, ad esempio, un approccio mediologico agli studi sulla comunicazione ha preso corpo in modo discontinuo e a fasi alterne, queste ultime essendo spesso legate alle fortune di questo o quel pensatore “non organico” a un ambito disciplinare o comunque da considerare eccentrico». Da Walter Benjamin a Edgar Morin passando per Marshall McLuhan, «autori molto citati ma sistematicamente mai presi troppo sul serio», gli autori dei contributi più interessanti per comprendere gli effetti trasformativi delle tecnologie per la comunicazione sono, a giudizio di Pireddu, sempre rimasti al di fuori della sfera d’interesse di chi per mestiere doveva occuparsi di comunicazione e società. «Le tecnologie per la comunicazione, in particolare, sono sempre state considerate e analizzate in un’ottica meramente strumentale, secondo un approccio che non poteva consentire di comprendere la natura fortemente post-umanistica delle pratiche comunicative novecentesche così come di quelle contemporanee». A questo punto il discorso del teorico dell’informazione è naturalmente caduto sul cosiddetto web 2.0 e sui social media, che «stanno finalmente mostrando quanto il medium sia sempre più messaggio, e quanto l’uomo non possa pensarsi senza l’alterità tecnologica». Le nuove tecnologie della comunicazione stanno cioè mostrando come i processi di ibridazione e compenetrazione tra anthropos e bíos siano oggi rapidissimi, tanto rapidi che «il ritmo di trasformazione culturale e tecnologica ci costringe a riconsiderare il ruolo del sistema uomo-macchina per affrontare i problemi posti dal superamento concreto del retaggio ideologico antropocentrico».
[1] J. DERRIDA, L’animale che dunque sono, ed. stabilita da M. L. Mallet, tr. it. Jaca Book, Milano 2006, p. 157.
[2] Ibid., p. 67.