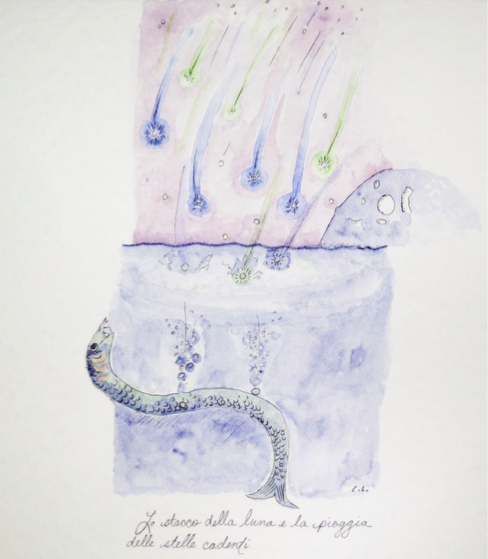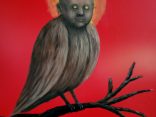Autore
Indice
- Neurofisiologia sperimentale e speculazione filosofica
- L’accadere psicofisico
- Illusioni sensoriali e vertigini
- La forma dell’esperienza
S&F_n. 14_2015
Abstract
The German doctor and physiologist Viktor von Weizsäcker believes philosophy is like an indispensable support for natural sciences, in particular for biology and neurophysiology. Man is not only a physical body and his subjectivity is very important in the study of human nature and in medicine. The introduction of subjectivity in sciences is possible by collaboration with philosophy; philosophy can transform a cluster of quantitative data in experiences with “a form”, or in the narrative of a living being.
- Neurofisiologia sperimentale e speculazione filosofica
Nella Germania dell’inizio del secolo scorso erano ancora abbastanza frequenti gli scambi tra ambito filosofico e ambito scientifico; non era tuttavia scontato che un neurologo sperimentale e medico clinico, quotidianamente alle prese con laboratori e pazienti, dedicasse alla riflessione filosofica tanta passione da elaborare una propria teoria dell’organismo vivente e orientare un’intera area della pratica medica. Victor von Weizsäcker (1886-1957) – ideatore della «teoria del Gestaltkreis» e fondatore della cosiddetta «Antropologia medica» – appartiene però proprio a questo genere di studioso. Discendente di una nota famiglia aristocratica del Baden-Württemberg, dopo avere frequentato l’Istituto fisiologico di Johannes von Kries a Friburgo, prosegue le proprie ricerche a Heidelberg, nella prestigiosa clinica neurologica di Ludolf von Krehl, dedicandosi in particolare alla fisiologia patologica dei sensi. Ma mentre svolge un’intensa attività pratico-scientifica, Weizsäcker frequenta i seminari di Wilhelm Windelband e coltiva l’amicizia di alcuni tra i più significativi filosofi del secolo, come Franz Rosenzweig, Max Scheler e Martin Buber.
Senza filosofia – sostiene Weizsäcker – la scienza rischia di essere sterile. La filosofia è uno strumento indispensabile per la ricerca: non si può essere solo «tecnici della scienza», per non smarrire il senso del tutto e il valore del proprio operato. Dal canto suo, la filosofia «non può costituirsi come sospesa nell’aria, sopra o accanto alla ricerca scientifica»; deve operare in accordo con la concretezza, poiché ne va «del legame con l’esperienza sensibile e con la verifica sperimentale e dunque [...] del legame morale della filosofia con la scienza naturale»[1]. Il richiamo a un «legame morale» non ha il senso della rivendicazione di una verifica empirica o di una fondazione esperienziale della filosofia; esprime soltanto la necessità che il sapere filosofico aderisca a quella realtà che nell’esperienza sensibile si offre in modo pieno e autentico. Pensare ed esperire, pensare e agire sono atti reciprocamente connessi nell’interazione del vivente con il mondo, e la datità materiale – sostiene – viene plasmata come «mondo del senso e dei fatti» dal processo dinamico e non scomponibile di progettazione-azione-sensazione-osservazione messo in atto dall’uomo[2].
La filosofia può fare in modo che i dati «bruti» della sperimentazione neurofisiologica possano inserirsi in un percorso «storico» e «narrativo», favorendo la liberazione della pratica scientifica dal giogo di griglie concettuali rigide e di un metodo riduzionistico non sempre vantaggioso per lo sviluppo scientifico[3]. Così, l’appello alle riflessioni di Kant, Schelling o Hegel gli viene in aiuto nella valutazione delle nuove tendenze della biologia[4], mentre tenta una ricollocazione delle concezioni meccanicistiche all’interno di una visione sistematica superiore del vivente[5]. Nella ricerca, l’uso di differenti metodi può soltanto favorire la conoscenza della realtà umana e biologica in generale, una realtà che Weizsäcker definirà «antilogica» (cioè non conforme alle leggi della logica). Causalità e teleologia sembrano comporsi in essa in un imbarazzante gioco di alternanza; ebbene – dice Weizsäcker – «cercai di cogliere questo “o-o” come un “sia-sia”: l’antinomia non doveva essere concepita come una deplorevole limitazione, ma ottimisticamente come una dotazione positiva»[6].
- L’accadere psicofisico
L’aggancio al pensiero speculativo è una chiara manifestazione di rifiuto di quella tradizione positivistica che nel settore medico, forse più ancora che nel restante ambiente scientifico, aveva improntato tanto la teoria quanto la pratica[7]. Nello spirito del positivismo, le cliniche erano concepite come istituti autonomi di osservazione, come laboratori di analisi per il controllo delle malattie, la valutazione della loro origine, del loro decorso e della loro eventuale eliminazione, nella convinzione che la malattia costituisca una deviazione dal normale corso della vita, una condizione irregolare dell’organismo a cui occorre restituire l’integrità originaria. L’isolamento del paziente, la sua osservazione e talora persino il suo allontanamento dalle cure terapeutiche, aveva lo scopo di capire come si possa intervenire su un «oggetto», senza il minimo interesse per il significato che la malattia riveste per la vita dell’individuo, la cui «soggettività» viene così totalmente trascurata. Mancava il riconoscimento di una portata psicologica della malattia (e tanto meno di una sua dimensione sociale) e non si poneva il problema di un’etica di fronte al paziente.
A questo genere di impostazione Weizsäcker preferisce quello della medicina romantica, il cui tratto universalistico – scrive – ha molto in comune con l’esigenza di totalità e di unitarietà dell’epoca contemporanea[8]. Il pensiero romantico esalta il significato della vita e conserva il valore dei suoi aspetti più oscuri e nascosti. La malattia non rappresenta una deviazione «quantitativa» da uno stato persistente e regolare, ma una manifestazione facente parte del corso esistenziale dell’individuo, un momento dell’accadere vitale, che come tale incide sulla realtà materiale e psichica dell’uomo. Con questo «accadere» l’uomo si confronta; non si può dunque paragonare la malattia a un semplice fenomeno di corruzione fisica. L’indagine che scruta dall’esterno con distacco, come dinanzi a un corpo fisico qualunque, non consente un approccio adeguato; il riconoscimento della soggettività del paziente ripristina l’integrità di questo singolare oggetto di studio e contemporaneamente rivela l’inevitabilità di una interazione, di una relazione creativa con un osservatore. È dunque più ampio il quadro da valutare: osservato e osservatore vi si inseriscono in un contesto di reciproco incontro e di «produzione» di fatti scientifici.
Si tratta, dunque, di rinunciare all’idea di un ordinamento puramente razionalistico dei fatti, omogeneo e privo di discontinuità, di contrasti e di contraddizioni, perché la vita non si lascia subordinare a una costruzione di questo genere. L’atteggiamento dello scienziato verso il vivente deve mantenersi aperto al libero porsi delle questioni. La domanda sul modo in cui considerare la natura, se ad esempio in relazione a un dio, a un’anima o se adottando un atteggiamento morale, ha a che fare con decisioni fondamentali nella regolamentazione dell’indagine e con la possibilità di riconoscere la struttura non banalmente oggettiva del vivente (non solo dell’essere umano). Abbandonando la pretesa di una costruzione compatta e lineare del sapere, la nuova scienza potrà infine «riconoscere la necessità del contrasto», insieme all’introduzione del soggetto nella scienza[9]. E’ questo che Weizsäcker tenta con la teoria del Gestaltkreis: una formulazione della struttura circolare onto-gnoseologica dell’«atto biologico», in grado di afferrare la sostanziale «antilogicità» della vita: poiché dove c’è vita c’è sempre contrasto.
- Illusioni sensoriali e vertigini
Intorno alla fine degli anni Venti Weizsäcker lavora a quell’insieme di questioni che lo condurranno a elaborare la teoria, complessa e polivalente, del Gestaltkreis. Saranno importanti soprattutto alcuni risultati ottenuti studiando il problema della percezione dello spazio e numerosi esperimenti sulle vertigini. Inizialmente, in una fase che egli stesso definisce «kantiana»[10], aveva coltivato la convinzione di poter individuare un organo del senso spaziale, collocato nel cervello e capace di rappresentare gli oggetti sensibili all’interno di uno spazio matematico omogeneo. Il disturbo di questo organo avrebbe causato, ad esempio, certi fenomeni di deformazione delle dimensioni spaziali e degli oggetti percepiti. Ma le osservazioni effettuate in clinica e in laboratorio non gli permisero di confermare simili ipotesi: non tutti i fenomeni osservati nei pazienti con disturbo della percezione spaziale si lasciavano sussumere sotto il caso della disfunzione di un unico organo. Il senso dello spazio e la capacità di orientamento gli sembrano piuttosto il risultato di una molteplicità di prestazioni organiche reciprocamente indipendenti. Per questo, comincia a ritenere opportuna la revisione di certe basi teoriche della neurofisiologia tradizionale.
Ulteriori sperimentazioni sui fenomeni di illusione sensoriale permettono a Weizsäcker di avanzare importanti ipotesi di critica del metodo e di stabilire che una deduzione strettamente fisiologica del rendimento dei sensi comporta forti incongruenze. Ritiene che nella spiegazione dei processi percettivi si debba tenere conto non solo dei dati oggettivi, ma altresì dei «vissuti soggettivi», e inoltre della eventualità che si verifichi un palese contrasto tra ciò che colgono i sensi e ciò che si dà come stato di cose oggettivo, perché parte del fenomeno nel suo insieme. Anche le ricerche sulle patologie delle funzioni sensorie aggiungono preziosi elementi, grazie ai quali elabora il «principio del cambiamento funzionale» (Funktionswandel): il disturbo di determinate prestazioni sensoriali non comporta una semplice soppressione della funzione da essi svolta; piuttosto si innesca un processo di trasformazione della funzione complessiva. L’organismo, cioè, mediante un’attività «creativa» di modificazione dei propri processi biologici, tenta di porre rimedio all’insorgere di una mancanza. Di conseguenza, il concetto di «funzione» non è da legare all’idea di un’azione fissa, ma va riconsiderato in relazione a un ordine fluido dei processi biologici, alla «prestazione» (Leistung) complessiva realizzata dall’organismo[11].
All’inizio degli anni Trenta, insieme a Paul Vogel, Weizsäcker approfondisce lo studio delle vertigini otocinetiche da rotazione. Essendo l’equilibrio corporeo una delle prestazione organiche più essenziali e complesse, ritiene possibile raggiungere risultati considerevoli a favore del principio del cambiamento funzionale. Le sue conclusioni confermavano che il verificarsi della vertigine non dipende da un organo specifico: per il soggetto sperimentale infatti «ciascuna delle velocità critiche della rotazione corrisponde a determinate composizioni dell’attività motoria e della percezione»[12]. La vertigine ha a che fare con l’associazione di funzioni statiche, ottiche e vestibolari e, per mantenere l’equilibrio, il soggetto ha la possibilità di adottare due differenti soluzioni, una percettiva e l’altra motoria. La perfetta equivalenza sul piano funzionale di queste soluzioni implica una precisa valutazione teoretica del dato psichico soggettivo e del dato fisico oggettivo: è a questo punto che «si introduce la concezione del Gestaltkreis»[13]. Essa rappresenta il tentativo di inquadrare l’accadere organico secondo un piano teorico e metodologico dalle premesse sostanzialmente nuove, nella convinzione che per trovare risposte ai problemi della fisiologia occorre partire da domande filosofiche. E la questione di fondo, quella che mostra priorità assoluta, riguarda dunque cosa si debba realmente intendere per «realtà biologica essenziale»[14].
- La forma dell’esperienza
La teoria del Gestaltkreis supera la questione del rapporto tra ordinamento fisico e dimensione psicologica, intrecciando tra loro la realtà soggettiva e la realtà oggettiva, il «proprio» e il «fuori» del vivente. Alla base di questa teoria, c’è l’idea che l’esperienza sia da descrivere non attraverso la giustapposizione lineare e discreta di momenti connessi causalmente, ma valutando la configurazione complessiva che assume una prestazione biologica. Per questo Weizsäcker usa il termine «Gestaltkreis», una «immagine concettuale» in cui la circolarità (Kreis) ha lo scopo di richiamare l’interdipendenza di soggettivo e oggettivo, indicando contemporaneamente l’impossibilità di individuare l’esatto momento di inizio e di fine dell’accadere biologico; mentre la forma (Gestalt) rimanda all’insieme, alla complessità unitaria del fenomeno vitale.
Nel breve saggio Der Gestaltkreis, dargestellt als psychophysiologische Analyse des optischen Drehversuchs, pubblicato in rivista nel 1933, Weizsäcker presentava una trattazione ancora ristretta della sua concezione; essa era tuttavia ben delineata nei suoi tratti essenziali. «Quando un malato si lamenta di avere la mano "come paralizzata" – dice –, osserviamo non di rado che egli non distingue affatto tra disturbo sensorio e disturbo motorio; solo la nostra indagine scopre, per lui e per noi, se si tratta dell’uno, dell’altro o di entrambi»[15]. Le due forme del disturbo – prosegue – hanno evidentemente qualcosa in comune nel modo in cui si manifestano, occorre perciò chiedersi cosa ne sia al fondamento, e soprattutto se non sia il caso di «correggere la nostra rigida separazione tra funzioni sensorie e funzioni motorie»[16]. Il fenomeno di fusione, che si manifesta in questo particolare disturbo del malato, non costituisce una patologia d’eccezione. Sempre e comunque la nostra attività percettiva si salda all’attività motoria in un intreccio che non genera processi paralleli o connessi tra di loro secondo una successione lineare, ma un «atto unico», un «accadere complessivo»; di fatto, «non possiamo fare nulla senza anche sentire qualcosa; non possiamo sentire nulla senza anche avere un qualche comportamento motorio»[17]. Il fondamento di questa unità, della fusione essenziale della percezione e del movimento in una unica prestazione, può essere trovato secondo Weizsäcker solo superando il tradizionale dualismo che affligge la fisiologia contemporanea, riconoscendo che «ogni distinzione è già di per sé una “astrazione”» e che la vita non si presenta mai sotto forma di momenti alternativi che si escludano l’un l’altro[18].
Nella prestazione organica, la serie dei fenomeni percettivi e quella dei fenomeni motori – vale a dire l’insieme dei dati «psichico-soggettivi» e di quelli «fisico-oggettivi» – si richiamano reciprocamente, si alternano e si scambiano secondo una disposizione circolare. Alle modalità fenomeniche di un oggetto percepito, secondo le quali lo si può afferrare, seguono le modalità fenomeniche dell’atto con il quale lo si afferra e, dopo che questo è stato afferrato – osserva Weizsäcker – si ottiene ancora una nuova percezione tattile dell’oggetto. Pare così che una successione che descriviamo in modo lineare, in qualche modo, si racchiuda in un circolo: «percezione della cosa, emozione, movimento, presa della cosa, percezione della cosa»[19]. Ma mentre in questo caso abbiamo a che fare con un processo per la cui descrizione ci sentiamo pienamente autorizzati a fare ricorso a una scansione temporale in momenti distinti successivi, se pensiamo al tentativo di riconoscere un oggetto al buio, con il solo uso del tatto, quel reciproco richiamo di percezione e movimento apparirà più immediato e la loro unità, in vista della prestazione complessiva, ancora più evidente. Il processo conoscitivo generato dalla tastazione si realizza poco a poco attraverso un gioco reciproco di atti percettivi e di atti motori, e quell’insieme di momenti, che parevano disposti nel tempo in una successione lineare continua, ora sembrano piuttosto costituire un processo unico e in certo senso simultaneo, nonostante vi si possano distinguere delle tappe. La disposizione «chiusa» delle tappe del processo rende impossibile stabilire «oggettivamente» se sia davvero il movimento a precedere e causare la percezione o viceversa quest’ultima a precedere e causare il movimento. L’atto nel suo complesso, dotato di una doppia direzionalità, procede tanto dall’oggetto verso l’organo quanto dall’organo verso l’oggetto. In questo atto – dice Weizsäcker – «la dipendenza dei processi ritorna su di sé come in un movimento circolare, in cui non si può stabilire dove sia l’inizio e dove la fine»[20]. Naturalmente è possibile fissare un «primo momento» del processo, ma esso è arbitrario, perché stabilito dall’osservatore intenzionato a descrivere l’atto biologico secondo un certo percorso, a dare un ordine e una sequenza ai momenti che lo determinano; per questo, qualunque «prima» o «dopo» possono avere soltanto un carattere relativo. La percezione insieme con il movimento genera l’atto biologico; e i due elementi non si compongono in un insieme come se fossero «parti» di un fatto accostate l’una all’altra, o una causa e un effetto che si susseguono[21].
Per questo, né la psicologia né la neurofisiologia, prese come scienze tra loro separate, con prospettive autonome e reciprocamente alternative, sono in grado di rendere conto dell’«atto biologico» nella sua totalità; d’altro canto, occorre abbandonare lo schema duale di cui si serve la fisiologia tradizionale: il rapporto tra stimolo e reazione nella fisiologia del riflesso, quello di stimolo e sensazione nella fisiologia dei sensi: «quando ci dedichiamo alla fisiologia delle sensazioni come teoria della percezione – dice Weizsäcker – ci sfugge la funzione motoria che l’accompagna, e quando studiamo le funzioni psicomotorie ci sfugge la percezione sensibile loro connessa»[22]. Un modello adeguato deve riuscire a comporre insieme un momento esterno (la stimolazione), un processo di reazione (il movimento organico) e un processo soggettivo (la sensazione o il vissuto)[23]; lo schema per la rappresentazione di tale attività dovrà dunque coordinare tre variabili: lo stimolo, la sensazione e il movimento. Con l’inserimento di una terza variabile – corrispondente alla cosiddetta «introduzione del soggetto» nell’analisi neurofisiologica – si può acquisire una nuova ottica per la spiegazione di fenomeni considerati in genere semplici «modificazioni soggettive» del dato reale, che attestano invece l’esistenza di un circuito funzionale tra le attività dell’organismo e la sua aderenza all’ambiente circostante.
Adottato dunque per chiarire il rapporto sussistente tra la percezione e il movimento in ogni «atto biologico», il concetto di Gestaltkreis assume una portata descrittiva che ne va incredibilmente oltre. In un appunto per la preparazione delle proprie lezioni, Weizsäcker gli attribuisce inoltre la descrizione del rapporto tra psiche e soma, tra soggetto e necessità, tra libertà e necessità, tra soggetto e predicato[24]. Nella sua più ampia valenza, esso coglie il divenire composito del vivente in generale, la sua forma esistenziale contrastata e metamorfica, quella di un oggetto che non può essere adeguatamente definito mediante determinazioni ontologiche, giacché la sua natura, attiva e ricettiva, non si lascia fissare nella statica, semplice modalità dell’essere.
[1] V. von Weizsäcker, Natur und Geist (1954), in Id., Gesammelte Schriften, I-X, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1986, sgg., I, pp. 9-190, p. 19. Sul suo lavoro teorico, mi permetto di rimandare a V. Rasini, Theorien der organischen Realität und Subjektivität bei Helmuth Plessner und Viktor von Weizsäcker, Königshausen & Neumann, Würzburg 2008.
[2] Cfr. D. Wyss, Viktor von Weizsäckers Stellung in Philosophie und Anthropologie der Neuzeit, in V. von Weizsäcker – D. Wyss, Zwischen Medizin und Philosophie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1957, pp. 181-290, p. 186, dove si sottolinea l’affinità di questa posizione con il Pragmatismo.
[3] Si veda, ad esempio, V. von Weizsäcker, Natur und Geist, cit., p. 117.
[4] Si veda il saggio Neovitalismus, in «Logos», II, 1911-1912, pp. 113-124.
[5] Cfr. V. von Weizsäcker, Kritischer und spekulativer Naturbegriff, in «Logos», VI, 1916-17, pp. 185-209.
[6] Id., Natur und Geist, cit., p. 117.
[7] Si veda T. Henkelmann, Viktor von Weizsäcker. L’uomo e la sua opera, introduzione a V. von Weizsäcker, Filosofia della medicina, Guerini, Milano 1990, pp. 21-28.
[8] V. von Weizsäcker, «Romantische Medizin». Zum Werk von Werner Leibbrand, in Id., Gesammelte Schriften, cit., I, pp. 544-547, p. 544.
[9] Id., Natur und Geist, cit., p. 82.
[10] Ibid., p. 90.
[11] Cfr. Id., Funktionswandel der Sinne (1940) e Funktionswandel und Gestaltkreis (1950), in Gesammelte Schriften, cit., III, pp. 577-594 e pp. 619-634.
[12] Id., Natur und Geist, cit., p. 73.
[13] Ibid., p. 74.
[14] Ibid., p. 76.
[15] Id., Der Gestaltkreis, dargestellt als psychophysiologische Analyse des optischen Drehversuchs (1933), in Id., Gesammelte Schriften, cit., IV, pp. 23-61, p. 23.
[16] Ibid.
[17] Ibid., pp. 23-24.
[18] Ibid., p. 24.
[19] Ibid., p. 25.
[20] Ibid., p. 26.
[21] Ibid., p. 32.
[22] Ibid., p. 28.
[23] Cfr. Id., Natur und Geist, cit., pp. 75-76.
[24] Cfr. T. Henkelmann, Viktor von Weizsäcker (1886-1957). Materialien zu Leben und Werk, Springer, Heidelberg 1986, p. 149.