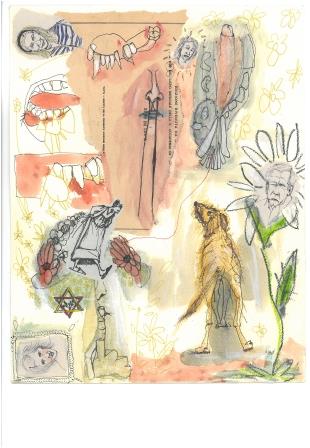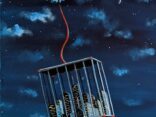Autore
Indice
- Premesse storiografiche
- L’equivocità della scienza tardo-medievale
- Lo schema linguistico
- Per una cartografia dei saperi: l’individualità del reale
S&F_n. 09_2013
Abstract
This essay considers synthetically forms and nature of philosophia naturalis in the Late Medieval Age, analyzing specifically the last work by Joël Biard focused on the philosophical and epistemological thinking of Jean Buridan. Magister artium at Paris, the French philosopher represents one of the most clear statement of the debate about science and logic in the university milieu in the XIV century.
- Premesse storiografiche
La frequenza con cui Joël Biard ci riporta alla lettura di temi scientifici nel pensiero medievale e, in questo caso, di Giovanni Buridano[1], ci consente di ravvisare, in trasparenza, la linea tematica del suo pensiero che pure si è sviluppato, in tutti i suoi lavori, anche su versanti storici vari e diversi da quello in cui si colloca la problematica del famoso Magister dell’Università di Parigi. La passione per l’esegesi, che avvince ogni studioso che si accosta a personalità e temi di carattere decisivo nello spazio culturale occupato dalla filosofia, rivela la sua fruttuosità allorché si esprime come interesse speculativo originario, cioè come domanda originaria ed essenziale, quella da cui lo studioso stesso deve essersi mosso in base a un’ipotesi da verificare; è il caso allora, di una vera e propria metodologia come logica applicata, che è la stessa operazione teoretica con cui si esprime la totalità della persona che la pone in atto.
La lettura del testo di Biard mi spinge a tornare brevemente a riflettere, ancora una volta, su quelli che potrebbero essere definiti i paradigmi scientifici tardo medievali e sulle tappe storiografiche fondamentali che ne hanno segnato le progressive rivisitazioni concettuali. La variegata plurivocità degli approcci, delle dottrine e degli esiti speculativi e culturali presenti nel tardo Medioevo, si è ormai indirizzata, negli ultimi anni, nella messa a punto di edizioni critiche e di traduzioni: tale rivisitazione ha condotto a una valutazione diversa sia dei testi già editi della philosophia naturalis del XIII e XIV secolo, sia di protagonisti meno noti, ora considerati come rappresentanti di un certo rilievo per intendere il processo evolutivo della problematica scientifica tardo-medievale. Tali ricerche confermano la necessità di un approccio sempre più testuale, libero da ogni forma di pregiudizi sottratto, finalmente, da quegli “anacronismi psicologici” messi in evidenza da Guy Beaujouan, in molteplici occasioni[2], anacronismi che hanno costantemente applicato alle elaborazioni scientifiche in particolare della tarda scolastica, categorie ermeneutiche improntate ai canoni della scienza moderna. Tale fu il caso, ad esempio, di Pierre Duhem che, nella prospettiva di un evidente continuismo, aveva addirittura individuato nelle condanne ecclesiastiche del 1277 pronunciate dal vescovo Tempier nei confronti delle 219 proposizioni contrarie alla fede cristiana, la nascita della scienza moderna[3], orientando i percorsi epistemologi coevi nella direzione di un rifiuto della fisica aristotelica e nella ricerca di nuovi sentieri di indagine[4]. Alla base della continuità tra pensiero scientifico medievale e rinascimentale vi sarebbe stata dunque persino la teologia cristiana della creazione, l’idea in base alla quale il mondo, creato da Dio ex nihilo, conserverebbe in filigrana l’impronta di dell’armonia prestabilita da Dio stesso, nei suoi caratteri di bene, ordine e razionalità.
Tale impostazione “continuista” fu ereditata, tra gli altri, da Anneliese Maier[5] e, in maniera ancor più significativa, da Alistair Crombie il cui saggio, pubblicato per la prima volta nel 1952[6], individua già nei testi di autori del secolo XIII i tratti portanti di quella metodologia della ricerca scientifica, che poi confluirà nella scienza moderna. Una tale ipotesi interpretativa suscitò la reazione di numerosi studiosi da Marshall Clagett a James McEvoy, ma la reazione più violenta fu espressa da Alexandre Koyré: a suo parere, infatti la scienza moderna, da Copernico a Galileo, è nata dalla condivisa polemica contro lo sterile empirismo degli aristotelici perché le matematiche, più che un metodo per ordinare i fatti, rappresentano la chiave stessa per la comprensione della natura[7].
Per venire a tempi più recenti, è doveroso perlomeno osservare che un approccio eminentemente storico-critico al problema di una corretta definizione del pensiero scientifico medievale, deve prendere le mosse da una circostanziata analisi dei testi che ne furono privilegiata espressione. In questa direzione si sono mossi gli sforzi di quanti, come Marshall Clagett e i suoi allievi[8], hanno ritenuto prioritario il lavoro di edizione dei trattati scientifici, privilegiando un percorso interno al testo stesso, ai suoi contenuti, alla rivisitazione profonda delle fonti, nello sforzo di di risolvere le difficoltà derivate dal linguaggio tecnico proprio delle scienze particolari.
Negli ultimi decenni, l’idea di un libero fluire del pensiero scientifico occidentale, senza soluzione di continuità, dal mondo classico all’età di Copernico, Galileo e Newton, ha ceduto il posto a una più attenta riconsiderazione della specificità della scienza medievale. Alterità, dunque, del medievale rispetto al moderno, e senso dell’alterità che la mentalità moderna deve tener presente e da cui deve partire per trovare quell’unico filo d’Arianna che ci permetta di entrare nello spirito generale degli autori della tarda scolastica. Tale percorso scientifico si svolge e si legittima all’interno di un ambito speculativo che tratta dei corpi, delle sostanze generabili e corruttibili, considerati nella loro dignità epistemologica, garantita dalla rivisitazione del concetto di aristotelico di scientia, alla luce delle nuove categorie rese disponibili dagli Analitici Secondi, dal sesto libro dell’Etica Nicomachea, dalle questioni proemiali di trattati di astrologia e medicina.
- L’equivocità della scienza tardo-medievale
Se dunque consideriamo ormai acquisito tale retroterra concettuale e storiografico, possiamo rilevare come, nel suo ultimo e voluminoso lavoro, la riflessione di Joël Biard, applicata al concetto di scienza, già del resto trattato in opere precedenti, ne ha ribadito il carattere di assoluta equivocità, laddove ha trovato in Giovanni Buridano, maestro della Facoltà delle Arti e due volte Rettore dell’Università di Parigi (1328-1340), argomenti e stimoli per procedere verso la determinazione dei nuclei teorici portanti che esprimono tale concetto. Abbiamo così gli elementi di un’ipotesi ermeneutica atta a rivisitare il discorso scientifico tardo-medievale, ma anche la teoria del conoscere, la logica e le condizioni di possibilità di una philosophia naturalis. In effetti tali elementi costituiscono una tematica unitaria che si impone oggi alla riflessione dei medievisti, nuclei tematici che hanno interessato il Biard nelle sue varie e precedenti opere.
Assumere dunque l’ultimo lavoro di uno studioso come chiave di lettura di quelli che lo precedono, significa rischiare di ridurre a sistema finalisticamente strutturato quella che può essere stata invece una continua ed elaborata ricerca, liberamente aperta alla possibilità, alla scoperta di nuovi codici e testi, il che avviene incessantemente nel caso della filosofia medievale. L’attenzione di questo studioso converge elettivamente su quegli aspetti della riflessione di Giovanni Buridano che, in termini immediati, fungono da cardine là dove il piano di svolgimento del pensiero deflette dal suo asse, secondo un’angolazione che viene poi a costituire l’inizio del piano di considerazioni ulteriore. Nel presentare il suo lavoro, Joël Biard lascia liberamente trasparire le variazioni di senso e di tono che sottendono la complessità stessa del concetto di scienza medievale che «conjugue d’emblée la dimension discursive de l’ἐπιστήμη grecque et la dimension intuitive de l’intellection, renforcée par le modèle de la vision intellectuelle chez Augustin»[9].
Proponendosi di indagare tale nucleo tematico sulla base di una stringente disamina dei testi di Buridano, Biard individua e conferma il concetto di scienza come quello che si radica innanzitutto nel problema essenziale del ruolo dei princìpi primi nell’ambito della dimostrazione scientifica, ereditato dalla tradizione aristotelica dei commenti agli Analitici. Risulta evidente che tale discorso presuppone un ambito di riflessione tanto più ampio e accuratamente ripercorso in tutti i suoi segmenti, fino a comprendere quello che concerne il rapporto con altri autori, innanzitutto con Guglielmo d’Ockham. A tale proposito Biard non trascura di sottolineare che l’idea della scienza in Buridano resta sempre quella di una disposizione mentale, di un habitus, che presuppone un fondamentale approccio linguistico in termini di significatio, di voces e di concetti, così come era ormai acclarato dalla rivoluzione semiologica occamista. Fin dalla prima parte del volume Biard si sofferma a porre in rilievo quell’aspetto «psicologico» della scienza che descrive le «modalità generali» di apprensione di qualsivoglia oggetto: si tratta di distinguere la scienza dall’opinione, entrambe però habitus adhesivus, secondo l’espressione dello stesso Buridano, sulla base dell’assenso a una proposizione riconosciuta come vera e tale struttura «reste constante et fondatrice, quelles que soient les variation d’usage dont est susceptible le mot “science”»[10]. L’analisi dei vari aspetti in cui si manifesta l’assenso permetterà poi di determinare la diversificazione dei modi dell’evidenza scientifica e in tale direzione di ricerca Buridano distingue la scientia simplex da quella congregata: la prima rappresenta una dispositio che si rivolge a una conclusione acquisita per dimostrazione, la seconda indica invece un insieme compiuto di conclusioni. La lettura che Biard conduce sulla questione del soggetto e dell’oggetto dei saperi scientifici è sicuramente atta a decifrare un punto essenziale di quella tradizione aristotelica in cui si colloca Buridano, quello del rapporto tra universalità e necessità: dalla critica all’innatismo, alla percezione del singolare «per modum existentis», l’atteggiamento di Buridano viene a enfatizzare quell’aspetto del primato della conoscenza intellettiva del singolare, che egli oppone decisamente alla posizione di San Tommaso fautore, com’è noto, del singolare come conoscenza unicamente riflessa. In tal modo «la combination des différentes sens de la science, leur déclination du plus strict au plus large, permet d’infléchir la science vers une prise en compte fine des choses contingentes, singulières, périssables»[11].
- Lo schema linguistico
Senza dubbio, però, la teoria della significatio e in particolare il tema della suppositio dei termini, costituiscono l’apporto più rilevante offerto alla storia della semantica dai filosofi medievali il cui orizzonte concettuale è contrassegnato dalla tendenza a significare la realtà: su tale orizzonte si fonda la scienza, abito acquisito per via sillogistica, che colloca l’uomo in contatto con oggetti reali, e lo sottrae alle ipostatizzazioni di una tradizione che aveva fuso l’aristotelismo con elementi delle correnti platoniche, greche e arabe. Ci troviamo di fronte, nella logica tardo-medievale, ai vari sviluppi di quella semantica estensionale che però, nella seconda metà del XIII secolo, sembra subire all’Università di Parigi un’indiscutibile flessione a favore dell’approccio modista, esteso dalla grammatica alla logica. Esemplare, in questo caso, la posizione in cui Biard colloca Buridano, che conobbe com’è noto grande fama proprio come logico: nelle Summule logicales egli fa appello alla distinzione tra una grammatica positiva, anteriore alla logica, e una grammatica regularis per introdurre il dibattito sulla teoria dei modisti: a suo parere infatti i modi significandi non possono essere derivati dai modi d’essere, come sostenevano i modisti che concludevano sovente le loro tesi in argomentazioni sofistiche. Buridano fa qui esplicito appello a un doppio livello di significatio e «une telle approche fait du concept le signifié premier du mot et de la chose sa signification seconde ou médiate»[12].
Le discussioni sul sermo e sulla vox, sul concetto come proposizione mentale, e dunque sull’ambito concettuale riorganizzato sulla base di uno schema linguistico, rappresentano poi il terreno su cui mettere alla prova la centralità della suppositio, vale a dire la definizione dell’ambito di riferimento originario dei termini e gli effetti riconosciuti al contesto nella modifica di questo stesso ambito. In tale prospettiva le questioni discusse nei capitoli successivi, relative alla teoria della dimostrazione scientifica, al concetto stesso di principio, estremamente impegnative e costruite su una rigorosa esegesi dei testi, consentono a Biard di proporre una sua particolare interpretazione a proposito del nesso di temporalità e causalità nel processo dimostrativo: Buridano sembrerebbe spingere fortemente nella direzione di una dimostrazione matematica per la quale lo schema aristotelico delle cause, applicato allo studio della natura, si mostra inadeguato e ciò per il fatto che le matematiche, al contrario, non dimostrano né a partire dalla causa efficiente, né da quella finale e le stesse idee di materia e forma, in tale ambito, sono assunte solo in senso metaforico. L’analisi della diversità e della pluralità dello statuto dei principi rappresenta inoltre una tappa obbligata per Buridano nel suo rapporto con Nicola d’Autrecourt, maestro a Parigi dal 1326 al 1340, in relazione all’esigenza della reductio a un unico principio della teoria delle inferenze, in particolare quelle di tipo esistenziale (ad esempio si a est, b est) o relative alla causalità. In realtà, come suggerisce efficacemente il Biard, è l’intera teoria della conoscenza che si oppone a quella di Nicola d’Autrecourt: «alors que pour Nicolas les idées sont indépendantes du sensible, pour Buridain le sensible est le point de départ de la connaissance scientifique, et il rappelle ici l’adage péripatéticien selon lequel à qui manque un sens, une science fait défaut»[13].
- Per una cartografia dei saperi: l’individualità del reale
Nella terza parte del volume il passaggio alla conoscenza del mondo sulla base dell’epistemologia dell’individuale avviene sulla linea della continuità, considerato che l’iter speculativo di Giovanni Buridano viene visto da Biard sempre in rapporto con le sue dottrine gnoseologiche e con la sua analisi del linguaggio, vale a dire con il suo terminismo; emerge qui in particolare la sua scelta per l’intrinseca individualità del reale, l’esclusione dell’universale in re, e ciò per il fatto che l’universalità dei concetti può essere spiegata senza far ricorso a una corrispondente universalità extramentale. La filosofia, a parere di Buridano, non è più, come voleva la tradizione aristotelica, conoscenza delle cose umane e di quelle divine, ma è «fondamentalement connaissance naturelle et humaine»[14]. La nozione di singolarità, che rappresenta la connotazione naturale di tutta la teoresi di Giovanni Buridano, viene subito presa in esame da Biard ed è seguita nella sua funzionalità sin dalle Questiones sulla Metafisica aristotelica dove viene posto il problema del suo significato in rapporto alla critica del realismo degli universali. Tra le altre considerazioni che Biard propone nella sua disamina, segnaliamo quella per cui – proprio in virtù del fatto che il mondo si compone di individui e del rifiuto della dimensione metafisica della questione dell’individualità – occorre concludere che è possibile una scienza degli accidenti. Tale questione fondamentale è posta in rapporto al sesto libro della Metafisica, laddove Buridano solleva il problema stesso dell’equivocità sia del concetto aristotelico di sostanza che di quello di accidente.
La lettura che il Biard conduce delle Quaestiones di Buridano sull’Etica Nicomachea è attenta a dispiegare il suo problema lungo l’importante direttrice del confronto teorico con il dibattito coevo relativo alla divisione delle scienze. Pur partendo dalla tripartizione aristotelica secondo la quale le scienze teoretiche sono la metafisica, la matematica e la fisica, Buridano rompe decisamente con il concetto di scienza costruita a partire dal genere su cui si fonda, e ne propone un altro, alternativo al precedente, che la considera, nell’ambito di una vera e propria «cartografia dei saperi»[15], come un semplice punto di vista. Si ripropone così alla nostra attenzione l’ampia disamina del concetto di metafisica come scientia prima, la relazione tra scientia e sapientia, l’idea della metafisica stessa come scienza certissima; ciò non toglie che lo sviluppo stesso della tesi per cui metafisica, fisica e matematica trattano delle stesse res, considerate però da punti di vista diversi, conduce Buridano a sottolineare il valore particolare delle matematiche il cui soggetto principale è il quantum della res.
Nel trattare dei problemi relativi alla definizione del movimento e al concetto fisico di infinito, Biard ci fornisce elementi preziosi ed esaurienti circa l’altezza dei toni e la vigoria espressiva raggiunta da Buridano nel campo del dibattito dottrinale sulla natura del movimento al quale egli conferisce un particolare statuto ontologico, ma ciò avviene in modo assai problematico se consideriamo il retroterra di un’ontologia dichiaratamente nominalista. Estremamente significative le pagine con cui Biard chiude il capitolo dedicato alle teorie elaborate da Buridano nell’ambito della philosophia naturalis, che lo vedono sostanzialmente vicino alle posizioni degli aristotelici radicali della facoltà delle Arti, e alla loro rivendicazione a operare nel dominio filosofico in autonomia da condizionamenti o presupposti normativi esterni alla scienza. Ciò non indica, peraltro, porsi apertamente in contrasto con la fede, anzi sostenere di volerla considerare sempre criterio ultimo della verità. In tal modo l’invito a non porre mai in contrasto la necessità di una argomentazione filosofica, pur corretta, con i contenuti della rivelazione, i cui enunciati riguardano la realtà soprannaturale, che eccede i confini della scienza, legittima, nello stesso Buridano, la distinzione degli ambiti di studio e la diversità degli oggetti. Nell’orbita speculativa di questa importante differenziazione non sorprende allora l’introdurre quella nuova e positiva valutazione del ruolo del naturaliter loquendo, del tutto idoneo a offrire informazioni pienamente attendibili su una realtà che è costituita essenzialmente da individui. La problematica epistemologica di Buridano riceve così un senso profondo solo se la separazione della sfera del discorso de naturalibus dalla metafisica e dalla teologia venga considerata a partire dall’intelligenza dialettica di quella particolarissima epistemologia e gnoseologia empirista che la governa. Così risulta pienamente accettabile che, nel linguaggio messo in opera da Buridano, venga recuperata una visione del mondo in cui il primato originario dell’individuale, fondamento dell’evidenza e della certezza relativa alle realtà particolari e contingenti, rappresenta una tesi straordinariamente feconda di sviluppi, a partire dall’ammissione di un rapporto diretto e immediato tra l’oggetto e le facoltà conoscitive dell’uomo, tanto del senso, quanto dell’intelletto. In tal modo, Buridano si inserisce autorevolmente nell’ambito del dibattito sulla problematica scientifica tra XIII e XIV secolo e radicalizza gli sviluppi di quel nuovo atteggiamento speculativo a partire dal quale divenne di primaria importanza stabilire i caratteri, determinare la natura, analizzare gli effetti della conoscenza diretta del singolare.
Ciò non toglie, tuttavia, come osserva in conclusione il Biard, che proprio la teoria dell’induzione, che serve a stabilire i principi della demonstratio in fisica, debba necessariamente rinviare a quello che egli definisce un orizzonte metateorico e fondatore, da lui individuato nell’ordine regolare della natura: «un tel odre, constitué par un tissu de relations causales, producteur de nécessité conditionelle dès lors qu’on exclut méthodologiquement et les résultats d’actes faits par volonté libre, explique à la fois les régularité dans la nature et l’évidence secundum quid qui s’y attache»[16].
Le linee di ricerca cui ho accennato in tale sede restano comunque in fieri e impongono sempre la massima prudenza ermeneutica, a maggior ragione se pensiamo che Buridano, nello sviluppare posizioni filosofiche nuove e alternative, instaurò un dialogo continuo con la molteplicità degli apporti culturali della tarda Scolastica, oltre che, naturalmente, con Ockham e con la sua scuola. In ogni caso il dibattito scientifico che egli sviluppa rappresenta, insieme con l’intera riflessione sugli altri fondamentali temi della tradizione aristotelica tardo-medievale, l’espressione di un’identica esigenza speculativa: il tentativo di determinare con precisione quel modello scientifico in cui il progresso delle scienze, e innanzitutto di quelle matematiche e logiche, possa misurarsi col rigore del loro metodo e con l’evidenza dei loro principi, nel distacco totale da ogni possibile considerazione realista e metafisica della scienza stessa come conoscenza della causa sostanziale prima.
[1] J. Biard, Science et nature. La théorie buridannienne du savoir, Vrin, Paris 2012.
[2] G. Beaujouan, L’histoire des sciences est-elle, pour le moyen age, porteuse d’anachronismes psycologiques?, in «Bulletin de philosophie médiévale», 39, 1997, pp. 23-30.
[3] P. Duhem, Le système du monde, Hermann, Paris 1913-1959, vol. VI, pp. 3-69.
[4] Sulla figura e l’opera di Duhem, cfr. perlomeno J. E. Murdoch, Pierre Duhem and the History of Late Medieval Science and Philosophy in the Latin West, in Gli studi difilosofia medievale fra Ottocento e Novecento. Contributo a un bilancio storiografico, a cura di R. Imbach – A. Maierù, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1991, pp. 253-302.
[5] A. Maier, Zwischen Philosophie und Mechanik. Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, Ed. di Storia e Letteratura. Raccolta di studi e Testi 69, Roma, 1958.
[6] A. Crombie, Augustine to Galileo: the history of science A. D. 400-1650, (1952), tr. it. Milano 1982.
[7] A. Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, Paris 1966, p.66 sgg.
[8] Per una bibliografia esaustiva sulla scienza tardo medievale si veda J. Biard, op. cit., pp. 373-386.
[9] Ibid., p. 8.
[10] Ibid., p. 22.
[11] Ibid., p. 89.
[12] Ibid., p. 103.
[13] Ibid., p. 205.
[14] Ibid., p. 236.
[15] Ibid., p. 350.
[16] Ibid., p. 368.