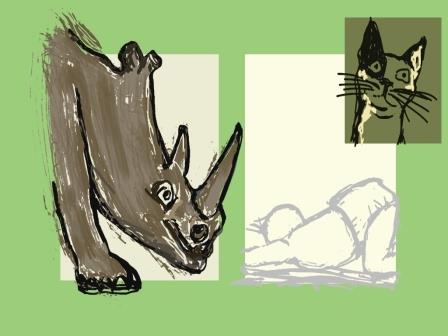Autore
Indice
- Oddio... mi sono perso la realtà!
- E meno male che c’è il realismo
- Sospetti e inviti
S&F_n. 09_2013
Abstract
Through the analysis of some proposals called “New Realism”, this paper tries to ask questions about its theoretical system. Because of the inner opacity, the rediscovery of realism drags into the argument the Philosophy, once again.
Will we be able to answer?
Siamo di fronte alla verità, di quando in quando; possono passare dieci, quindici anni, prima che un movimento non ci rimetta di fronte a lei, non necessariamente in un sovrappiù di luce, può essere notte fonda, può esserci un braciere fumoso
– e muri di rocce, e muri di libri – nulla può essere d’ostacolo: quindi, non è la verità che è lì di quando in quando, ma siamo solamente noi ad essere non so dove la maggior parte del tempo.
Henri Thomas, The perjury
- Oddio... mi sono perso la realtà!
Ci sono mille eccellenti motivi per essere realisti, non ultimo il fatto che la realtà è poco interessata a nostri eventuali motivi contrari […].
Non essere realisti equivale, in buona sostanza, a essere dei cretini. Ma, allora, come si spiega che tante persone intelligenti siano contrarie al realismo, che anzi, alla fine, sembri che a essere realisti siano buoni tutti, e che la filosofia, l’intelligenza, la scienza, abbiano inizio proprio nel momento in cui si smette di essere realisti?[1]
Qualsiasi sia la reazione istintiva all’interrogativo proposto, se, in effetti, in maniera più o meno dichiarata, ci si attivi all’istante in quella sorta di fermento e concitazione mentale al fine di soppesare milligrammi di realismo quotidiano, il tutto per effettivamente registrare se si è dalla parte degli ottusi tardivi o degli ingegnosi raziocinanti, la questione sottesa, la questione del realismo, di là appunto dalle cretinerie d’occasione e\o sagacie di lunga durata, è seria e concerne, riferendovisi dichiaratamente, addirittura a una vera e propria «trasformazione che ha investito la cultura filosofica contemporanea»[2] dacché – e specie per tutti quelli i quali, sinora, hanno vissuto nell’inconsapevolezza – «il realismo è la strada maestra della filosofia»[3].
Questione seria e davvero epocale, allora e che, esplicitamente, interessa di sé investendola criticamente in pieno, la presunta e vanagloriosa, ma sapientemente sostenuta dal punto di vista filosofico, “negazione del mondo” che inizia e concresce a dismisura attorno alla «tesi secondo cui il mondo è costruito dai nostri schemi concettuali, da cose che abbiamo in testa o addirittura che ci hanno raccontato da bambini o ci hanno insegnato a scuola, e che influirebbero sulle forme e i colori che vediamo, sugli odori e i rumori che sentiamo, sul liscio e sul ruvido e lo striato»[4].
In altri termini, detta “negazione del mondo” quale anche, e soprattutto, dissoluzione dell’oggettività o, finanche, della realtà stessa, sarebbe il frutto avvelenato ingoiato e nuovamente rigurgitato da quelle filosofie novecentesche che, autentiche pantomime speculative, dalla prospettiva del post-modernismo di Lyotard al pensiero debole di Vattimo, dall’ermeneutica ontologica post-gadameriana ai nietzschianesimi d’ogni specie e sorta, dai proto-heideggerismi e sino anche a certe derive decostruzioniste vetero-derridaiane, sono sostanzialmente riconducibili a una doppia semenza.
A una doppia viziata semenza: una riferibile a Immanuel Kant e alla sua indicazione in ragione della quale se la conoscenza non può che avere inizio per il tramite dell’apparato sensoriale e, tuttavia, è davvero tale solo in quanto è stabilita-stabilizzata da schemi concettuali, indipendenti dunque dal contingente dell’esperire e, indi, letteralmente a priori. Vero e proprio «collasso della ontologia (quello che c’è) sulla epistemologia (quello che sappiamo a proposito di quello che c’è)»[5] e che rinviene già, in una intensa pagina dei preliminari della Logica Trascendentale, i suoi intimi motivi, laddove è precisato che
la nostra conoscenza trae origine da due sorgenti fondamentali dell’animo, di cui la prima consiste nel ricevere le rappresentazioni (la ricettività delle impressioni), e la seconda è la facoltà di conoscere un oggetto per mezzo di queste rappresentazioni (spontaneità dei concetti). Attraverso la prima, un oggetto ci è dato, attraverso la seconda esso viene pensato in rapporto a quella rappresentazione (come semplice determinazione dell’animo). Intuizione e concetti costituiscono pertanto gli elementi di ogni nostra conoscenza; non ci può dunque esser data la conoscenza né dai concetti senza un’intuizione che corrisponda ad essi in qualche modo, né dall’intuizione senza concetti. [...] I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche[6].
Se qui, come è del tutto chiaro, lo scossone dato all’ontologia davvero sembra assumere i connotati di un critico cedimento dell’essere nel gorgo famelico del conoscere, del conoscere nell’ottica del trascendentale, ovvero di quell’automatismo formale della conoscenza stessa, tant’è che, esplicitamente, il fuoco problematico si dirotta dal “che cosa” al “come”, non v’è dubbio anche che, con gli sviluppi del neokantismo tardo ottocentesco e novecentesco, con i vari Cohen, Natorp e Cassirer, a tinte e sfumature diverse, e tuttavia sotto la comune inesorabile spinta dell’ulteriore assorbimento della cosa-in-sé, del prosciugamento del “pensare” nel “conoscere”, il “quello che c’è” ha assunto le fattezze di “quel che sappiamo”.
Parte della scienza contemporanea, è inutile sfumare, in certo qual senso ha proceduto in direzione e virato, nell’alternarsi straordinario di performanti traccianti fatti di paradigmi decifrativo-conoscitivi mai così penetranti come nell’ultimo secolo e mezzo, lungo questa strada.
Ciononostante, se nelle intime trame di questa direttrice critica dei nuovi alfieri del realismo al massimo ci si può spingere a evidenziare, e comunque non senza problematiche accelerazioni di lettura, un pervicacemente inseguito (e raggiunto) disconoscimento di un essente-presente quale immediato-dato, giacché il dato è, appunto, il frutto di una costruzione progressiva in direzione non di una oggettività, ma di una oggettivazione che rimane sempre un aperto, e pressoché mai concluso, oggettivarsi, quel che a questa complessa e poliedrica prospettiva non può esser certo imputato è quella forma di netto “rifiuto” che vuol dire dissoluzione della realtà.
Quel che risulta respinto, da Kant in poi, è qualsiasi forma concepibile e declinazione possibile di un immediato-disvelativo del rapporto con l’oggetto, non certo il “mondo nella sua cosalità”. Anzi e di più, le scienze coeve, anche quelle più a rischio di un tal tipo di imputazione quali, per esempio, la fisica dell’indeterminato e/o dell’immateriale, nel loro sforzo continuo di “costruire mondi”, procedono proprio in direzione di quella che potrebbe essere la versione che più si approssima alla effettività del mondo che è dinanzi a noi dimostrandosi, dunque, nell’impresa di riduzione del margine di errore rispetto all’oscuro diretto per il tramite di costanti riassetti del cognitivo, tutt’altro che impegnate a volerlo perdere.
Non a caso, quindi, si diceva di una doppia viziata semina.
E già, perché dell’altra rovinosa seminagione, quella decisamente tesa al “rifiuto” quale dissoluzione della realtà, un centinaio d’anni dopo rispetto alla Critica della ragion pura, è stato responsabile Friedrich Nietzsche allorquando, nel sentenziare il crepuscolo d’ogni idolo della metafisica in ordine al quale il mondo vero si fa favola e, in buona sostanza menzogna, ha argomentato sul nostro nuovo “infinito”:
oggi [...] siamo lontani dalla ridicola presunzione di decretare dal nostro angolo che solo a partire da questo angolo si possono avere prospettive. Il mondo è piuttosto divenuto per noi ancora una volta “infinito”: in quanto non possiamo sottrarci alla possibilità che esso racchiuda in sé interpretazioni infinite. Ancora una volta il grande brivido ci afferra – ma chi mai avrebbe voglia immediatamente di divinizzare ancora, alla maniera antica, questo mostruoso mondo ignoto? E di adorare forse, da questo momento, questa cosa ignota come “colui che è ignoto”? Ah, in questo ignoto sono comprese troppe possibilità non divine d’interpretazione, troppa diavoleria, scempiaggine, bizzarria d’interpretazione – quella nostra umana, anche troppo umana, interpretazione, che conosciamo...[7]
Dove il difetto, allora, da cui il frutto avvelenato ingoiato e nuovamente rigurgitato da buona parte delle filosofie novecentesche qual è il diniego/rifiuto del mondo quale dissoluzione dell’oggettività o della realtà stessa?
Anzitutto, e come si accennava, proprio con Kant inizia ad articolarsi una filiera speculativa in ordine alla quale la consapevolezza dell’essere, in qualche modo, dipende dal conoscere, in cui lo snodo decisivo dell’essere-sapere tende a risolversi nell’amalgama dell’uno nell’altro, finanche nell’assorbimento dell’essere nel sapere. Dal che, vera e propria “fallacia trascendentale” in cui «il problema è [...] che Kant intendeva che fossero necessari concetti per avere una qualsiasi esperienza, ossia che serva un concetto anche per scivolare su una lastra di ghiaccio. Il che non solo è falso in sé, ma dà avvio a un processo che conduce a un costruzionismo assoluto»[8].
Ma, appunto, almeno per Kant, “fallacia”.
E già, perché è stato proprio Nietzsche a compiere, in una contiguità riflessa nel solco kantiano, il passo ultimo e più radicalmente distruttivo: quello dell’oggettività.
Passo ultimo e più radicalmente distruttivo, dunque, dell’ontologia (quello che c’è) e, indi, della realtà, quello che c’è a prescindere da ànthropos che, anzi, proprio perché non è egli stesso un soggetto-dato, letteralmente non c’è se non in particolari condizioni. Fondamentalmente (e semplicemente) quelle in ordine alle quali «il commediante del mondo»[9], da «aeterna veritas» quale «entità fissa in ogni vortice, come una misura certa delle cose»[10], si riscopre vitale capacità metaforica. Per cui: proprio perché «noi crediamo di sapere qualcosa sulle cose stesse, quando parliamo di alberi, di colori, di neve e di fiori, eppure non possediamo nulla se non metafore delle cose che non corrispondono affatto alle essenze originarie»[11], tant’è che la verità è «un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi», «illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria»[12], non se ne può che concludere che «ciò che distingue l’uomo dall’animale dipende da questa capacità di sminuire le metafore intuitive in schemi, cioè di risolvere un’immagine in un concetto»[13], di risolvere, ogni volta e daccapo, anche se stessi in tutto questo.
Passo ultimo e radicalmente distruttivo tant’è vero che Nietzsche, già nell’annunciare il primo sbadiglio della ragione, indicando in direzione di un’estremizzazione di quel «mondo vero, inattingibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una consolazione, un obbligo, un imperativo. (In fondo l’antico sole, ma attraverso nebbia e scetticismo; l’idea sublimata, pallida, nordica, königsbergica)»[14], non poteva che decidersi, puntando preciso, per l’eliminazione non solo di questo stesso mondo vero, ma anche del mondo apparente, giacché «separare il mondo in uno “vero” e in uno “apparente”, sia alla maniera del cristianesimo, sia alla maniera di Kant (in ultima analisi, uno scaltro cristiano), è soltanto una suggestione della décadence – un sintomo di vita declinante»[15].
In altri termini, nulla è più ascrivibile alle caselle dell’ovvio, del palese, del manifesto, dell’incontestabile. E dunque, una forma di reazione è necessaria anche e soprattutto perché tutto questo non ha voluto dire, come la storia recente e recentissima ha dimostrato, la liberazione “dai vincoli di una realtà troppo monolitica”, bensì la letterale polverizzazione in mondi semi-veri che ha significato, in special guisa nelle sue ultime declinazioni, l’imporsi di un «populismo mediatico» da cui e per cui «si può pretendere di far credere qualsiasi cosa», un surrogarsi senza soluzione di continuità di realtà che, “realitysmo” disorientante e demolitore, non solo revoca «qualsiasi autorità al reale, e al suo posto imbandisce una quasi-realtà» a spiccate tinte ciarliere e menzognere ma, soprattutto, impone (auto-)distruttivamente che «non c’è niente da realizzare, e dopotutto non c’è nemmeno niente da immaginare; si tratta, al contrario, di credere che la realtà sia come un sogno che non può far male e che appaga»[16].
Simmetrie dispiegate, senza valore e senza possibilità di valorazione se non nell’ottica di un conveniente – ed evidentemente autoriferito – relativizzarsi assoluto che si traduce inesorabilmente in relativismo epistemico, in relativismo concettuale, in relativismo etico, ovvero in un vero e proprio «antirealismo magico»[17] che, ingannevole, sottende solo una «dottrina programmaticamente parassitaria»[18].
- E meno male che c’è il realismo
Il problema sostanziale e di fondo è, allora: quale reazione è possibile e ragionevole al cospetto dell’acidamente corrosivo del diniego/rifiuto radicale con cui i kant-nietzschismi del XX secolo avrebbero letteralmente avvelenato i pozzi fino a condurre «a forme di esplicito nichilismo teoretico e morale»[19]?
Ma come?
Il sano ritorno della realtà e, si badi bene, non alla realtà. Giacché il mero e banale ritorno-a sortirebbe solo l’effetto, e quindi contrariamente alle intenzioni di fondo, di soccombere a «una concezione severamente scientistica dell’uomo e della sua prassi», ovvero arretrare (e di nuovo) in direzione dei modi di «uno spietato oggettivismo» abile solo a elaborare «tanto l’incapacità di comprendere la prassi umana quanto il cedimento ad un naturalismo oltranzista che riduce tutto a serie causali in cui dell’essere umano non ne è più nulla»[20].
Qui si tratta del ritorno della realtà, dell’irrompere di un «mondo esterno» che si fa «vivo senza aspettare che i nostri schemi concettuali siano pronti ad accoglierlo»; dell’ingresso di un paradigma in ragione del quale questo stesso “mondo esterno”, che si rinviene «in tutto ciò che non è emendabile», non essendo «a disposizione dell’interprete», letteralmente «non lo si può cambiare col pensiero»[21], a partire dal pensiero.
Il ritorno, per questo, di quel plesso di atteggiamenti concreti e movenze speculative che focalizzino e facciano perno, sempre, in una vigorosa e inalterabile stiratura e compressione ai fatti e che, quindi, consentano valutare situazioni e cose nella loro concretezza ed effettività.
Tutt’altro che sconsiderato e sprovveduto «materialismo», il ritorno della realtà è invece imprescindibile richiamo e appello alla «densità delle esperienze fondative primarie»[22].
Il ritorno del sano, vecchio realismo, verrebbe fatto di concludere, ovvero l’effettivo di un deciso rinvio a una accezione di corrispondenza che ammette solo una mera illustrazione nei termini propri di una chiarificazione della verità stessa nella sua tangibile possibilità e nelle sue vitali articolazioni.
Ovviamente, non così dichiaratamente.
Ma come che sia, sulle macerie dell’iper-costruzionismo di matrice kantiana e della conseguente iper-relativizzazione interpretativa di marca nietzschiana, si rende necessario un modo dell’orientamento che proceda sicuro e spedito in direzione di un “innovato realismo” che di queste avventure – comprese quelle metafisicheggianti e creazionistiche da cui anche il vecchio realismo – faccia tesoro al punto da produrre moti reattivi a qualsiasi lusinga ritornante di ulteriori agenti infettivi disgregatori a venire.
“Innovato” allora, stando così le cose, vuol dire anzitutto che «il realista [...] sostiene che non è vero che tutta la realtà è socialmente costruita, come viceversa affermano gli amici delle interpretazioni, che proprio su quella base possono affermare che l’ermeneutica [...] è un fenomeno universale»[23].
E “innovato” vuol anche significare, nella forza dell’evidenza dispiegata, dell’evidenza che persino si auto-dispiega, che «le domande filosofiche o scientifiche o religiose o politiche davvero rilevanti sono tutte collegate al problema della realtà da assegnare a questa o quella cosa»[24].
E “innovato” vuol anche dimostrare che una tradizione è «nuovamente in movimento» dacché «così deve essere in quanto diversi fattori spingono a riprenderne il tema», laddove “riprendere”, e ciò deve essere ben compreso, vuol significare «non solo tornare a considerare ma pure far emergere le virtualità inespresse di una tradizione imponente»[25].
E “innovato” vuol anche rivelare che i diversi fattori che spingono e che, a titolo vario, rinvengono «principali aree di criticità della filosofia dell’ultimo mezzo secolo (e anche più)», impegnano in «un movimento di rinascita» che è «una reazione», un opporsi-a che implica principalmente «riprendere il discorso metafisico dopo un lungo periodo in cui l’obiezione antimetafisica e postmetafisica è risultata particolarmente estesa»[26].
Come non convenire e, indi, cedere a tale inconfutabile assennatezza che, vibrante, si oppone al disfacimento.
Come non ripartire, dunque, da tale evidente equilibrio e buonsenso.
Come non far propria e disporre, in ogni piattaforma filosofica a venire, di questa «nuova disponibilità nei confronti del mondo esterno, di un reale che esorbita dagli schemi concettuali, e che ne è indipendente», di un’autentica “svolta ontologica” che, a partire dal riconoscimento della fallacia trascendentale, del potenziale disgregativo del prospettivismo radicale, vuol significare «rilancio dell’ontologia come scienza dell’essere», scienza «della molteplicità degli oggetti [...] che costituiscono un ambito di analisi non necessariamente subordinato alle scienze della natura»[27].
Come non mettersi in scia, perciò, di una sì viva sterzata che volendosi ulteriormente modulare nei termini di una gnoseologia innervata dall’«idea che le cose possiedono una loro “essenza” e intelligibilità che la nostra mente può cogliere» e sostenuta dalla certezza che «il concetto non rappresenta ma presenta direttamente l’oggetto, la sua essenza o forma»[28], fonda nell’immedesimazione tra essere e realtà.
- Sospetti e inviti
Non c’è dubbio che i discendenti a vario titolo di Heidegger potrebbero da subito evidenziare, nelle trame strutturali dell’innovato realismo, il rischio incombente e imminente dello slittamento in una sospetta e anonima ontico-logia quale precipitato disposto, e muto, di un ciò che è per come è comunque dimentico di un qualsiasi stato di retro- o pre-riferimento tale da render trasparente un ente nel suo essere, tant’è che questa «ontologia naturale» è, persino esplicitamente, «teoria dell’inemendabilità»[29] ovvero, più che sistema, pratica del «fatto che ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il mero ricorso a schemi concettuali» giacché «l’inemendabilità si manifesta come un fenomeno di resistenza e di contrasto» che, appunto, «non [...] si può correggere»[30].
Poi, se da Heidegger ci si è riusciti a emancipare, è possibile avanzare un sospetto persino più conturbante in ragione del quale questa innovazione che si muove, intenzionata, partendo da una concezione e accezione d’essere quale darsi naturalmente non a partire semplicemente dalle cose ma le cose stesse, apre a un senso dell’intenzionare che facendo a meno dell’interrogante e, indi, anonimato assoluto, accenna già in direzione di un umbratile minaccioso. Quello in conseguenza del quale davvero la bruma del Neutro, ancor più opaca e opacizzante di quella delle “ontologie fondamentali”, s’avanza.
Ma come che sia, un rilancio che dice e implica sia «un uso dell’ontologia come base per la formulazione di teorie dell’esperienza», sia anche il performante «di un’ontologia finalizzata alla costituzione di classificazioni ben formate», ovvero di una (nuova) organizzazione del mondo e dei suoi oggetti in cui e per cui il realismo è il «tratto proprio» dacché se «l’essenziale è la realtà con la sua durezza», «questa» stessa «durezza è l’ontologia»[31].
Qui il passaggio è sottile, ma la deduzione è ovvia: se «il mondo è pieno di oggetti che non si risolvono semplicemente nel linguaggio, ci sono fatti che non si dissolvono nelle interpretazioni»[32], se, in altri termini, si è deciso per i motivi in precedenza addotti che non è più possibile derogare da questo assunto realistico, l’innovato realismo che invoglia, ardente, questa svolta ontologica, sta a significare che
per quanto riguarda il problema della teoria dell’esperienza, il primo gesto è riconoscere quei caratteri nativi dell’esperienza che sono irriducibili alla scienza, e in particolare il fatto di essere inemendabile e in larga parte impenetrabile all’azione degli schemi concettuali. Questa circostanza, ben lungi dal depotenziare la scienza, ne costituisce il vero fondamento: si ha scienza quando si ha scienza di qualcosa, e non autoreferenza di schemi concettuali. D’altra parte, riconoscere un’esperienza indipendente dalla scienza ci permette anche di risolvere il problema, altrimenti insolubile, del fatto che possiamo avere un rapporto soddisfacente con il mondo anche con conoscenze molto modeste, o addirittura sbagliate[33].
Ma, e qui il sospetto si fa convinzione, quello del realismo è, specie nelle congiunture di massimo squilibrio e/o disfacimento come l’epoca attuale sembra restituire, assillo che si riaffaccia, «ritorno»[34], gesto riflesso, reattivo che, proprio perché costitutivamente “tentazione” priva di riserve, «come le vere tentazioni, è qualcosa che ritorna e ci tormenta». Ragion per cui, a voler essere davvero pragmatici e disincantati, non ci si può esimere dal «fare i conti con la realtà di questa permanente tentazione»[35], anzitutto e per lo più, per i valori esiziali di cui prima.
E qui “farci i conti” non può voler dire “far da conto” e sottolineare, e finanche stanare, volta per volta, a guisa di agente decontaminante, sviste, imprecisioni, forzature di lettura e docodifica nel mentre dello strutturarsi dell’impianto critico da cui prende le mosse questo “innovato realismo”. Quello specialistico, quello dello specialista-di, non tanto paradossalmente, rischierebbe essere infatti certosino lavoro più teso e rispondente a quel criterio di falsicabilità che, dunque, nel passare al setaccio una teoria, perseguirebbe – e nel caso specifico, anche involontariamente – il fine auspicato dai suoi propugnatori dell’inconfutabile.
Si diceva, dunque: è necessario fare i conti con la realtà di questa permanente tentazione. Cosa questa che non può neppure voler dire “fare i conti” con l’ammorbante e contagiosa realtà – specie tra i cosiddetti addetti ai lavori che sino a non molto tempo fa, seriosi e determinatissimi, si dichiaravano antimetafisici, decostruzionisti, etc. – del complessivo esonerante di questa seduzione istigatrice e/o seducente istigazione.
Il punto, piuttosto, è venir in qualche modo a capo del problematico sotteso in ogni tentativo speculativo che forzi, in modi e maniere più meno dichiarate, in direzione del riflusso reazionario nel cono d’ombra della monopolistica e monistica alterata idea di rispecchiamento della cosa, della natura, dell’Intero, quale anche e soprattutto un esser-riflesso e un esser-adeguamento/adattamento dei/ai fatti che traluce una definitività paradigmatica che strizza l’occhio (comunque e sempre) all’Auctoritas de La Verità.
E allora, più che gioire per questo ritorno della realtà, bisognerebbe augurarsi che sia la filosofia a rimpatriare, a tornare al centro e cimentarsi con questa prospettiva reazionaria. Cimento che dovrebbe dire, principalmente, muoversi in direzione del vero obiettivo mirato, in maniera non meramente dichiarata bensì compiutamente incarnata, dall’“innovato realismo” la cui prospettiva teorico-pratica, in un avvitamento senza precedenti relativamente alle versioni-conversioni e proposizioni d’ànthropos, assomma una potenza di fuoco che espone a rischio letale. Che è “rischio letale”.
Dunque: bentornata filosofia?
[1] M. Ferraris, Le caverne di Paolo, Introduzione a P. Bozzi, Un mondo sotto osservazione. Scritti sul realismo, Mimesis Edizioni, Milano 2007, pp. 11-20, in particolare, p. 11.
[2] Id., Manifesto del nuovo realismo, Editori Laterza, Roma-Bari 2012, p. 27.
[3] V. Possenti, Realismo diretto e verità, in A. Lavazza e V. Possenti (a cura di), Perché essere realisti. Una sfida filosofica, Mimesis Edizioni, Milano 2013, pp. 19-49, in particolare, p. 19.
[4] M. Ferraris, Le caverne di Paolo, cit., p. 12.
[5] Id., Esistere è resistere, in M. De Caro e M. Ferraris (a cura di), Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, Einaudi, Torino 2012, pp. 139-165, in particolare, p. 146.
[6] I. Kant, Critica della ragion pura (1781), [A 50-51/B 74-75], tr. it. TEA, Milano 1996, pp. 92-93.
[7] F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina (1887, 2a ed.), tr. it. Adelphi, Milano 1992, pp. 309-310. Ovviamente faccio riferimento alla seconda edizione della Gaia scienza dacché l’aforisma in oggetto, il 374. Il nostro nuovo “infinito”, che è nel Libro V, Noi senza paura, non compare nella edizione del 1882.
[8] M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 34.
[9] F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II (1886), tr. it. Adelphi, Milano 1992, p. 141.
[10] Id., Umano, troppo umano, I (1878), tr. it. Adelphi, Milano 1992, p. 16.
[11] Id., Su verità e menzogna fuori del senso morale (1873), in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e scritti 1870-1873, tr. it. Adelphi, Milano 2010, pp. 231-232.
[12] Ibid., p. 233.
[13] Ibid., p. 234.
[14] Id., Crepuscolo degli idoli. Ovvero come si filosofa col martello (1888), tr. it. Adelphi, Milano 2008, p. 46.
[15] Ibid., p. 45.
[16] M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. 24.
[17] Ibid., p. 26.
[18] Ibid., p. 9.
[19] A. Lavazza-V. Possenti, Introduzione a A. Lavazza e V. Possenti (a cura di), Perché essere realisti. Una sfida filosofica, cit., pp. 7-15, in particolare, p. 8.
[20] Ibid.
[21] M. Ferraris, Il mondo esterno, Bompiani, Milano 2013 (2a ed.), p. 89 e p. 93.
[22] A. Lavazza-V. Possenti, Introduzione, cit., p. 8.
[23] M. Ferraris, Nuovo realismo FAQ, in «Noéma», 2, 2011, pp. 1-14, in particolare, p. 1.
[24] Ibid., p. 2.
[25] A. Lavazza-V. Possenti, Introduzione, cit., p. 8 [corsivo mio].
[26] Ibid.
[27] M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., pp. 28-29.
[28] V. Possenti, Realismo diretto e verità, cit., p. 22.
[29] M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, cit., p. X.
[30] Ibid., p. 48 e p. 49.
[31] Id., Esistere è resistere, cit., p. 160 [corsivo mio].
[32] Id., Introduzione a Storia dell’ontologia (a cura di M. Ferraris), Bompiani, Milano 2008, pp. 7-27, in particolare, p. 10.
[33] Ibid., p. 20.
[34] V. Possenti, Realismo diretto e verità, cit., p. 35.
[35] G. Vattimo, Della realtà, Garzanti, Milano 2012, p. 83 [corsivo mio].