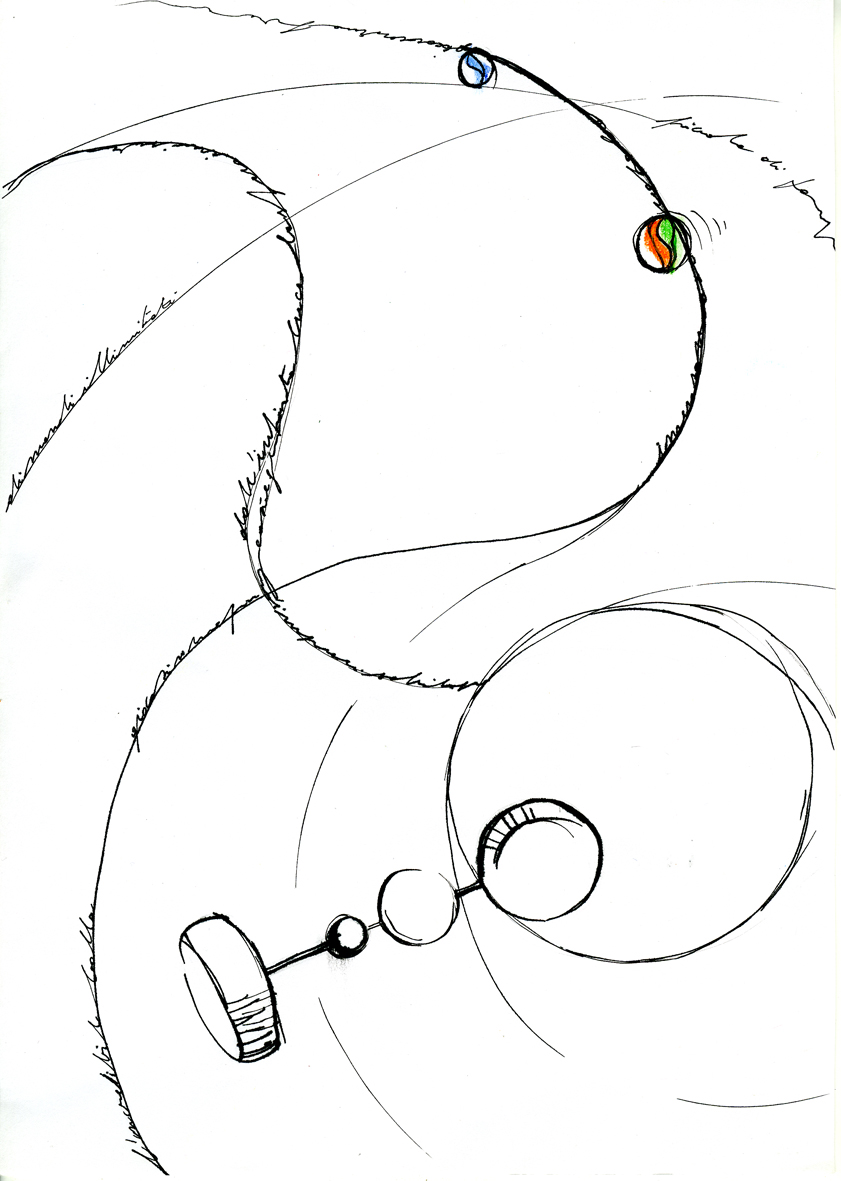Autore
Indice
- Un nuovo concetto di natura
- Il linguaggio della fisica
- L’epoché della sostanza
- Una semplificazione normativa
- L’introduzione di un nuovo assoluto
S&F_n. 15_2016
Abstract
Cassirer and Einstein’s Physics. The epistemological Advantage of the Theory of Relativity
The vast universe, which exists independently of us human beings and which stands before us as an eternal enigma, accessible only in part to our attention and our thinking, has never ceased to exercise his attraction on Einstein. The contemplation of universe led him to venture into the most mysterious sides of theoretical physics and to solve the most complex problems of classical physics. The paradox of theory of relativity consists precisely in the introduction of new absolute, which create a considerable epistemological advantage compared to the newtonian physics. The constancy of the speed of light becomes for Cassirer an ideal apriori, or rather a transcendental form of scientific thought, that revolutionizes the concepts of nature, measure, space and time and responds to the fundamental synthetic requirement of intellect, to his inevitable process of gathering and unifying the multiplicity of experience within the unity of the universal laws of science.
- Un nuovo concetto di natura
L’interesse di Cassirer per la teoria della relatività di Einstein è dominato dalla notevole potenza immaginifica che in essa si riscontra. Consideriamo i due postulati di questa teoria: tutte le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali; la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento inerziali, indipendentemente dalla velocità dell'osservatore o dalla velocità della sorgente di luce. Questi principi delineano una nuova immagine del mondo, che modifica profondamente il concetto stesso di natura e di conoscenza della natura. La filosofia neocritica non poteva ignorare cosa stesse avvenendo nel mondo delle scienze, poiché la reine Naturwissenschaft e le sue condizioni di possibilità erano state poste da Kant come uno dei tre problemi fondamentali nella Critica della ragion pura[1]. Ma se la fisica pura è possibile in quanto paradigma concettuale e struttura formale delle evidenze sperimentali, queste ultime hanno d’altra parte il potere di scardinare proprio le solide impalcature su cui sono state edificate (hypotheses), oppure di trasformarne il disegno o progetto che in esse si rispecchiava. «Ogni risposta data dalla fisica intorno al carattere e alla particolare natura specifica dei propri concetti fondamentali, per la gnoseologia torna di fatto ad assumere, automaticamente, la forma di problema»[2].
Nel semestre invernale 1920-1921, all’Università di Amburgo, Cassirer tenne una serie di lezioni il cui tema era Die philosophischen Probleme der Relativitätstheorie, nel corso delle quali fece spesso riferimento al manoscritto del suo saggio Zur Einsteinschen Relativitätstheorie, che venne pubblicato, benché pronto da tempo, a corso già finito. Erano trascorsi 15 anni da quando Einstein aveva pubblicato, insieme ad altri fondamentali lavori, un articolo scientifico dal titolo Elektrodynamic bewegter Kӧrper, in cui esponeva la sua teoria della relatività ristretta. All’epoca, il giovane scienziato lavorava all’Ufficio brevetti di Berna, dove aveva modo di leggere e riflettere sulle più tormentose questioni di ottica ed elettrodinamica, che risolveva arditamente. È lo stesso Einstein a rivendicare la semplificazione delle teorie precedenti:
la teoria della relatività (ristretta) si è sviluppata dall’elettrodinamica e dall’ottica. In questi campi essa non ha modificato in modo apprezzabile gli enunciati della teoria (di tali fenomeni), ma ne ha considerevolmente semplificato la costruzione teorica, cioè la derivazione delle leggi e – cosa di gran lunga più importante – ha ridotto in misura notevole il numero delle ipotesi tra loro indipendenti su cui tale costruzione si basa[3].
Il nucleo delle analisi di Cassirer sulla fisica einsteiniana consiste proprio nell’individuazione del criterio, del nomos, in base al quale lo scienziato ha edificato la sua brillante teoria, perché rintracciare il principio normativo in base al quale la nuova fisica ha operato la rivoluzione della fisica newtoniana significa rivelare il titolo di legittimità in base al quale la ragione opera in deroga a determinate leggi e in forza di altre al fine di costruire una determinata teoria scientifica. Da questa procedura di carattere metodico discende la seguente domanda: questi nuovi principi normativi derivano dalle caratteristiche cognitive del soggetto o dalla realtà oggettuale? Questa straordinaria teoria quale immagine usa per rappresentare l’universo? In essa l’universo conserva ancora carattere sostanziale o si riduce a un reticolato di interconnessioni tra eventi? Molte sono le problematiche filosofiche sollevate da Cassirer in merito alla nuova immagine del mondo che la nuova fisica ha costruito, prima tra tutte l’esistenza del cronotopo, ossia l’entità tetradimensionale costituente l’universo fisico, provvisto di una geometria unificante i concetti di spazio e tempo, che insieme costituiscono una sola dimensione, misurabile soltanto in relazione al sistema di riferimento scelto dall’osservatore.
La prima delle interessanti riflessioni di Cassirer in cui ci addentriamo riguarda proprio il problema della costruzione dei concetti in fisica, poiché il tema riguarda lo statuto trascendentale della scienza naturale, ossia la condizione in base alla quale la fisica può essere pura a priori. Come si ricava una legge fisica da una serie di dati empirici? È chiaro che «i fatti dell’esperienza, presi nella loro brutalità originaria, non sarebbero utili al ragionamento; per alimentarlo essi dovranno essere trasformati e messi in forma simbolica»[4]. Pierre Duhem, filosofo e matematico francese, cui Cassirer fa spesso riferimento nel corso della sua argomentazione, nell’opera La teoria fisica. Il suo oggetto e la sua struttura (1906), riprende una questione fondamentale per una teoria trascendentale della natura: posto che, come dimostrato da Kant, i contenuti della nostra esperienza del mondo non sono tutti indistintamente utili alla costruzione di teorie scientifiche – lo sono nella misura in cui essi rispondono a precise domande che la nostra ragione ha posto all’inizio di un’indagine sperimentale – occorre chiedersi perché essi si rivelano utili soltanto se rappresentati in formule matematiche, le quali, traducendo in simboli una determinata realtà fisica, sono autorizzate a sostituire i dati concreti con concetti fisici. Secondo Cassirer
in questo passaggio dallo stato della mera sensazione a quello della forma matematica, della forma simbolica, consiste lo specifico segreto epistemologico, il problema della costituzione fisica dei concetti. Non si risolve questo problema, bensì lo si maschera, se non si vede nei concetti fisici nient’altro che delle asserzioni, più o meno condensate, sulle sensazioni, perché già questa “condensazione”, […], è un concetto assolutamente poco chiaro, dietro il quale, […], si nasconde un’ambiguità logica[5].
Da quest’ultima questione ne deriva un’altra, cui prima si è accennato e che sarà fondamentale per comprendere la posizione di Cassirer intorno alla fisica einsteiniana: i dati riformulati simbolicamente in concetti fisici rappresentano a loro volta sostanze, ossia cose, oggetti reali, oppure soltanto mere relazioni tra i fenomeni? Per il momento occupiamoci del primo dei due problemi, fondamentale nel dibattito epistemologico della Rivoluzione scientifica del XVII secolo, il cui maggiore impegno teoretico era volto all’eliminazione dell’antropomorfismo e all’individuazione della struttura matematica del reale, che rivela i rapporti tra grandezze e fenomeni astraendoli dal caos originario delle intuizioni sensibili. Quando le forme a priori della sensibilità mettono in ordine i dati esperienziali, offrendo all’intelletto il materiale su cui operare la sintesi categoriale, avviene un fatto di notevole importanza per la costruzione di un concetto fisico. Il nostro intelletto agisce sui dati sensibili con l’intento di costruire una legge che abbia validità universale, per questo motivo esso dovrà selezionare i dati facendo in modo che la natura risponda alle domande che esso stesso ha posto grazie alla fecondità dei giudizi sintetici a priori.
la ragione arriva a vedere solo ciò che essa stessa produce secondo il proprio progetto, […] essa deve avanzare con i principi dei suoi giudizi, secondo leggi stabili, e deve costringere la natura a rispondere alle sue domande; senza farsi guidare soltanto da essa, come se fosse tenuta per le dande. E questo perché, in caso contrario, le osservazioni casuali che noi facessimo senza un disegno prestabilito, non si connetterebbero affatto in una legge necessaria, mentre è proprio di una tale legge che la ragione va in cerca e ha bisogno. La ragione deve accostarsi alla natura tenendo in una mano i suoi principi – secondo i quali soltanto è possibile che dei fenomeni concordanti valgano come delle leggi –, e nell’altra mano l’esperimento che essa ha escogitato seguendo quei principi: e questo per essere istruita dalla natura, certo, ma non come uno scolaro che stia a sentire tutto ciò che vuole il maestro, bensì come un giudice che svolga il suo ruolo, costringendo i testimoni a rispondere alle domande che egli pone loro[6].
- Il linguaggio della fisica
Immediatamente comprendiamo il valore normativo di quest’operazione, operazione che lo stesso Einstein ha dovuto compiere. Quali esperimenti ha scelto per la costruzione della teoria della relatività ristretta (di cui quella generale è un’estensione)? Come ha organizzato i dati a sua disposizione? A quali tra questi ha attribuito significatività, a quali irrilevanza? Quali connessioni ha individuato tra gli eventi e in base a quali leggi? Questi principi di interconnessione delle relazioni tra i fenomeni sono stati costruiti ex novo oppure rintracciati nei fenomeni stessi?
Per rispondere a queste domande, occorre innanzitutto approfondire la questione relativa alla costruzione dei concetti in fisica, processo in cui si annida, per Cassirer, un’ambiguità logica. Se il fine della fisica è la comprensione e la descrizione di sensazioni concrete in formule matematiche, riproducendo nel modo più fedele possibile il loro autentico contenuto,
si deve ammettere che la fisica, per raggiungere questo fine, deve imboccare una strada particolare, una strada che invece di avvicinarlo a esso, minaccia di allontanarvela sempre di più. […] anziché anche solo tentare una tale descrizione dei dati sensibili immediati, il suo intero procedimento consiste in un allontanamento da questo contenuto. Nella misura in cui la conoscenza scientifica progredisce e sviluppa i metodi che le sono propri e caratteristici, non può allontanarsi sempre di più dalla “realtà effettiva” che è data nella sensazione e in essa riproducibile[7].
In Esperienza e Giudizio (1939) Husserl era pervenuto alle stesse conclusioni: la conoscenza scientifica del mondo non è capace di coglierne le essenze, poiché ha valore simbolico e carattere impersonale. Essa è una traduzione in termini matematici di relazioni oggettive tra gli eventi, ma nulla sa dirci sull’essenza degli eventi stessi. Le leggi della fisica e della matematica non rispecchiano la struttura oggettiva dei diversi ambiti di realtà, poiché esse nelle loro formulazioni simboliche costituiscono delle pure costruzioni intellettuali, anzi una vera e propria «ipertrofia intellettualista»[8], ossia delle proiezioni soggettive che non avvicinano, piuttosto allontanano lo sguardo del filosofo dalle cose stesse. L’universo determinato dall’esattezza ideale della scienza non è
nient’altro che un rivestimento di idee gettato sopra il mondo dell’intuizione e dell’esperienza immediata, sul mondo della vita in modo che ciascun risultato scientifico ha il fondamento del suo senso nell’esperienza immediata e nel mondo dell’esperienza e si rapporta a esso “en retour”. Questo rivestimento di idee fa sì che noi assumiamo per vero ciò che non è che un metodo[9].
Questa traslazione dalla realtà empirica alla simbolizzazione formale, questa μετάβασις εις άλλο γένος, determina il passaggio da un livello logico a un altro e proprio qui sta, secondo Cassirer, l’ambuiguità di fondo dei concetti fisici. I concetti di suono e colore, ad esempio, si esprimono attraverso le frequenze di vibrazione o lunghezza d’onda, mentre il calore è definito dalla scala delle temperature assolute dedotta dal secondo principio della termodinamica. Come sostenuto anche da Max Planck, il fondatore della fisica quantistica, cui Cassirer fa spesso riferimento nel corso del 1920-21, la formazione dei concetti in fisica avviene accantonando sempre di più gli aspetti antropologici contenuti dalla sensazione e allontanandosi sempre di più dalla definizione dell’oggetto fisico e dalla rappresentazione e classificazione dei fenomeni fisici. L’immagine del mondo che la fisica esatta ha costruito è infinitamente più scialba rispetto al «ricco e multicolore quadro di un tempo»[10], costituitosi in base ai bisogni della vita quotidiana.
È anche vero però che il ritorno alle strutture dell’esperienza pre-scientifica non può ignorare la questione su come si costituisca l’idealità trascendentale della fisica a partire dall’idealità del mondo della vita, ossia su come un apriori scientifico traduca simbolicamente un apriori della Lebenswelt. In realtà, il mondo della vita per Husserl è anteriore a ogni sintesi simbolica compiuta dall’essere umano, quindi anche rispetto alla conoscenza sensibile, che procede per scarto e selezione[11] dei dati, enucleando le caratteristiche pregnanti degli oggetti in simboli e lasciando sullo sfondo un residuo irrilevante ai fini dell’interazione, del commercium tra uomo e ambiente. Ora, come sostenuto da Derrida, la totalità piena di questo mondo è per noi inaccessibile:
[…] il mondo prescientifico di cui disponeva il proto-geometra, […], non ha la radicalità del mondo ante-predicativo al quale Husserl tenta di tornare in Esperienza e Giudizio e nella Logica […]. È un mondo di cultura già informato dalla predicazione, dai valori, dalle tecniche empiriche, dalla pratica di una misura e di una induttività che hanno esse stesse il loro stile di certezza[12].
La costruzione di un concetto fisico si fonda sull’osservazione dei fenomeni, certo, ma la determinazione del contenuto e del significato dell’osservazione non concerne soltanto il mero accaduto, bensì anche la disposizione spirituale dell’osservatore, ossia la direzione del suo sguardo. Il mondo della vita è quindi già da sempre informato dai nostri giudizi, misure e pratiche; esso, sin da quando si desta in noi la coscienza, è già inscindibilmente commisto alle forme trascendentali della soggettività. La fisica però, secondo Cassirer, deve recuperare la sapienza degli antichi Greci, che sapevano interrogare la natura secondo criteri logicamente compiuti senza esaurire il contenuto delle loro osservazioni in rigidi e astratti simbolismi. Proprio contro l’astratto concetto si muove la viva esperienza del Rinascimento e della Rivoluzione scientifica, che inaugurano un nuovo modo di osservare e interpretare la natura, dove è l’esperienza, non l’apriori concettuale, a fondare l’autentica conoscenza dei processi e dei fenomeni fisici. Anche la filosofia, come sostenuto da Paracelso,
deve essere trattata in modo tale che anche gli occhi la possano comprendere e che essa risuoni alle orecchie come la cascata del Reno; e che il suo risuonare sia chiaro alle orecchie come il mormorio dei venti marini, e che quindi sia gustata dalla lingua come miele e ogni profumo di tutta quanta la scienza sia avvertibile dalla bile e dal naso. Al di fuori di questa conoscenza, ripugna alla natura tutto quanto a essa si attribuisce[13].
Lo stesso Paracelso, convinto assertore che il linguaggio della fisica debba poter riprodurre l’autenticità delle cose, la viva attualità del reale, è però consapevole che gli occhi dello scienziato, ossia la direzione del suo sguardo, siano ben diversi da quelli dell’esperienza ingenua, che compiamo nel mondo senza alcun fine scientifico, senza alcun principio che guidi il nostro agire, senza alcun criterio di raccolta e classificazione dei dati. Ebbene questi dati, scelti tra una molteplicità perché corrispondenti alle domande poste dal nostro intelletto, ossia congruenti con le forme del nostro intelletto indispensabili per la costruzione di un discorso razionale, questi dati si danno esclusivamente per via simbolica, perché sono il risultato dell’applicazione di criteri di misura. In questo modo però, ritagliando dalla Lebenswelt il correlato empirico conforme alla struttura psicofisica dell’essere umano, al suo modo di stare al mondo, comprenderlo, misurarlo e in esso agire, si opera una μετάβασις εις άλλο γένος, una traslazione da un piano a un altro, che comporta necessariamente la perdita del contenuto immediato, vivo e autentico dell’esperienza. I concetti fisici non possono essere riproduzioni delle cose.
- L’epoché della sostanza
Chiarito il problema della formazione dei concetti fisici, giungiamo alla seconda delle questioni suddette: questi concetti «che cosa sono allora? Che essere si riproduce mai in essi, se non debbono essere né riproduzioni di una “realtà” esterna data, né di una interna?»[14]. Non possiamo rinunciare al significato oggettivo di questi concetti. Non possiamo trattarli come se fossero semplici finzioni, incapaci di dirci alcunché sul mondo della vita e poi pretendere che i fenomeni si comportino secondo le leggi in essi enunciate. Dobbiamo, secondo Cassirer, indicare e definire il senso di queste leggi in modo diverso, chiedendoci con quale linguaggio esse sono state scritte, ossia quale sistema simbolico è stato adoperato per l’enunciazione del principio, dell’apriori scientifico che sta a fondamento della teoria. Se cambia la struttura formale della fisica pura, cambia anche la modalità di sintesi categoriale, ossia di connessione dei fenomeni. Possiamo asserire dunque che si è verificata nel corso della storia della scienza una variazione delle forme del giudizio, inteso nella sua funzione predicativa?
La fisica, nel XIX secolo, ha via via cessato di essere una fisica di immagini, per trasformarsi invece in una fisica di principi. La fisica antica nei modelli meccanici, grazie ai quali essa descriveva un complesso ambito di fenomeni, vedeva ancora immediatamente una riproduzione di questo accadere stesso. Questi modelli meccanici erano per essa l’όντος όν, la “vera realtà effettiva” che sta a fondamento dei fenomeni[15].
Nella fisica contemporanea invece è avvenuta una progressiva desostanzializzazione della realtà, una sospensione dell’elemento oggettuale-cosale, poiché le cose devono essere spogliate del loro contenuto sensibile per poter essere espresse in unità di misura, a loro volta intercambiabili mediante equivalenze. Un raggio di luce, ad esempio, può essere spiegato ricorrendo a immagini e modelli molto diversi tra loro: la teoria newtoniana dell’emissione di corpuscoli, la teoria del moto ondulatorio, quella mediante le oscillazioni del mezzo elastico. È evidente che variando il linguaggio espressivo, varia la rappresentazione della natura e del nostro modo di conoscere la natura. In questo modo però, la storia della fisica si ridurrebbe a un caos di interpretazioni contrastanti, invece, indubbio è il suo potere speculativo e la sua forza di trasformare le condizioni dell’esistenza. L’assetto trascendentale della fisica consiste allora nella sua fondamentale e ineliminabile esigenza di assoluto, di costanti, di apriori che si conservano nel corso della progressiva ristrutturazione o variazione dei concetti fisici. L’elemento oggettivo, costante e apriori delle diverse teorie che si susseguono nella storia della scienza non si trova nelle singole “cose”, alle quali i nostri concetti assomigliano o che riproducono più o meno fedelmente, bensì in relazioni in base a leggi dei fenomeni, che esse esprimono. «Queste leggi e non un qualche criterio di misura o unità di misura oggettuali sono dunque, come ha sottolineato Henri Poincaré nel suo saggio Le mesure du temps, le autentiche costanti che poniamo mentalmente alla base della misurazione»[16].
Nelle considerazioni sulla teoria della relatività, la domanda fondamentale posta da Cassirer non verte su ciò che questa teoria ha visto, ma con quali occhi essa vede il mondo, ossia quali leggi, principi e forme adopera per la rappresentazione della realtà. Se la nuova immagine dell’universo è prodotta da un nuovo modo di accostarsi alla comprensione e spiegazione dei fenomeni, è lecito chiedersi se questo approccio innovativo sia legittimato a procedere. Occorre individuare quale sia il guadagno epistemologico della fisica einsteniana, poiché lo scienziato stesso ha asserito di aver notevolmente semplificato la costruzione teorica delle leggi ottiche ed elettrodinamiche, riducendo considerevolmente il numero delle ipotesi. Consideriamo il celebre esperimento di Michelson-Morley, il quale aveva mostrato, contro ogni aspettativa, che la velocità della luce resta invariata, sia che il raggio di luce fosse lanciato nella presunta direzione del vento d’etere, sia che fosse lanciato nella direzione opposta. L’etere, in base alle leggi della fisica classica, avrebbe dovuto modificare, anche leggermente, la velocità della luce, accelerando il moto di un raggio che viaggia nella sua stessa direzione, rallentando quello che viaggia in direzione opposta. Lo stesso principio si verifica se una nave in moto rettilineo uniforme viaggia a favore di vento, oppure in senso contrario. Il concetto apriori di inerzia, (un corpo persiste nel suo stato di quiete o moto uniforme finché una forza non interviene a modificarlo) ricavato mediante analogia di esperienza, uno dei principi dell’intelletto puro, sembra essere messo in crisi. Il fallimento di questo esperimento fu un fatto sconcertante per la comunità scientifica, che si interrogò a lungo sulle ragioni di questa inspiegabile evidenza sperimentale. L’esperimento fu perfezionato e ripetuto più volte, anche da altri scienziati, ma il risultato rimase invariato. Ciò allarmò nuovamente il modo della scienza e destò molto clamore, poiché l’unica spiegazione possibile era che tutti i fenomeni ottici si comportano come se non vi fosse una traslazione della terra rispetto all’etere. Per rispondere all’esperimento di Michelson-Morley, salvare la fisica classica e il concetto d’etere, seguendo una strada già proposta autonomamente un anno prima da George F. Fitzgerald, il fisico olandese Hendrik A. Lorentz (che divenne poi amico di Einstein), avanzava l’ipotesi che un corpo in movimento subisca una contrazione della propria lunghezza nella direzione del moto, la quale investirebbe anche la forza di coesione delle molecole. La teoria di Lorentz-Fitzgerald fu considerata un prodotto costruito ad hoc, la contrazione dei corpi in movimento o addirittura dei regoli attraverso i quali misuriamo gli intervalli di distanza e tempo fu introdotta apposta per spiegare il motivo per cui la velocità della luce resta costante malgrado la forza contraria esercitata dal vento d’etere.
- Una semplificazione normativa
Tuttavia, proprio dalla crisi del sistema normativo edificato dalla fisica newtoniana si generò un nuovo modo di considerare il problema. La ragione procede, come sappiamo, tenendo in una mano gli esperimenti, nell’altra i principi in base a cui questi sono stati condotti. Se i risultati di alcuni esperimenti contraddicono costantemente gli stessi principi su cui si fondano, occorre individuare la ragione in base alla quale un sistema normativo può spiegare determinati fenomeni ma non altri, e per questi ultimi ricavare nuove leggi in base a cui spiegarli. Si badi, lo scarto epistemologico tra la teoria eisteiniana e quella di Lorenz-Fitzgerald fu proprio questo: mentre costoro cercavano di ristrutturare concetti fisici già esistenti senza cambiare modo di ragionare, Einstein introdusse una nuova chiave di lettura della realtà, ossia un nuovo principio normativo, (ugualmente legittimo rispetto a quelli della fisica classica in quanto derivante dalla comune necessità di sintesi teoretica), in base al quale il vento d’etere non aveva più alcuna importanza se il fine dello scienziato era quello di spiegare il moto inerziale.
Il concetto d’etere, però, era necessario per spiegare la propagazione della luce e delle onde elettromagnetiche, in quanto sostanza materiale che riempie lo spazio e penetra i corpi; infatti, a seconda delle circostanze veniva considerato dagli scienziati ora come un fluido, ora come un corpo elastico, ora addirittura come un corpo rigido. La sostanziale identità di natura dei fenomeni elettrici e magnetici con quelli luminosi, cui conduceva la teoria di Maxwell e Faraday, sembrava appianare almeno in parte le difficoltà, perché il vento d’etere finiva con l’essere un campo elettromagnetico, che possedeva un più chiaro concetto fisico. «Restavano però da chiarire almeno due aspetti non certo secondari: si trattava di capire per quale motivo non fosse possibile rilevare alcuna resistenza dal presunto mezzo materiale al moto dei corpi e se l’etere fosse trascinato dai corpi oppure no. Per dare risposta a questi problemi era necessario elaborare una elettrodinamica dei corpi in movimento»[17]. Proprio il fallimento di questi esperimenti di elettrodinamica stimolò la teoria di Lorentz-Fitzgerald e di Einstein. Dall’apertura di un conflitto sgorga infatti l’istanza di unità; è la dialettica dell’esperienza a mettere in moto la sintesi dell’intelletto, che si attiva proprio in presenza di elementi eterogenei e incompatibili, da connettere tra di loro in modo da superare le contraddizioni e pervenire alla formulazioni di leggi semplici e univoche, capaci di spiegare una molteplicità di fenomeni perché costruite secondo criteri di economia e produttività. Ma allora, se Lorentz e Fitzgerald avevano introdotto una teoria capace di superare la contraddizione delle evidenze sperimentali di Michelson e Morley,
perché non ci si è accontentati di essa? Perché Einstein l’ha sostituita con un’altra teoria nella quale non si parla più dell’esistenza dell’etere e degli effetti che esso esercita sui corpi in moto in esso, nella quale invece si viene rinviati semplicemente alle condizioni del processo di misurazione spaziale e temporale e viene mostrato che due osservatori, l’uno dei quali si trovi nel sistema K, e l’altro nel sistema K’, in moto rispetto a K, debbono usare necessariamente differenti misure di tempo e di spazio?[18]
Il vantaggio epistemologico della teoria di Einstein consiste nello scarto di ipotesi non corroborate dall’esperienza. L’ipotesi dell’esistenza dell’etere e dei suoi effetti sul moto dei corpi non gode di alcuna prova sperimentale, pertanto, non si può attribuire realtà fisica a un corpo la cui esistenza non è mai stata provata. Senza l’etere, però, i corpi non avrebbero uno spazio (e quindi neanche un tempo) in cui muoversi e questa semplice intuizione sospende gli assiomi della fisica classica e della geometria euclidea, dove spazio e tempo sono due dimensioni distinte all’interno delle quali si svolgono gli eventi.
Tutto ciò che finora non era affatto spiegabile, o lo era soltanto ricorrendo a ipotesi estremamente difficili e in fondo arbitrarie, mediante l’introduzione di un etere oggettuale, inteso come sostanza particolare, si spiega perché ci atteniamo unicamente alle regole di misurazione valide per ogni sistema di riferimento fisico. In queste regole e non in una cosa sostanziale esistente assolutamente viene ora fondata l’unità dell’immagine fisica del mondo e in questa unità non vi è alcun contrasto con la diversità delle osservazioni che possono essere ottenute da differenti sistemi di riferimento in moto uniforme gli uni rispetto agli altri, bensì si trova proprio lì la chiave di questa stessa diversità[19].
Ebbene, da questa esigenza di unità e semplificazione scaturirono i due postulati della teoria della relatività ristretta, costruita per descrivere eventi che si registrano a velocità prossime a quella della luce, mentre negli altri casi rinvia alle leggi della meccanica classica: le leggi dell'elettromagnetismo e dell'ottica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali; la luce si propaga nel vuoto a velocità costante c indipendentemente dallo stato di moto della sorgente o dell'osservatore. Il primo postulato, noto anche come “principio di relatività speciale”, riafferma ed estende il principio di relatività di Galilei, mentre il secondo discende dal primo ed elimina la necessità dell'etere luminifero, dando il giusto significato all'esperimento di Michelson-Morley. Dai due postulati discende che nell'universo descritto dalla relatività speciale le misure di intervalli temporali e di lunghezze spaziali effettuate da osservatori inerziali non corrispondono necessariamente fra loro, dando luogo a fenomeni come la dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze, che sono espressione dell'unione dello spazio tridimensionale e del tempo in una unica entità tetradimensionale nella quale si svolgono gli eventi, chiamata cronotopo o spazio-tempo. In questo ambito lo strumento matematico che consente il cambio di sistema di riferimento è costituito dalle trasformazioni di Lorentz, che si riducono alle trasformazioni di Galilei della fisica classica nel limite di basse velocità.
Tutti gli osservatori – come mostra l’esito dell’esperimento di Michelson – hanno il medesimo diritto e la medesima ragione di assumere che nel loro sistema la luce si propaghi con velocità costante. Se eleviamo questa assunzione a esigenza, richiediamo dunque che la velocità della luce, che è stata trovata in un sistema K, valga anche per tutti i sistemi K’ in moto uniforme e rettilineo rispetto a K (così che lo stesso raggio di luce sembra muoversi alla stessa velocità a due osservatori che si muovano l’uno rispetto all’altro); in questo modo abbiamo già tutto quello che ci serve per completare il passaggio dei valori di misura da un sistema all’altro[20].
- L’introduzione di un nuovo assoluto
L’etere inteso come sostanza oggettuale non riesce a rendere conto dell’invarianza dei fenomeni meccanici, ottici ed elettromagnetici nell’ambito di differenti sistemi inerziali, per questo nella teoria della relatività viene de-sostanzializzato, ma l’oggettività di questo concetto si conserva in un’altra forma di assoluto: il principio della costanza della velocità della luce, che, unito al principio della relatività speciale, si dimostra adeguato a dare pienamente conto di tutti i fenomeni fisici. I postulati di Eistein non rappresentano una cosa unitaria, non descrivono una sostanza, ma formulano una relazione fondamentale unitaria cui obbediscono tutte le leggi della natura. La posizione di questa relazione tra sistemi di riferimento, ossia sistemi di coordinate di misurazione, assurge a nuovo paradigma concettuale, a nuova struttura formale dell’esperienza; si tratta di una ratio legis che si fa radice oggettiva e normativa, ossia misura, del reale. La misura rispecchia il concreto e vivo svolgersi dei fenomeni anche se non può riprodurne i contenuti sensibili. Essa è la forma e il modo in cui accadono gli eventi naturali, è l’autentico e verace fondamento dei fenomeni, il ritmo del loro interno divenire. La misura, ossia il modo d’essere delle cose, è però il frutto dell’interazione tra un osservatore e un determinato sistema di riferimento. Confrontare tra loro più sistemi di riferimento (rispetto alla teoria della relatività ci riferiamo a sistemi inerziali) implica un superamento dei limiti della fisica classica, perché la radice oggettiva e normativa del reale non è più costituita dal concetto di sostanza ma da quello di misura. Einstein non ha reso affatto più scialba l’immagine dell’universo, tutt’altro: dalla semplificazione delle ipotesi è scaturita un’immagine dell’universo più ricca, dove gli intervalli di spazio e tempo non sono predeterminati, fissi e univoci, ma originati dalla velocità dei corpi, dunque relativi. L’immagine della realtà nella teoria einsteiniana è persino troppo complessa per potercela figurare con esattezza: solo ricorrendo a sofisticate tecnologie possiamo farci un’idea di come cambiano i concetti di spazio e tempo. Non più cornici o contenitori, ma, fusi in un’unica dimensione, si dilatano e si restringono in base al grado di velocità con cui viaggia un corpo, determinando variazioni nella misurazione degli intervalli di distanza e durata. Le variazioni non sono rappresentazioni contrastanti della realtà, di cui una e una sola è vera. Nessuna misurazione è più corretta delle altre, non esistono sistemi di riferimento privilegiati. In tutti i sistemi di misurazione, però, si conserva un residuo di oggettività assoluta, ossia la costanza della velocità della luce:
Come nella meccanica galileiana, nello stabilire le leggi del moto, l’introduzione delle grandezze delle forze determinate veniva scelta in modo tale che il principio di inerzia rimanesse valido, così qui viene richiesta una costituzione delle leggi di natura tale per cui la velocità della luce non venga violata. Si tratta in questo principio non tanto dell’affermazione di un fenomeno singolo, per quanto ben garantito, quanto piuttosto dell’affermazione di una legalità universale, con la quale riuniamo in una sola, breve formula la totalità delle nostre conoscenze dei processi ottici ed elettromagnetici[21].
Ogni teoria scientifica fissa nuovi punti di cristallizzazione, nuovi limiti ideali, che diventano principi di misurazione e in questi principi si trasferisce tutta l’oggettività delle relazioni tra i fenomeni. La decosalizzazione della materia, dunque, non implica affatto una deriva nominalistica della scienza naturale, per cui gli enunciati della fisica sarebbero pure astrazioni, incapaci di restituire l’autentica concretezza dei fenomeni naturali. Anzi, la dematerializzazione dei concetti fisici determina la posizione di nuovi limiti ideali, nuovi apriori scientifici, (in questo caso il principio di costanza della velocità della luce), capaci di sussumere nella loro superiore unità sintetica una molteplicità di fenomeni incompatibili in base alle leggi della fisica classica. La teoria della relatività, quindi, da un punto di vista epistemologico, introduce nuovi assoluti, ossia un paradigma di legalità universale. Einstein, infatti, in Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie (1915), sostiene che «le leggi generali della natura debbono potersi esprimere mediante relazioni che valgano per tutti i sistemi di coordinate, siano cioè covarianti rispetto a qualunque sostituzione»[22]. Egli ha posto un nuovo, estensivo concetto di misura e principio di misura, che intende «abbracciare e rappresentare uniformemente la meccanica e l’elettrodinamica, i vari moti e i fenomeni ottici ed elettrici»[23] . Mentre per Lorentz il concetto di misura corrisponde a un concetto di cosa, per Einstein va inteso soltanto in quanto tale e puramente in quanto tale va applicato.
I principi di misura, allora, hanno la forza di comprendere e rappresentare il logos, ossia il criterio in base al quale si svolgono gli eventi naturali, nella consapevolezza che esso sia pur sempre soggetto a un processo di simbolizzazione e teorizzazione, derivante dall’idealità trascendentale della Naturwissenschaft: «nessuna teoria della scienza della natura», osserva Cassirer, «si riferisce direttamente ai fatti della percezione come tali, bensì ai limiti ideali che noi con il pensiero poniamo in luogo di essi»[24]. La posizione di limiti ideali non è però un’operazione artificiosa o arbitraria, bensì legittima, in quanto volta al superamento della dialettica dell’esperienza, ossia delle sue interne contraddizioni, entro l’unità sintetica del concetto puro. Ora, l’esigenza di sintesi unitaria certamente di matrice soggettiva, in quanto espressione delle forme trascendentali del pensiero, ma de facto e de iure è capace di dar conto e ragione della totalità dei fenomeni fisici, ricomprendendoli in virtù di un nuovo assoluto, (la costanza della velocità della luce), ossia in forza di una legge maggiormente esaustiva. Addirittura il contenuto della teoria della relatività può essere sintetizzato in una sola proposizione, come sostenuto dallo stesso Einstein in The Fundamentals of Theoretical Physics (1940): «tutte le leggi naturali devono essere invarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz»[25].
Il paradosso della teoria della relatività consiste proprio nella posizione di nuovi assoluti, che scardinano ogni forma di scetticismo e rivelano l’intrinseca normatività del reale, ossia il necessario rimando, per ogni misurazione degli intervalli di tempo e spazio, a un sistema di riferimento in relazione al quale quelle misurazioni siano valide. L’oggettività della misurazione spazio-temporale, dunque, non viene annullata, ma vincolata a un determinato sistema di coordinate e questa operazione di carattere teoretico è mossa dalla funzione critica della ragione pura, volta a stabilire i limiti, la validità e le condizioni di possibilità della conoscenza della natura.
Il guadagno epistemologico della teoria della relatività non sta dunque nell’aver scoperto nuovi fenomeni o introdotto nuove descrizioni o classificazioni degli stessi, ma nell’aver individuato una legge unitaria in base alla quale è possibile spiegare la totalità dei fenomeni fisici. In questo modo il progresso scientifico può superare «la collezione periferica di conoscenze multilaterali»[26] e avviarsi verso la
raccolta centralizzata di esse in un’Unità vera e ultima. Questo è l’ultimo grado che resta da raggiungere, questa è la meta, l’unica che ripaghi quello sforzo multiplo e variegato. Infatti, in virtù del rafforzamento e potenziamento procurato da tutto quel lavoro scientifico, si scorge infine l’unità della scienza, nel suo fondamento unitario ultimo, nell’Idea, […], la Legge della legalità stessa; dunque l’Unificazione ultima, centralizzata di tutte le conoscenze particolari nella Legge originaria, nel Fondamento metodico puro della conoscenza stessa[27].
[1] «Basterà andare a vedere le diverse proposizioni che ricorrono all’inizio della fisica vera e propria (empirica) – come quelle riguardanti la permanenza di una stessa quantità di materia, l’inerzia, l’uguaglianza di azione e reazione ecc. – per convincersi subito che esse costituiscono una physica pura (o rationalis)», I. Kant, Critica della Ragion Pura, tr. it. Bompiani, Milano 2004, p. 97.
[2] E. Cassirer La teoria della relatività di Einstein, tr. it. Castelvecchi, Roma 2015, p. 68.
[3] A. Einstein, Opere scelte, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1988, p. 419 (corsivo mio).
[4] P. Duhem, La teoria fisica. Il suo oggetto e la sua struttura, tr. it. Il Mulino, Bologna 1978, p. 221.
[5] E. Cassirer, I problemi filosofici della teoria della relatività, tr. it. Mimesis, Milano 2015, p. 70.
[6] I. Kant, op. cit., p. 30.
[7] E. Cassirer, I problemi filosofici della teoria della relatività, cit., p. 64.
[8] E. Husserl, Esperienza e Giudizio, tr. it. Bompiani, Milano 2007 p. 167.
[9] Ibid., pp. 41-42. Cfr. Il mondo della vita come dimenticato fondamento di senso della scienza della natura, in La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it. Il Saggiatore, Milano 2008, p. 77.
[10] E. Cassirer, I problemi filosofici della teoria della relatività, cit., p. 65.
[11] Cfr. A. Gehlen, L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, tr. it. Sugarco, Milano 1983.
[12] J. Derrida, Introduzione a Husserl. L’origine della geometria, tr. it. Jaca Book, Milano 1987, p. 178.
[13] T. Paracelso, Paragrano (1530), tr. it. Laterza, Roma-Bari 1973, pp. 26-27.
[14] E. Cassirer, I problemi filosofici della teoria della relatività, cit., p. 72.
[15] Ibid.
[16] Ibid., pp. 75-76.
[17] Ibid., Introduzione di R. Pettoello, p. 10.
[18] Ibid., p. 86.
[19] Ibid., p. 90.
[20] Ibid., p. 90.
[21] Ibid., p. 99.
[22] A. Einstein, Opere scelte, cit., vol. VI, p. 289 (corsivo mio).
[23] E. Cassirer, I problemi filosofici della teoria della relatività, cit., p. 88.
[24] Id., La teoria della relatività di Einstein, cit., p. 178.
[25] Ora in A. Einstein, Opere scelte, cit., p. 570.
[26] P. Natorp, Dottrina platonica delle idee. Una introduzione all’idealismo, tr. it. Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 220.
[27] Ibid.