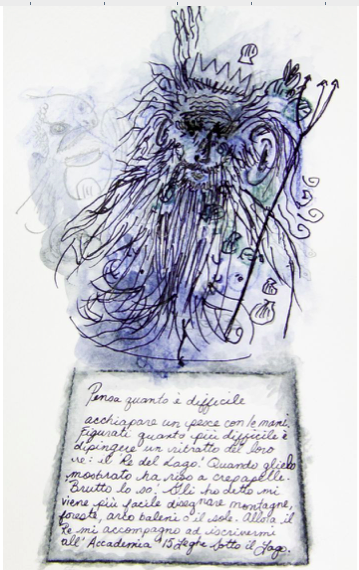Autore
Indice
- Qualche chiave di lettura
- Il soggetto
- L’inconscio
- Come una partitura
- L’abito longitudinale
- Conclusione
S&F_n. 14_2015
Abstract
Penso mas não existo
This paper aims to explain the main issues emerging from the research of Sergio Piro, not only a psychiatrist (or psychiatrist and much more) concerning the subject, otherwise defined in common sense terms and extensively intended as person, self, individual and so on. So, this paper presents the topic of the historical constitution of the singularity, its development, its relations to world and the topic of destinies too, questions concerning the structure of the unconscious and its relationship with Time.
- Qualche chiave di lettura
L’impresa di riferire il pensiero di Sergio Piro (P. da ora in poi) risulta problematica per svariate e complicate motivazioni che hanno origine nella natura stessa di ciò di cui si vuol riferire.
Innanzi tutto P. riteneva che ogni teorizzazione dovesse essere preceduta da un atteggiamento proposizionale che ne sottolineasse il carattere di irrimediabile provvisorietà: io credo, io penso, io spero, io temo etc., rappresentano l’unico atteggiamento in grado di controbattere alle certezze proprie di ogni “io forte” che tenti di ipostatizzare credenze, opinioni, convinzioni etc. allo scopo di imporle nelle relazioni nel campo antropico continuo[1].
Di conseguenza questo scritto non potrebbe mai sfuggire a questa premessa e pertanto va inteso come sviluppo di un atteggiamento proposizionale orientato a sottolineare l’arbitrarietà delle riflessioni di chi scrive circa le riflessioni di P.
A rendere ancor più arbitrario il riferire il suo pensiero, è la circostanza che ogni affermazione, sia pur preceduta da opportuno atteggiamento proposizionale, può essere colta nella sua estrema provvisorietà in quanto legata al tempo[2]: P. affermava spesso che ogni scritto che consegnava all’editore diventava in quel medesimo momento già superato dal tumultuoso accadere dell’accadere antropico[3].
Il terzo limite, che chi scrive intende ricordare, riguarda il rifiuto di P. verso ogni tentativo di cristallizzare i contenuti della sua ricerca, durata decenni, in formule o modelli o, peggio ancora, in strutture interpretative deterministiche[4] e orientamenti didattici metodologicamente rigidi, e ciò appare come logica conseguenza del punto precedente.
Altra notevole difficoltà discende dal dover qui riferire di un aspetto specifico della ricerca di P., ricerca che ha seguito nel suo divenire un percorso zigzagante (diadromico)[5] tra l’enorme flusso degli accadimenti e degli eventi che ne hanno caratterizzato il pensiero in continuo rapporto dialettico con le prassi.
Come è comprensibile, questa oscillazione perenne della ricerca, in senso diacronico e sincronico, rende impossibile qualunque tentativo paradossale di congelare in definizioni stabili gli attraversamenti della ricerca stessa.
Ciò ancor più se questo scritto, avventurosamente, tenta di esplorare lo snodo importantissimo del pensiero di P. che riguarda un argomento specifico, estrapolandolo dal contesto espositivo del quale è parte, e a maggior ragione se questo argomento riguarda il soggetto,o meglio, in terminologia piriana il singolo come molteplicità pluripersonale.
Altro ostacolo a una sintesi possibile e credibile dell’esplorazione piriana è costituito dai suoi molteplici riferimenti culturali e formativi in vari campi del conoscere, e del resto questa impostazione tiene fede della necessità da lui avvertita di oltrepassare i confini delle singole discipline (psicologia, sociologia, linguistica, semantogenesi, genetica, filosofia, musica, scienze naturali, teatro, letteratura, antropologia etc.) allo scopo di annullare i limiti angusti che queste discipline si pongono e creare così sintematiche[6] originali e per loro natura provvisorie.
In estrema sintesi, anche se l’argomento esula dalle finalità specifiche di questo scritto, ma ne costituisce contemporaneamente fondamento irrinunciabile, potremmo rintracciare con sufficiente approssimazione le radici culturali di P., coerentemente con il suo pensiero, rileggendo, cronoligizzando e contestualizzando le sue opere principali.
Si rintraccia in esse un iniziale interesse per la linguistica, interesse presente nei suoi scritti fin dal 1953 che lo guidò a redigere la tesi di laurea sull’esperienza del confronto con schizofrenici e a produrre, in seguito, il suo primo poderoso lavoro di ricerca sul linguaggio schizofrenico[7].
Ma l’atmosfera culturale degli anni della sua formazione era profondamente impregnata dal pensiero fenomenologico, e questo pensiero è stato senz’altro una radice culturale condivisa con gran parte del movimento che lottò per l’abbattimento delle istituzioni totali allora esistenti (i manicomi).
La direzione della ricerca di P., a differenza di altri ricercatori di quella generazione, volse decisamente e speditamente verso la relativizzazione dei singoli ambiti disciplinari, l’abbattimento dei confini che rigidamente ne segnavano le competenze ma, contemporaneamente, soprattutto i limiti.
Questa scelta comportò la necessità di coniare neologismi e di utilizzare paralogismi allo scopo di narrare, con la maggior accuratezza semantica possibile, cosa emergeva dall’allargamento degli orizzonti del ricercare, conseguentemente alla moltiplicazione degli strumenti della ricerca.
Risulta ovvio pensare che dunque P. non fu certo animato da un generico furore iconoclasta nei confronti delle (così malamente denominate, avrebbe soggiunto) scienze umane, al contrario: radicò in loro un’acutezza critica che lo indusse a considerare scrupolosamente il lascito irrinunciabile delle ricerche scientifiche del ventesimo secolo, lascito sussunto nella definizione residuo operazionale[8].
in qualche modo dunque incarnò l’intreccio possibile tra le impronte husserliane e l’ermeneutica, la psicoanalisi strutturale semantica di Lacan e la bi-logica di Matte Blanco, il pensiero marxista, l’interesse per la scuola di Francoforte, il confronto con le tesi antipsichiatriche e, evitando di elencare tutti gli estesi riferimenti teorici (Arendt, Foucault, Wittgenstein, Derrida, Sartre, Nietzsche, Masullo, Mao Ze Dong, Piaget, Frege, Carnap, Quine etc.) divenne egli stesso il viandante diadromico nell’orizzonte sopravveniente del futuro prossimo[9].
La ricerca di P. appare dunque, nel suo svolgersi diacronico, uno zigzagare continuo oltre i limiti delle singole discipline malamente designate come “scienze umane”, per la costituzione di sintematiche provvisorie quanto rigorose nell’evitare cedimenti dadaistici a fumetti.
Esemplari risultano a proposito gli studi linguistici, senza alcuna esclusione, e le implicazioni possibili, le connessioni (ad es. tra la linguistica e la psicologia nella teoria freudiana del lapsus[10], citato da P. come brillante esempio di sintematica) in grado di ampliare gli orizzonti della ricerca.
Ma ritengo che fu soprattutto l’immersione continua in ciò che in quegli anni accadeva nel mondo a dare vivacità e ironia, visionarietà e una spiccata capacità di “preveggenza” al suo pensiero.
E se intendo sottolineare ancora una volta la stringente necessità di narrare P. tenendo ben presente il suo destino[11] è perché la sua traiettoria personale descrive, in modo più evidente di ogni scritto, cosa intendesse per Antropologie trasformazionali.
Dall’interesse per la linguistica, come già ricordato, a quello per i nuovi movimenti no-global di Seattle, passando per le battaglie politiche e anti istituzionali sempre da militante, sembra che un suo suggerimento possa essere sintetizzato (P. mi perdonerà per questo azzardo) in una massima che sottolinei l’importanza delle capacità trasformazionali[12] proprie della singolarità multipersonale.
Ne è testimonianza la sua costante protensione verso l’ulteriorità,
al di là delle nebbie intensionali del futuro prossimo, al di là del paradosso, prassi indilazionabili, bivi con una sola strada, scelte radicali [“o rimanere chiusi nel pollaio o perdersi nel deserto”] che sono solo apparenti[13].
Se nonostante le difficoltà elencate, e le altre che implicitamente sono a esse collegate, chi scrive persiste nel portare a termine il suo intento, deve ipotizzarsi da un lato una sua certa temerarietà e dall’altro un desiderio di restituire a P. una possibilità ulteriore di conoscenza e confronto.
2. Il soggetto
Il tema dell’individuo, inteso estensivamente con la terminologia varia che ha accompagnato l’evoluzione del pensiero psicologico (Io, soggetto, sé, persona etc.), viene approfonditamente ripreso da P. nel senso più proprio che egli conferisce a questo ambito della ricerca precipua delle antropologie trasformazionali; naturalmente senza ignorare i residui storici, teorici e operazionali, che, quanto meno a partire dal Saggio sull’intelletto umano di Locke, si riferiscono alla delicata permanenza di una certa consapevolezza di continuità del proprio io, consapevolezza che accompagna lungo tutta la vita l’essere umano.
Questo vissuto di identità, sostenuto forse dal bisogno di rielaborare il lutto della perdita della garanzia cristiana nell’aldilà e dal bisogno di fugare ogni negazione dell’uomo come soggetto che lo oggettivizzi a cosa tra le cose, si è articolato nel tempo in svariate forme concettuali volte a contrastare la fragilità personale e a ricostituire una sorta di bivalenza dell’essere umano, convocato al difficile impegno di coniugare in sé l’immanenza della propria mondanità e la trascendenza delle proprie protensioni.
Naturalmente non è possibile in questo scritto ripercorrere tutto il travagliato tragitto del soggetto, ma è viceversa possibile indicare alcuni rivoli del pensiero che riguardano più da vicino il monde psy: non si può non accennare infatti alle ricerche di Taine, Ribot, Janet, Binet, i c.d. médicin philosophes, che in qualche modo negarono l’unitarietà dell’io e gli attribuirono invece una originaria frammentarietà e discontinuità, condizione preliminare per concepire poi l’esistenza di personalità multiple.
Ma ancor più problematicamente queste tematiche sono rappresentate in campo artistico da autori quali Proust e Pirandello che trattano l’argomento, con diverse e per tanti versi opposte modalità, o per sottolineare l’elemento memoria come garante di una continuità e consistenza storica dell’individuo; o per ipotizzare la coesistenza di coscienze diverse, se non anche opposte, coesistenza che tiene insieme i brandelli disgregati dell’io garantendogli, anche a sua insaputa, una certa sostanziale unitarietà governata da un io egemone.
La costruzione di sé stessi è per Pirandello uno «spontaneo artificio interiore»[14] che può tentare quattro differenti strategie: l’adeguamento al desiderio dell’Altro (come tu mi vuoi), la trasformazione delle illusioni in comportamenti “superiori” (sublimazione?), la follia come scelta nichilistica (depersonalizzazione), la fusione panica con la natura (reificazione) senza ritenzione e senza protensione[15].
Da questi, e altri innumeri non meno importanti residui storici che avrebbe maggior senso ricordare in una trattazione estesa, parte P. per approdare poi a una complessità di cui tenterò il dire.
Con una necessaria premessa che lo stesso P. ha tenuto a precisare:
È abbastanza evidente che le questioni sull’identità di cui si occupa la ricerca diadromico-trasformazionale non hanno a che fare né con la definizione filosofica di essa […], né col principio di identità in logica […], anche se un filo epistemologico sottile unisce l’identità antropica (o personale) di cui qui si dice con l’identità formale della logica: il collegamento passa attraverso il linguaggio, l’uso estensionale-intensionale di esso, i problemi che derivano dalla logica estensionale e dal suo superamento, i problemi del riferimento semantico e della denotazione[16].
La parola singolo, nella terminologia delle antropologie trasformazionali, si riferisce a ciò che l’uso comune definisce come tale: persona, soggetto, individuo etc.; in particolare al termine persona viene attribuito da P. un significato di sotto-insieme fluente capace di esprimere (delotica[17]) serie molteplici di comportamenti, mutevoli nel tempo, finalizzati a scopi o sovra scopi, che si manifestano con maggior legame al sistema doxo-axio-ideologico[18] locale, vale a dire nelle zone adiacenti del campo antropico continuo.
Quindi, chiarito almeno in parte a cosa ci si riferisce, sembra congruo affrontare dall’inizio come va formandosi la singolarità intesa come politropo empirico-trascendentale[19]: dall’avvertenza iniziale, che P. definisce pre-tetica e ante-predicativa, vale a dire ancora non in possesso di tutte quelle capacità e competenze che lo indurranno a una ininterrotta prassi di attività protensive e di simbolizzazione linguistica, alla necessaria coscienza tetica del mondo.
Tale salto è reso possibile dallo sviluppo biologico naturale da cui prende inizio, tramite la maturazione e l’ampliamento delle capacità percettive degli organi di senso, di tutti gli organi e apparati, in un tragitto senza discontinuità sostanziale con le successive abilità a costruire strumenti ulteriori di conoscenza e di ricerca.
Per necessaria continuità tale coscienza osservante comincia a riflettere, a ripiegare su se stessa e, grazie al naturale sviluppo delle strutture predicative che consentiranno poi la piena strutturazione del linguaggio, diviene coscienza tetica di se stessa[20].
afferma che per tutto questo iniziale processo va inferita una naturalità biologica che consente lo sviluppo delle capacità di dominio delle proprie capacità ricettive e del linguaggio, e su questo piano vanno osservate le connessioni e le implicazioni tra il linguaggio stesso e il formarsi del pensiero predicativo[21].
Nel processo della evoluzione dalla coscienza tetica del mondo alla coscienza tetica di sé, fino ad approdare alla manifestazione del linguaggio e alla coscienza riflessiva piena, P. descrive una faglia disastrosa[22] che separa il discorso della ragione da quello dell’emozione, e che manifesta questa separazione nel linguaggio.
Tale separazione determina la spaccatura del noema[23] nelle due componenti, cognitiva e passionale: così dalla globale avvertenza iniziale in cui non esisteva alcuna soluzione di continuità o differenza sostanziale tra conoscenza e passione, la riflessione, e di conseguenza il linguaggio, costruiscono un enorme artefatto.
non nega che queste due frazioni possano avere, sul piano neurobiologico, diverse strutture o diverse modalità neurofisiologiche, non è questo il punto; ma, poiché si tratta di eventi inferiti, afferma che di essi non c’è possibilità di narrazione.
Il passaggio importante, secondo l’opinione di chi scrive, avviene proprio in questa dinamica disastrosa della frattura: questa dinamica, in qualche modo simile al processo che la psicologia designa come soggettivazione, crea l’artefatto che condurrà in seguito all’illusione dell’unità intensionale del soggetto.
Illusione basata sulla convinzione di una continuità della coscienza attraverso la narrazione del mondo della memoria, mondo che, se definito intensionalmente, caratterizzato dal realismo ontologico del passato, è inesistente[24].
A rafforzare in qualche modo tale illusione collabora attivamente quella che P. chiama la
coscienza tetica dell’interiorità fluente: negli Erlebnisse costitutivi dell’identità personale protopatica è molto difficile porre il limite fra quella parte che attiene all’attività basale del sistema neuro semantico in vicinanza con le attività di schema corporeo, di percezione diffusa del mondo, di auto percezione spaziale, etc. e quell’altra parte, sicuramente molto estesa, che viene appresa nella contrattazione umana[25].
Ma la coscienza è necessariamente tetica dell’interiorità fluente, nella provvisorietà e nella frammentazione delle esperienze percettive e nelle sue manifestazioni esterne: in tal modo tra la coscienza tetica del mondo e la coscienza tetica di sé si interpone la coscienza tetica dell’interiorità fluente[26].
Tale coscienza di transizione, definita obliqua da P., riflette su quella parte di accadimenti del mondo che vengono percepiti in modo differente e per qualche aspetto avvertiti come più interiori.
Ma non si può affermare l’esistenza di alcuna interiorità sostanziale: la singolarità immersa nel campo antropico continuo è incessantemente attraversata dall’enorme flusso pancronico di eventi e accadimenti (come vedremo poi), non ha barriere che lo separino dall’esterno, e vive l’illusione che la parte del flusso che la attraversa sia garante di questa supposta individualità: «la singolarità umana delle sintematiche diadromico-trasformazionali è aperta da tutte le parti, è comunicante con tutto e fa parte di tutto ciò che accade»[27].
quindi ritiene molto calzante la parola interiorità per denotarne, credo, anche il significato spaziale (lo spazio dell’attraversamento interiore delle molteplici dinamiche mondane) ed enumera cosa l’attraversa.
Innanzi tutto la memoria, intesa in senso estensivo e genericamente definibile come biologica; i filoni diacronici provenienti dal passato plurale e dal passato singolare; la radiazione micro semiotica traversante e le afferenze macrosemiotiche del mondo; la presenza di altre singolarità pluripersonali; il vissuto fluente della unitarietà e la compresenza di vissuti di molteplicità interiore.
Quindi in virtù dell’incessantemente cangiante presenza di questa enorme onda pancronica di eventi, di cui la singolarità è parte inseparabile e da cui viene attraversata, non è possibile affermare la stabilità di alcuna identità imprigionata nel guscio calcareo di una definizione identitaria.
L’interiorità quindi non può avere confini impermeabili, è alonare, non ha barriere definite, vive diadromicamente nell’alone della conoscenza e della delosi pulsando di continuo tra la necessità di auto affermarsi e quella di negarsi, dipende dal mondo in cui è immersa e a esso eternamente si mostra, oscilla di continuo tra l’essere il risultato di protensioni di altro e ad altro, è perennemente aperta al mondo e verso il mondo, l’alone che tutta la avvolge e confonde contempla accadimenti che stanno indecentemente (avverbio utilizzato da P.) dall’una e dall’altra parte dei suoi (inesistenti) confini, va incontro alla confluenza con altre molteplicità singolari formando aggregati sintelici molteplici e variabili, etc.
Dunque l’erronea e fuorviante sovrapposizione di individualità a singolarità non ha alcun fondamento per P., essa è dovuta alla singolarità della coscienza e alle sue dinamiche percettivo-espressive, proprie del sistema neuro semantico (o neurosemantocosmico in una precedente trattazione) da cui si sviluppa.
Su questa illusoria pretesa di identità si fonda un artificio che, portato alle estreme conseguenze, conduce alla sua necessaria, ostinata, coatta e ripetitiva affermazione fino all’organizzarsi di un io forte, rigidamente e orgogliosamente obbligato alla prevaricazione e all’odio.
E la storia non è avara di esempi di realizzazione di un io forte: razzismo, fondamentalismo religioso o economico, nazionalismo, colonizzazione, imperialismo, oppressione, emarginazione sociale, fino al provocare sofferenze e guerra[28].
3. L’inconscio
È necessario anche in questa parte del discorso operare alcune precisazioni di tipo linguistico: P. distingue l’emergere di una duplice concezione dell’inconscio, da una parte quello definito come sub-strato e dall’altra gli inconsci sistemici, psicoanalitici e postpsicoanalitici.
E afferma che tutte le ultime ricerche in campo neuropsicologico suggeriscono una crescente capacità dell’inconscio sub-strato; anzi, soggiunge P., anche le teorie lacaniane, l’inconscio strutturato come un linguaggio, o le teorie di Matte Blanco che ipotizza la coesistenza di due diversi tipi di logica, quella asimmetrica diretta conseguenza dell’impostazione aristotelica, e la logica simmetrica fondata sui principi della simmetria e della generalizzazione, confortano l’ipotesi dell’inesistenza di un inconscio sistemico.
Per P. dunque è da respingere qualunque affermazione dell’esistenza di un mondo dell’inconscio, inteso intensionalmente mediante la funzione reificante del linguaggio:
metaforizzazione, analogizzazione, introiezione della logica cosale, attribuzione al mondo interno delle leggi causali macroscopiche del mondo esterno, sono i processi mediante i quali viene creato l’inconscio come mondo del passato[29].
Questo mondo è comunque un mondo della memoria che organizza scene e discorsi finalizzati a una ricostruzione delle vicende passate costituzionalmente arbitraria: gli eventi e gli accadimenti[30] del passato vengono rielaborati in accaduti.
L’accaduto è testimoniato da documenti obiettivabili, alla stregua della ricerca storica che indaga e ricerca sulle fonti; mentre il ricordo, adeso a un’attività neurosemantica che nel corso dell’esistenza biologica continuamente si evolve, viene inesorabilmente deformato dalle necessità intensionali del linguaggio.
Per questo motivo l’accaduto non può essere mai definito in relazione all’interiorità fluente tramite procedimenti mnesici; ma esclusivamente in relazione al mondo esterno: «è spazializzato», afferma P..
E allora cosa rimane dell’interiorità a causa della deformazione inesorabile cui è sottoposta dalla narrazione? Neanche il presente, comunque inafferrabile in virtù della sua evanescenza, nonostante rappresenti l’opportunità per l’illusoria definizione della propria identità.
Rimane la vastissima e nebbiosa coscienza pre-tetica e ante-predicativa, di cui già si è detto; l’arbitrarietà e disomogeneità della coscienza tetica; e il futuro immediatamente prossimo, che si presenta incessantemente in maniera mai definita, in un vortice mai fermo, in perenne bilico asincronico tra la formulazione di ipotesi trasformative o di scelte impellenti, e il realizzarsi di un qualche obiettivo, anche se transitorio.
attribuisce a questa condizione, in cui è immerso il politropo empirico-trascendentale, lo sviluppo della sua capacità di oscillare, pulsare continuamente, tra il progetto sincronicamente concepito e la necessità di comunicarlo per il tramite di uno strumento non sincronico, bensì diacronico, quale è il linguaggio.
Questa differenza irriducibile e questa inconciliabilità inevitabile, rendono possibile il rimanere sorpresi dal proprio linguaggio, dal proprio dire in maniera lineare ciò che fino a un attimo prima dell’inizio del discorso appariva multiordinale e sincronico, quindi indicibile.
Bisogna opportunamente ricordare che questa riflessione del pensiero piriano ha avuto, nella storia della sua ricerca, un continuo e ostinato riscontro nelle sue prassi, sia didattiche sia di cura, e distinguo solo per comodità espositiva la didattica dalla cura creando indubbiamente un artificio, anche se provvisoriamente utile.
Ma proseguendo nella ricerca P. riferisce di un grande inespresso continuamente fluente che, sussumendo operazionalmente le descrizioni della conoscenza traversante, del campo antropico continuo, dell’attraversamento campale dell’interiorità etc., si costituisce come protensione[31] non espressa appunto, ma tuttavia capace di attraversare l’ interiorità.
A questo punto il pensiero di P., assumendo anche un certo incedere poetico, esprime un’opinione molto profonda sulla condizione disperata degli schizofrenici: essi forse avvertono le tematiche del grande inespresso continuamente fluente, ma hanno agli occhi di chi è nel campo antropico, immediatamente adiacente ma anche in ambiti più estesi, la stessa credibilità di un rabdomante.
Come una partitura
Dopo aver riportato, sia pur sinteticamente, i temi della ricerca piriana sulle fasi iniziali dello sviluppo del politropo empirico-trascendentale, ritengo sia necessario riferire come esso prosegua il suo destino e seguendo quali tracce possa operare la cura nei propri confronti e nelle relazioni.
E soprattutto come si muova nel campo antropico continuo, da quali dinamiche sia vorticosamente catturato, come queste dinamiche lo attraversino e cosa riescano a innescare nella sua interiorità fluente.
Occorre a questo punto ribadire una doverosa precisazione che riguarda la coscienza, precisazione che prende spunto dalla citazione di un passo di Husserl[32]: «[…]In un senso amplissimo l’espressione “coscienza” abbraccia (ma vi è poco adatta) tutti gli Erlebnisse».
(con molta presunzione e qualche rischio, avverte egli stesso) espone la sua critica al passo citato, sottolineando la differenza tra coscienza ed Erlebnis:
[…] la coscienza sembra appartenere solo a se stessa e, se osservata, si spacca subito in una coscienza riflettente ed in una coscienza riflessa, e la prima, se osservata, nuovamente si spacca e così via, nell’infinito ritirarsi di ciò che è riflettente come altro da ciò che è riflesso […] Per quanto riguarda invece […] l’Erlebnis, per il fatto di dover essere sempre riflesso e non poter essere mai riflettente, sembra già porsi nelle strutture fluenti dell’interiorità, cioè di quello a cui proprio si volge la coscienza tetica dell’attraversamento degli accadimenti antropici del singolo (interiorità fluente)[33].
Nel disperato tentativo di mettere ordine a questo scritto si potrebbe a questo punto schematizzare il tragitto fin qui seguito e quello che si sta per seguire: dalla prima configurazione di una coscienza pre-tetica e ante-predicativa si è riferito del formarsi della coscienza tetica del mondo e poi di sé, quindi della coscienza tetica dell’interiorità fluente.
afferma che questa coscienza di transizione determina l’artefatto all’illusione dell’unità intensionale del soggetto contribuendo al formarsi di vissuti di interiorità; procedendo quindi verso la manifestazione del linguaggio e la maturazione della coscienza riflessiva piena si verifica la separazione disastrosa, la frattura tra ragione e passione dell’originale noema unitario.
È d’uopo ora prendere in considerazione come questa singolarità pluripersonale si muova nel campo antropico continuo; quali influenze abbia questo campo sul suo comportamento e, non dimenticando che la ricerca di P. è tutta orientata verso un continuo rincorrersi tra teoria e prassi, quali conseguenze comporti il loro reciproco e incessante influenzarsi alla singolarità pulsante nel suo tragitto diadromico, all’interno del gruppo in cui vive e agisce.
L’osservazione e la ricerca su questi temi mostrano l’incessante intrecciarsi di eventi e accadimenti in senso diacronico, e il sincronico presentarsi dell’enorme attimo veniente: il paragone adatto a suggerire un’immagine utile a descriverne le dinamiche è la partitura musicale.
Essa infatti è semiograficamente organizzata per riportare la notazione musicale in senso verticale (la struttura armonica di una composizione) e in senso orizzontale (la linea melodica): per poter essere eseguita il direttore d’orchestra non può non indugiare su di essa con sguardo pancronico.
4. L’abito longitudinale
Il campo antropico continuo è definibile come un insieme di eventi e accadimenti, dei primi, come già detto, si può solo inferire perché hanno, afferma P., carattere molecolare e quindi non possono essere nominati, essi potrebbero essere in qualche modo assimilati (è una semplificazione di chi scrive) a fenomeni subliminari.
I secondi invece, gli accadimenti, hanno carattere molare (il parallelo con la chimica ha lo scopo di raffigurarne la complessità) cioè sono composti, percepibili, avvertibili, nominabili.
Di conseguenza la donna e l’uomo vivono immersi in un campo continuamente e incessantemente attraversato da eventi e accadimenti che si dispiegano nella dimensione planetaria ma che non hanno, ovviamente, tutti la stessa prossimità alla singolarità multipersonale.
Schematicamente, e artificialmente per chiarezza espositiva, possiamo distinguere un campo antropico contiguo alla singolarità che avrà influenze maggiori su di essa di quanto non possano averne invece le zone più periferiche.
Tale parte del campo antropico costituisce il sistema doxo-axio-ideologico locale, a sua volta costituito da porzioni del campo ulteriormente, sia pur artificialmente, divisibile in svariati ambiti sociali, o gruppi sintelici[34].
L’immersione in questo universo di eventi e accadimenti comporta il costante attraversamento di radiazioni microsemiotiche traversanti e di afferenze macrosemeiotiche sincroniche.
È opportuno a questo punto ricordare che il linguaggio deforma, nella nominazione, lo spazio interiore che queste radiazioni attraversano, e artificiosamente lo denota come soggetto o persona o individuo etc..
Questo artificio linguistico nasce dall’impossibilità, per uno strumento a stendimento diacronico come è appunto il linguaggio, di narrare circa il magmatico brulichio presente nel campo antropico.
Ma l’immersione zigzagante in esso, descrivibile approssimativamente come un andamento perennemente oscillante tra le innumerevoli radiazioni e afferenze che costituiscono l’enorme attimo sincronico, e al contempo la protensione verso il tempo immediatamente sopravveniente, alludono a una indescrivibile dimensione pancronica.
La singolarità pluripersonale pertanto è in continua e inarrestabile trasformazione, vestendo in ogni circostanza l’abito che maggiormente si confà: ne ha a disposizione vari e di diversa importanza gerarchica, li alterna in relazione alla protensione da cui è spinto.
Possiede indubbiamente un abito mutazionale prevalente, che si manifesta quindi per maggior tempo nel corso della sua esistenza, un abito longitudinale; ne ha però anche altri adiacenti, più o meno remoti, o lontani come ombre.
Per questo P. afferma che «l’interiorità nella riflessione lacerata di una singolarità pluripersonale non può mai porre la tesi di una propria stabile identità»[35], e utilizza la metafora inquietante di un’identità pulsante che si asserisce e si nega in una diadromia illimitata.
La conclusione provvisoria di questa affermazione contempla necessariamente l’impossibilità per l’interiorità a separarsi dal mondo o a proclamare l’indipendenza da esso: la sua dipendenza da tutti gli eventi del mondo e la sua sensibilità a tutti gli eventi del mondo coincidono pienamente con il suo eterno manifestarsi e il suo continuo esprimersi nel mondo.
Questa fondamentale affermazione (va comunque ribadito che sempre gli scritti di P. terminano con l’avvertimento che ogni enunciato debba intendersi preceduto da opportuno atteggiamento proposizionale: io credo, le mie ricerche mi hanno portato a ritenere che, etc.) comporta una serie di conseguenze operative di portata enorme che hanno caratterizzato la ricerca di P. e immediatamente il suo agire politico nelle varie fasi della sua vita; naturalmente non è possibile che queste riflessioni ne riferiscano, focalizzate come sono sui risultati di una pluridecennale attività di ricerca e di studio circa un ambito specifico cui il titolo di questo scritto allude.
Ma ciononostante credo utile un rimando bibliografico a Le tecniche della liberazione[36], testo che descrive appunto anche le conseguenze operative del pensiero di P., allo scopo di connettere teoria e prassi immerse come sono nell’intreccio e nel continuo evolversi del campo antropico all’interno del quale la singolarità pluripersonale esiste e si esprime.
Occorre a questo punto introdurre un riferimento specifico alla modalità con la quale la singolarità si rapporta al tempo sopravveniente: P. parla di un legame al tempo (cronodesi), legame che consente cioè di affrontare gli orizzonti che incessantemente si aprono alle trasformazioni del campo antropico.
Ma nel confronto con il futuro prossimo è necessario operare una pausa cronodetica, pausa che permette, attraverso la riflessione, di far prevalere le linee più avanzate presenti nel campo antropico, a dispetto di un’azione spontanea che, secondo P., sarebbe improntata all’odio.
La pausa consente inoltre all’operatore trasformazionale di avvertire, con ironia, la propria emotività e di sperimentarla nella relazione di cura o di insegnamento come irrinunciabile strumento di trasformazione sociale[37].
5. Conclusione
La conclusione, come a questo punto risulta ampiamente prevedibile, non può che essere provvisoria e quindi può coerentemente cercare solo di alludere agli svariati altri campi di discussione e di problemi in divenire.
Ma per suggerire alcune indicazioni utili mi limito a segnalare qualche spunto che potrebbe incuriosire chi legge.
Sarebbe a mio avviso interessante proseguire nella ricerca piriana focalizzando le tematiche relative ai rapporti teorici con il pensiero di Husserl e di Lacan, suggerirei ad esempio un approfondimento sulla fase dello specchio in confronto allo sviluppo della coscienza tetica.
Altrettanto fecondo potrebbe risultare il confronto con Sartre e con lo sviluppo della neuroprogrammazione linguistica.
Analogamente mi sembrerebbe interessante indagare i rapporti tra la concezione di P. sulla questione dell’inconscio e il materialismo dialettico, o quelle che riguardano il così detto abito mutazionale e la Gestalt.
E naturalmente ritengo che proprio in virtù della sottolineatura metodologica sulla necessità di pervenire a sintematiche, in grado di raccogliere elementi residuali delle scienze umane e di allargare l’angusto orizzonte delle psicologie del novecento, la ricerca puntuale e appassionata di P. possa risultare un’occasione di confronto con vari saperi e soprattutto, credo avrebbe raccomandato egli stesso, di trasformazione dell’operatività.
Ritengo doveroso sottolineare ancora una volta, al termine di questo scritto, l’arbitrarietà della scelta degli argomenti trattati e ricordare al lettore che ho dovuto trascurare, per comprensibili limiti dimensionali, passaggi estremamente importanti evidenziati nella ricerca di P..
In primo luogo il concetto di Non-I, vale a dire non-identità + non-innocenza, presupposto irrinunciabile per qualunque prassi politica, umana o di cura.
Il concetto di non-identità viene in qualche modo riferito in questo scritto; non altrettanto quello di non-innocenza, pertanto, con tardivo intento riparatorio, ne abbozzo solo una breve definizione che ha lo scopo di evidenziare quanto sia importante l’atteggiamento proposizionale assunto da P. nel corso della sua ricerca e quanto esso debba valere nella pratica.
Con il termine non-innocenza si vuol sottolineare, se lo riferiamo soprattutto al ricercatore, la necessaria messa in crisi di ogni idea e/o terminologia che, chiusa in un sistema autoreferenziale, costituisca punto di riferimento immutabile e calcareizzato delle scienze (malamente dette) umane.
Ed è di fondamentale importanza questo passaggio perché costituisce da un lato la testimonianza della sterminata curiosità di P., e dall’altro, cosa ben più importante e carica di conseguenze nelle prassi, indica con decisione la necessità impellente per ogni operatore di vivere incessantemente la crisi del sistema doxo-axio-ideologico in cui è immerso, e nel quale rischia di muoversi solo passivamente se accettasse supinamente ciò che i “sacri libri” affermano.
Per chi scrive questa è stata le lezione esistenziale più perspicace e utile; ma vorrei concludere non con ipostatizzazioni di qualunque genere, bensì con qualche domanda impossibile che farei a P., se fosse ancora vivo.
Gli chiederei, ad esempio, cosa intende per solitudine come conquista gioiosa, al di là della ovvia e facilmente intuibile opposizione con l’isolamento antropico.
Gli chiederei anche in che modo e attraverso quali vie gli schizofrenici avvertano il grande inespresso continuamente fluente e, in ultimo, gli leggerei una splendida poesia di Alda Merini che, a parte il diverso contesto in cui la poetessa la colloca, esprime in un tempo il piacere connesso a vivere i confini come conquista e la necessità di non rimanere chiusi al loro interno come in una gabbia.
E credo che Sergio avrebbe apprezzato anche la metafora linguistica cui allude.
Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra,
varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni.
Buon limite a tutti! (T. Eliot, Cocktail party)
[1] Ogni esistenza singola e ogni aggregato antropico in qualche modo nominabile, sono gettati in un campo antropico di scambi informazionali, emozionali, culturali, doxici, ideologici, lirici, espressivi etc. che è continuo perché è esteso quanto l’umanità ed è continuamente mutevole perché contiene tutti gli eventi dell’accadere antropico in continua interazione, cfr. S. Piro, Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, La Città del Sole, Napoli 2005, p. 64.
[2] Nella terminologia usata da P., terminologia peraltro ricca di neologismi, tale adesione al tempo, il legame al tempo (cronodesi), indica l’essere nel tempo di tutti gli eventi umani in un’accezione molto vasta che allude al legame dell’uomo con gli orizzonti sopravvenienti, incessantemente cangianti e tumultuosi. La cronodesi inoltre rappresenta il tramite che rende possibile afferrare il presente e il passato come conoscenza e non come evanescenza.
[3] La ricerca sull’accadere non può in alcun modo prescindere dalla sua immersione nell’accadere: il piano ontico si disvela deloticamente solo nell’onticità dell’accadere, cfr. Id., Introduzione alle antropologie trasformazionali, La Città del Sole, Napoli 1997, p. 591.
[4]«[…] nelle applicazioni fattuali cliniche, dalla nascita a ora, il nesso psicoanalitico appare di fatto come retrospettivo, unilineare, deterministico […]», Id., Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 136.
[5] «Diadromia:[…] proliferazione locale di spunti teorici mutualmente incompatibili, intendendosi per locale l’inerenza a un sottoinsieme accadimentale limitato, parziale e in qualche modo specificamente nominabile», ibid., p. 240.
[6]«[…]Una sintematica non è una disciplina, bensì un gruppo di temi interpolati, connessi, disgiunti complanarmente, allusi, labili, senza infrastruttura politica e accademica», ibid., p. 24.
[7] Id., Il linguaggio schizofrenico, Feltrinelli, Milano, 1967.
[8] I residui storici, teorici o operazionali, passano dai modelli paradigmatici precedenti ai successivi assumendo un senso differente, più amplio o più ristretto.
[9] «Il futuro prossimo è l’unico presente, il presente attuale, che abbia luce, pulviscolo luminosissimo di atti protensionali, brulicare asincrono e disordinato di mete vicine, raggiunte e subito dissolte: questo altro presente del futuro prossimo, un presente molecolare, non è affatto sincronico perché si estende negli intervalli diacronici di atti innumeri e tra loro asincroni fra la protensione e il raggiungimento, fra il progetto e l’evento … La comprensione degli eventi del mondo e la comprensione degli eventi umani … si svolgono nel futuro prossimo», Id., Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 274.
[10]Nei confronti della psicoanalisi la critica di P. riguarda prevalentemente due questioni fondanti: la cosificazione delle istanze psichiche e il determinismo retrospettivo e unilineare. Si rimanda però all’opera di P., nel suo complesso, per un approfondimento di questa tematica.
[11] La parola destino viene usata da P. nel significato della seconda accezione che il Grande dizionario della lingua italiana di Battaglia indica come “sorte”: quello che il futuro riserba (a una persona, anche a una cosa).
[12] Il termine trasformazionale in P. denota una prassi e un obiettivo del ricercatore, a differenza dell’uso che ne fa Chomsky più riferito alle dinamiche linguistiche.
[13] S. Piro, Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 265.
[14] Molto suggestiva risulta, in questa definizione, la coincidenza terminologica tra Pirandello e P.
[15] R. Bodei, Destini personali, Feltrinelli, Milano 2002, p. 145.
[16] S. Piro, Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 303.
[17] È definita da P. come disciplina provvisoria. Delotica: δηλώσις «evidenza, manifestazione».
[18] P. intende con questo termine indicare l’insieme delle opinioni, degli assiomi e delle ideologie presenti in un campo antropico.
[19] P. si riferisce al termine foucaultiano allotropo empirico-trascendentale, ma intende ampliarne gli orizzonti di significato, pertanto introduce il termine politropo empirico-trascendentale. Ciò allo scopo di sottolineare la pluralità dei rimandi e dei multipli traversamenti di ogni singolarità.
[20] Cfr. S. Piro, Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 53.
[21] Il riferimento a Husserl è esplicito.
[22] Ritengo che nell’usare tale terminologia P. abbia voluto riferirsi a una frattura che si realizza in un corpo duro, quale ad esempio è la roccia, cui nell’uso comune tale parola viene riferita, per sottolineare la precedente compattezza del noema.
[23] Con questo termine P. intende esplicitamente riferirsi ancora una volta a Husserl piuttosto che alle varie accezioni che esso ha assunto da Parmenide in poi.
[24] P.2005 Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, La Città del Sole, Napoli, p. 494.
[25] Ibid., p. 304.
[26] Ibid., p. 59.
[27] Ibid., p. 269.
[28] S. Piro, Esclusione Sofferenza Guerra, La Città del Sole, Napoli 2002.
[29] Id., Trattato sulla psichiatria e le scienze umane. I: Euristica connessionale, Idelson, Napoli 1986, pp. 320-321
[30] Per “evento” P. intende ciò che non può essere nominato e di cui si può solo inferire in quanto hanno carattere molecolare; per “accadimento” invece intende ciò che può essere nominato perché composito, molare. Tuttavia talvolta P. utilizza il termine evento anche per indicare ciò che può essere nominato; ma tali casi sono opportunamente segnalati.
[31] Id., Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., p. 66.
[32] E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1913), tr. it. Einaudi, Torino 1950, p. 117.
[33] S. Piro, Trattato della ricerca diadromico trasformazionale, cit., pp. 57-59.
[34] P. definisce il gruppo sintelico come un aggregato antropico più o meno circoscritto in cui vivono attori che condividono un insieme di opinioni, assiomi culturali e ideologie e quindi anche parti dimensionalmente variabili di scopi e sovra-scopi. Naturalmente esistono anche aggregati dissintelici; ma purtroppo dolorosamente tale argomento, pur costituendo un passaggio fondamentale del pensiero di P., in questo scritto viene arbitrariamente rimandato ad altra più approfondita e completa esposizione.
[35] Ibid., p. 271.
[36] Id., Le tecniche della liberazione, Feltrinelli, Milano 1971.
[37] P. afferma che questa modalità di procedere dell’operatore trasformazionale si trova in sintonia con quanto afferma la metodologia psicoanalitica contro ogni interpretazione selvaggia o affrettata.