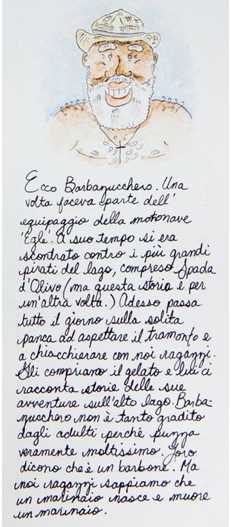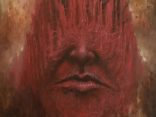Autore
Indice
- Introduzione: cause e ragioni
- La spiegazione causale e il modello nomologico-deduttivo
- La spiegazione dell’azione: il modello del sillogismo pratico
- Osservazioni conclusive
S&F_n. 16_2016
Abstract
Causes and Reasons: explicative Models in natural and human Sciences
Starting from Wittgenstein’s distinction between causes and reasons of an action, the paper presents two influential models in the methodology of explanation: the deductive-nomological model elaborated by C. G. Hempel and the model based on Aristotle’s practical syllogism, in G. H. von Wright’s version. The controversy between methodological monism and methodological dualism, which has its roots in the opposition between explaining (Erklären) and understanding (Verstehen), is examined.
-
Introduzione: cause e ragioni
In un discorso pronunciato a Princeton nel 1975 durante un festeggiamento dedicato all’epistemologo tedesco Carl Gustav Hempel, autorevole membro dell’emigrazione neo-positivista in USA degli Anni Trenta, Donald Davidson parla di «una fortissima corrente di libretti rossi neo-wittgensteiniani», contro la quale lo stesso Hempel avrebbe navigato tra la fine degli Anni Cinquanta e i primi Anni Sessanta[1]. Quelli che Davidson chiama un po’ sprezzantemente, e con una certa dose di perfida ironia sulla natura della relazione tra i «seguaci» di Wittgenstein e il loro Maestro, «libretti rossi neo-wittgensteiniani», sono, in realtà, una serie d’importanti lavori sulla filosofia dell’azione, pubblicati grosso modo dall’inizio degli Anni Cinquanta in poi, e uniti, appunto, dal fatto di trarre comune ispirazione dall’opera del secondo Wittgenstein. Com’è noto, a partire dalla comparsa delle Philosophische Untersuchungen nel 1953, gli esecutori testamentari di Wittgenstein, tra cui Gertrud Elisabeth Margaret Anscombe e Georg Henrik von Wright, cioè due dei protagonisti principali delle vicende filosofiche che ci accingiamo a raccontare, avevano dato avvio alla pubblicazione di alcuni dei tanti materiali che lo stesso Wittgenstein aveva lasciato inediti. Nel 1958 erano stati pubblicati i Blue and Brown Books, risalenti agli anni 1933-35, ed è proprio nel Blue Book che si trovano alcune celebri osservazioni di Wittgenstein sulla necessità di tracciare una netta distinzione tra cause e ragioni delle azioni, una distinzione di cruciale importanza per chiarire la struttura logica della spiegazione delle azioni intenzionali. Vediamo brevemente in cosa consista questa distinzione[2].
Wittgenstein immagina questa situazione: ho spiegato a qualcuno il significato della parola “rosso” indicando un pezzo di carta e dicendo che, con la parola “rosso”, s’intende il colore di quel pezzo di carta (il colore del pezzo di carta, cioè, è usato come campione del rosso); poi impartisco al mio interlocutore l’ordine di dipingere una macchia rossa e, dopo che l’ordine è stato eseguito, gli domando: “Perché, eseguendo il mio ordine, hai dipinto una macchia che ha proprio questo colore?”. In risposta alla domanda, l’interlocutore giustifica la propria azione, cioè il fatto di aver dipinto una macchia che ha proprio quel colore lì, dicendo che ha dipinto una macchia dello stesso colore del campione usato per spiegare quale colore la parola “rosso” designa. Sono molte le questioni semantiche che potrebbero essere sollevate in relazione a questo esempio, ma, nel contesto in esame, Wittgenstein focalizza la propria attenzione sulle caratteristiche salienti della risposta dell’interlocutore alla domanda: «Egli mi ha ora dato una ragione di eseguire l’ordine così, come egli ha fatto. Dare una ragione di qualcosa che si è fatto o detto significa mostrare una via che porta a questa azione»[3]. Al di là del tema, che si affaccia subito dopo il passo citato, del possibile regresso all’infinito nel processo del fornire le ragioni di un’azione, e di quello, a esso collegato, dell’esistenza di un termine in ogni effettivo processo di razionalizzazione di un’azione (la catena delle ragioni ha di fatto un termine, il regresso si arresta da qualche parte), il punto per noi decisivo è quello in cui Wittgenstein immagina che alla reiterata domanda iniziale, cioè alla domanda “Perché, eseguendo il mio ordine, hai dipinto una macchia che ha proprio questo colore?”, l’interlocutore ora risponda che lo ha fatto perché, tutte le volte che sente la parola “rosso”, gli viene in mente un’immagine del colore che ha poi riprodotto dipingendo la macchia. Il commento di Wittgenstein è che, con questa risposta, la struttura logica della spiegazione è cambiata: l’interlocutore ha fornito una causa della sua azione, non una ragione.
L’esempio discusso da Wittgenstein mostra, innanzitutto, che l’avverbio interrogativo “perché” è semanticamente ambiguo: esso può essere usato tanto allo scopo di chiedere qual è la ragione di un’azione, quanto allo scopo di chiedere qual è la causa di quella stessa azione. Ora, dove sta la differenza tra i due casi? Fornendo la causa, viene indicata una regolarità di connessione tra fenomeni, sperimentata fino a ora (l’udire la parola “rosso” è regolarmente associato al presentarsi alla mente di un’immagine di un dato colore; il presentarsi di questa immagine mentale è regolarmente associato, in un contesto come quello immaginato, al dipingere una macchia del colore dell’immagine mentale), e, in via esplicativa, si riconduce l’azione al fatto che quella connessione si è ripresentata anche nel caso particolare in esame. Fornendo la ragione, invece, non si è fatto appello a nessuna connessione regolare di fenomeni ma, piuttosto, al significato che il termine “rosso” ha ricevuto tramite la definizione ostensiva, e al fatto che un’azione non può essere l’esecuzione dell’ordine impartito, nella cui formulazione verbale compare la parola “rosso”, se la macchia dipinta non è del colore che quella parola designa. Qui l’impossibilità è di natura logico-semantica, concettuale, o, nel gergo di Wittgenstein, grammaticale: non avrebbe senso affermare che si è obbedito a quell’ordine dipingendo una macchia verde, com’è provato dal fatto che, a chi avesse dipinto una macchia verde, diremmo qualcosa come: “ti avevo ordinato di dipingere una macchia rossa; non sai quale colore è il rosso? non sai che significa la parola ‘rosso’?”. In generale, in una spiegazione causale di un’azione ci si basa sull’esistenza di una connessione regolare, osservata finora, tra certi tipi di eventi (condizioni) e certi altri tipi di eventi (effetti), e si spiega il prodursi di una determinata azione come un caso particolare di quella connessione: la spiegazione causale, quindi, colloca l’azione nello spazio dei fatti. Al contrario, l’asserzione che quella stessa azione ha una certa ragione non poggia sull’assunzione di qualche regolarità di successione tra fenomeni, ma sull’esistenza di relazioni grammaticali tra gli enunciati che descrivono l’azione e gli enunciati che esprimono le ragioni: la spiegazione mediante ragioni, quindi, colloca l’azione nello spazio delle norme. La conoscenza certa dei motivi (ragioni) di un’azione da parte dell’agente è spesso contrapposta alla conoscenza solo congetturale delle sue cause. I motivi appaiono come “cause viste dall’interno”, con cui l’agente sarebbe in una relazione di tale prossimità da non potersi sbagliare sulla loro esistenza e sui loro effetti. Questa contrapposizione, secondo Wittgenstein, poggia su un fraintendimento, perché, nel caso della relazione motivi/azione, non è in ballo una posizione epistemica privilegiata dell’agente circa una presunta relazione causale tra eventi, ma la sua padronanza di una relazione puramente semantica.
Dal punto di vista metodologico, il caso della spiegazione delle azioni umane è particolarmente interessante perché, come abbiamo visto, una stessa azione può essere spiegata sia adottando il punto di vista delle ragioni che quello delle cause (si potrebbe dire, kantianamente e senza eccessive forzature: sia il punto di vista noumenico, sia quello fenomenico). Tuttavia, una più precisa articolazione dei due modelli esplicativi può essere ottenuta separando, almeno provvisoriamente, il dominio delle spiegazioni causali da quello delle razionalizzazioni, o spiegazioni mediante ragioni (senza con ciò pregiudicare la questione dell’eventuale riducibilità delle seconde alle prime). Le spiegazioni causali sono tipiche delle scienze naturali, dove l’oggetto di studio è costituito da eventi e regolarità fisiche, chimiche, biologiche ecc., mentre le razionalizzazioni sono tipiche delle scienze umane, dove l’oggetto di studio è costituito dalle azioni, e ciò che interessa sono le ragioni degli agenti nel fare quello che fanno, individualmente o collettivamente. Il dibattito sulla metodologia della spiegazione all’interno della filosofia analitica finisce così per incrociarsi fruttuosamente con la tradizione di ricerca epistemologica d’ispirazione anti-positivistica che prende le mosse dalla celebre distinzione di Droysen tra lo spiegare (Erklären) e il comprendere (Verstehen), che passa, tra gli altri, per autori come Windelband, Rickert, Simmel, Dilthey, con la sua altrettanto celebre opposizione tra Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften, e che arriva fino a Weber e oltre.
- La spiegazione causale e il modello nomologico-deduttivo
Senza dubbio, la tradizione di studi metodologici di matrice analitica non è mai stata tenera col concetto di causalità. Due padri di quella tradizione, e cioè Ernst Mach e Bertrand Russell, si erano già decisamente espressi a favore della sostituzione della nozione di connessione causale tra eventi con quella di correlazione funzionale (argutamente, Russell nel 1912 osservava: «la legge di causalità, come molto di ciò che viene apprezzato dai filosofi, è il relitto di un’età tramontata, e sopravvive, come la monarchia, soltanto perché si suppone erroneamente che non rechi danno»[4]). All’origine della concezione della spiegazione causale elaborata, nelle forme più raffinate, dai due autori che rappresentano il culmine della riflessione metodologica neo-positivistica, cioè Carl Gustav Hempel ed Ernest Nagel, e condivisa da un epistemologo critico del neo-positivismo quale Karl Popper, c’è la celebre analisi di Hume degli asserti d’imputazione causale in termini di congiunzione costante degli eventi di certi tipi e di uniformità fenomeniche de facto. In realtà, anche le brevi considerazioni di Wittgenstein sulla natura della spiegazione causale di un’azione e sul ruolo indispensabile che in essa svolgerebbe l’esistenza di connessioni regolari tra certi tipi di eventi, sono indebitate con quell’analisi. La sostanza dell’analisi di Hume, per la parte rilevante ai nostri fini, può essere così riassunta: quando si afferma che un particolare evento e è stato causato da un particolare evento c s’intende che c è un evento del tipo C, e un evento del tipo E e, come dato di fatto osservabile, tutti gli eventi del tipo C sono regolarmente seguiti da eventi del tipo E. Così, l’asserzione che la caduta di un dato bicchiere di cristallo da una certa altezza ne ha causato la rottura, equivale all’asserzione che i due fenomeni in questione sono solo un caso particolare della sequenza regolare che lega, di fatto, tutti gli eventi del primo tipo (cadute di oggetti di un certo materiale e di una certo spessore da una certa altezza) con gli eventi del secondo tipo (rotture di quegli oggetti): che la sequenza regolare tra i fenomeni dei due tipi continuerà a valere in futuro, è una generalizzazione induttiva fondata sull’osservazione di quanto avvenuto in passato[5].
Com’è noto, l’obiettivo principale dell’analisi humiana degli asserti d’imputazione causale riguarda la presunta natura necessaria del nesso tra i fenomeni dei due tipi coinvolti. Nonostante le numerose critiche di cui è stata oggetto l’idea humiana che, nello spiegare l’universalità nomica, si debba fare a meno di nozioni modali come quella di necessità fisica (distinta dalla necessità logica) in favore della mera regolarità de facto, il modello nomologico-deduttivo della spiegazione scientifica, detto anche “modello di spiegazione per sussunzione” o “modello della legge di copertura”, elaborato da Hempel e Popper, generalizza e articola ulteriormente lo schema esplicativo di Hume. Vediamo come, partendo da un esempio discusso dallo stesso Hempel[6]. Supponiamo che si voglia spiegare l’esplosione del radiatore di una certa automobile stanotte, cioè rispondere alla domanda: perché il radiatore è esploso? Innanzitutto, si elencano una serie di fatti particolari: il radiatore era pieno d’acqua; il tappo era ermeticamente avvitato; non era stato aggiunto l’antigelo; l’automobile era nel cortile; la temperatura era scesa molto al di sotto dello zero (questi eventi o stati di cose particolari si chiamano antecedenti causali dello scoppio del radiatore). Poi, si fa appello a qualche legge fisico-chimica generale, tra cui quella che afferma che l’acqua ghiaccia alla temperatura di zero gradi; quella che afferma che l’acqua, trasformandosi in ghiaccio, aumenta di volume; quella che riguarda l’elasticità del materiale di cui è fatto il radiatore, e altre ancora (qui si parla di leggi generali perché, a differenza degli enunciati che descrivono gli antecedenti causali, esse descrivono il comportamento di un qualunque campione d’acqua, o di un qualunque campione del materiale del radiatore, quando si trovino in certe specificate condizioni). La spiegazione consiste, allora, nel dedurre logicamente l’enunciato che descrive l’evento da spiegare (enunciato che è detto explanandum della spiegazione) dall’insieme di enunciati composto: 1) dagli enunciati singolari che descrivono gli antecedenti causali dello scoppio (eventi e stati di cose particolari) e, 2) dalle leggi generali che enunciano connessioni nomiche tra i tipi di eventi di cui gli eventi effettivamente avvenuti sono semplici casi particolari, e che permettono, quindi, di istituire una connessione tra gli antecedenti causali e i loro effetti (gli enunciati delle due specie, nel loro insieme, formano il cosiddetto explanans della spiegazione). Ad esempio, tra le leggi impiegate nella spiegazione dello scoppio del radiatore c’è quella che afferma che l’acqua, quando ghiaccia, aumenta di volume, mentre tra gli enunciati singolari c’è l’enunciato che afferma che stanotte l’acqua nel radiatore della macchina si è ghiacciata: se ne potrà dedurre, per via puramente logica, che stanotte l’acqua nel radiatore è aumentata di volume. Questa deduzione costituirà un passo nel processo deduttivo che ha come sua conclusione l’explanandum. Si noti che, invertendo l’ordine temporale, con la stessa deduzione si sarebbe potuto, non spiegare, ma prevedere l’esplosione del radiatore, dati gli antecedenti e le leggi fisico-chimiche pertinenti.
Il modello nomologico-deduttivo della spiegazione può essere rappresentato in forma schematica, evidenziandone così la portata generale. Con E indichiamo l’enunciato che descrive l’evento da spiegare; con C1, C2, … , Ck gli enunciati singolari che descrivono i fatti particolari che entrano nella spiegazione, e con L1, L2, … , Lr le leggi generali esprimenti uniformità tra gli eventi dei tipi pertinenti. Allora, una spiegazione dell’evento descritto da E, conforme al modello nomologico-deduttivo, è un argomento deduttivo che ha la forma seguente:
C1, C2, … , Ck
L1, L2, … , Lr
____________
E
dove C1, C2, … , Ck, L1, L2, … , Lr sono le premesse ed E è la conclusione. La spiegazione, dunque, consiste nella sussunzione deduttiva dell’explanandum sotto principi che hanno il carattere di leggi generali, e risponde alla domanda: “Perché l’evento E è accaduto?” mostrando che esso è il risultato prodotto dalle particolari circostanze specificate dagli enunciati C1, C2, … , Ck in accordo con le leggi generali L1, L2, … , Lr
Ci sono ancora due aspetti della concezione hempeliana che occorre esaminare brevemente. Il primo riguarda la sua applicabilità, non solo a eventi singoli, ma anche a fatti generali, cioè alle stesse connessioni regolari di fenomeni. Un abbozzo di spiegazione (qualitativa) del perché, se si riscalda sufficientemente l’acqua, si produce del vapore (questo è un fatto fisico generale), suonerà grosso modo così: l’acqua è fatta di molecole in movimento, che si attraggono tra loro; il calore immesso aumenta l’energia cinetica media delle molecole, cioè le fa agitare sempre di più, fino a che la forza di attrazione tra le molecole non è più sufficiente a tenerle legate insieme; esse, allora, si disperdono separandosi l’una dall’altra, e poi volano via nell’aria formando il vapore. Questo schizzo di spiegazione è conforme al modello per sussunzione: l’enunciato che descrive un fatto generale (che, tutte le volte che l’acqua è riscaldata a sufficienza, si forma vapore) è dedotto dai principi ancora più generali della teoria sulla struttura molecolare della materia, dalle leggi della teoria cinetica del calore ecc. L’unica differenza rispetto alla spiegazione di un evento particolare è che, in questo caso, non intervengono enunciati singolari, che descrivono specifici eventi o stati di cose, ma solo enunciati che esprimono connessioni nomiche teoriche.
Il secondo punto da richiamare, pur senza entrare nei dettagli formali, è che il modello nomologico-deduttivo non è l’unico schema esplicativo identificato da Hempel nelle sue indagini metodologiche. Accanto a esso, ha un ruolo fondamentale il modello probabilistico, o statistico-induttivo. Anche nelle spiegazioni di questo secondo tipo, un particolare evento è spiegato sussumendolo sotto legge generali: tuttavia, queste leggi non sono asserti universali di connessine tra fenomeni (del tipo: tutte le volte che accade un evento di tipo A, accade un evento di tipo B), ma sono leggi statistiche, che specificano con quale probabilità statistica un evento di tipo B si presenta, se si verifica un evento di tipo A. Un dato evento è spiegato con successo usando questo modello quando si dimostra che era ragionevole aspettarsi che esso si verificasse, anche senza poterne avere la certezza, dato che si erano realizzate certe condizioni e che la probabilità statistica con cui si verificano eventi del tipo di quello da spiegare, tutte le volte che si realizzano quelle condizioni, è molto alta.
Ora che abbiamo un quadro più articolato di come vadano concepite le spiegazioni causali (che, per quello che abbiamo visto, costituiscono solo un caso particolare di spiegazioni nomologico-deduttive), possiamo riformulare con maggiore precisione e chiarezza il problema da cui siamo partiti, e cioè: la spiegazione delle azioni mediante ragioni, o razionalizzazione delle azioni, è conforme al modello nomologico-deduttivo? oppure presenta delle caratteristiche a esso irriducibili, come sostiene Wittgenstein nelle pagine del Blue Book esaminate nel paragrafo 1? Nel prossimo paragrafo vedremo come sia possibile identificare uno schema esplicativo generale, utilizzabile in molti casi di spiegazione tramite ragioni, che si contrappone per aspetti fondamentali al modello nomologico-deduttivo.
- La spiegazione dell’azione: il modello del sillogismo pratico
Com’è ben noto, la moderna scienza galileiana della natura è fondata su due pilastri: a) la matematizzazione della descrizione della natura attraverso la formulazione di leggi controllabili sperimentalmente, che collegano grandezze misurabili (come la legge della caduta dei gravi, che collega matematicamente lo spazio percorso da un grave in caduta libera alla durata temporale della caduta); b) l’espulsione delle nozioni finalistiche o teleologiche, abbondantemente presenti nella metafisica aristotelica, dall’apparato concettuale con cui si descrivono i fenomeni naturali. Ora, sono proprio i concetti che chiamerò genericamente “intenzionalistici”, quali i concetti di intenzione, di scopo, di significato ecc., che si rivelano indispensabili nella spiegazione delle azioni umane, individuali e collettive. Cominciamo con un esempio molto semplice: supponiamo che un signore, dal marciapiede di fronte, si giri verso di me e si tolga il cappello, magari con un sorriso, e supponiamo che qualcuno che non conosca i nostri usi e costumi mi chieda perché quel signore agisca così. Anche questa, naturalmente, è la richiesta di una spiegazione. In cosa consisterà qui la spiegazione? Senza dubbio, il nostro interlocutore non chiede di conoscere le cause per cui un corpo, un oggetto fisico, fa certi movimenti; chiede, piuttosto, di conoscere le ragioni per cui un certo uomo, un soggetto, agisce in un certo modo: l’evento osservato, cioè, è già preliminarmente compreso e descritto come un agire intenzionale di un individuo (un agente), non come un mero movimento di un corpo. Nel nostro caso, una buona spiegazione può essere fornita semplicemente dicendo che il signore in questione si è tolto il cappello perché intende salutarmi e perché conosce quell’istituzione sociale che è il salutare togliendosi il cappello, conosce il valore simbolico di quell’atto nella nostra cultura, e suppone che lo conosca anch’io. È evidente che in questa spiegazione non c’è nessun appello a una legge generale, ma solo una congettura sulle intenzioni dell’agente, assieme all’attribuzione della conoscenza di una pratica sociale che conferisce un particolare significato a un certo tipo di atto eseguito in un certo contesto, e che fa di quell’atto (il togliersi il cappello) il mezzo con cui poter realizzare una certa intenzione (quella di salutarmi).
Consideriamo ora un secondo esempio. Supponiamo che qualcuno veda un amico, Gianni, correre lungo la strada che porta alla stazione, e che chieda perché Gianni, invece di camminare tranquillamente, stia correndo a perdifiato lungo quella strada. Si può spiegare l’agire di Gianni attribuendogli, innanzitutto, un determinato scopo (ad esempio, Gianni vuole prendere il treno delle 10 per Roma), e poi attribuendogli la convinzione che solo correndo potrà arrivare alla stazione in tempo per prendere il treno (e realizzare così il proprio scopo). L’agire di Gianni, quindi, è spiegato inferendo da due premesse l’enunciato che lo descrive: la prima premessa riguarda l’obiettivo che congetturiamo Gianni stia perseguendo, la meta del suo agire, qualcosa che egli vuole fare (prendere il treno delle 10 per Roma), mentre la seconda riguarda una certa credenza, che ascriviamo a Gianni, sul ruolo del correre come mezzo idoneo al raggiungimento del suo scopo. Una siffatta spiegazione teleologica del modo in cui Gianni agisce (o ha agito) è un sillogismo pratico capovolto, nel senso che la conclusione descrive un’azione che egli sta compiendo (o ha già compiuto), non un’azione da compiere, e le premesse ne forniscono le ragioni[7]. Si noti che, mentre nel caso di una spiegazione per sussunzione le leggi sono assunte ipoteticamente come vere, nel caso di una spiegazione mediante un sillogismo pratico la seconda premessa non enuncia una connessione nomica generale vera tra l’uso di certi mezzi e il raggiungimento di un certo fine. Ciò che la seconda premessa fa è ascrivere all’agente la credenza che quella connessione mezzi/fine esista: per spiegare adeguatamente l’agire di Gianni, cioè, non è necessario che sia vero che, correndo, riuscirà a prendere il treno, basta che egli creda che sia così.
Una precisazione, prima di procedere a una generalizzazione: è ovvio che il modello esplicativo presentato col nostro esempio non si applica uniformemente a tutti i tipi di comportamento umano. Quando si chiede, ad esempio, perché un certo individuo si lamenta, e si risponde dicendo che ha mal di denti, si fornisce una spiegazione di un comportamento che non è descrivibile come un’azione, come un comportamento intenzionale (a meno che egli non si lamenti per raggiungere uno scopo, per esempio attirare l’attenzione dei presenti). Proprio perché non si tratta di un comportamento intenzionale, esso non è suscettibile di una spiegazione teleologica, finalistica, cioè conforme al modello del sillogismo pratico.
A questo punto, possiamo presentare lo schema esplicativo astratto, di cui i nostri precedenti esempi di spiegazione dell’azione sono applicazioni particolari. In un sillogismo pratico si spiega l’azione, descritta nella conclusione del sillogismo, partendo da una premessa maggiore, che riguarda la sfera motivazionale dell’agente, i suoi scopi, le sue intenzioni, le sue volizioni, i suoi desideri ecc., e da una premessa minore, che riguarda la sfera doxastico-cognitiva dell’agente, in particolare le sue credenze sulla pertinente relazione mezzi/fine. Indichiamo, allora, genericamente con “A” un qualunque soggetto, e rappresentiamo, sempre genericamente, le sue volizioni, intenzioni, desideri ecc. con lo schema enunciativo “A vuole che si realizzi p”, o, alternativamente, “A intende ottenere p”, “A mira a provocare p”, ecc., dove con “p” indichiamo una qualunque situazione che A voglia realizzare, ottenere, provocare ecc. (l’enunciato “Gianni vuole prendere il treno delle 10 per Roma” è un’esemplificazione dello schema enunciativo che stiamo considerando). Con lo schema enunciativo “A crede che p non si possa realizzare se non fa m”, o, alternativamente, “A pensa di non poter ottenere p se non fa m”, “A ritiene di non poter provocare p se non fa m” ecc., attribuiamo genericamente a un soggetto la credenza nel fatto che, solo facendo l’azione m, potrà realizzarsi la situazione p (così, l’enunciato “Gianni crede di non poter prendere il treno delle 10 per Roma, se non corre alla stazione” è un’esemplificazione dello schema enunciativo). La conclusione del sillogismo pratico è espressa genericamente dallo schema “A fa m”, o, alternativamente, “A si dispone a fare m”, “A inizia a fare m” ecc. (così l’enunciato “Gianni corre alla stazione” è un’esemplificazione dello schema enunciativo della conclusione). Lo schema del sillogismo pratico, dunque, è il seguente:
A vuole che si realizzi p
A crede che p non si possa realizzare se non fa m
_______________________________________
A fa m.
Diciamo, allora, che l’azione di un agente è spiegata teleologicamente quando l’enunciato che la descrive è deducibile come conclusione di un sillogismo pratico del tipo di quello rappresentato nella sua generalità dallo schema.
Va detto che il problema dello statuto logico degli argomenti che esemplificano lo schema è tutt’altro che banale. Si sostiene che il legame tra premesse e conclusione di un argomento del genere non sia empirico (causale), ma concettuale (logico); tuttavia, si tratterebbe di un legame sui generis, perché gli stessi sostenitori del cosiddetto Argomento della Connessione Logica riconoscono che tale legame non è identificabile sic et simpliciter con l’implicazione logica[8]. Comunque sia, si può a buon diritto sostenere che il sillogismo pratico fornisca alle scienze dell’uomo un modello di spiegazione che offre una valida alternativa al modello per sussunzione sotto leggi generali, in uso nelle scienze della natura. Ci si può fare un’idea delle potenzialità dello schema considerando un esempio di applicazione nella spiegazione di un evento storico, quale lo scoppio della prima guerra mondiale[9]. A volte in storia si usa la fraseologia causalistica, ad esempio quando si dice che l’assassinio dell’erede al trono dell’impero austro-ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando, a Sarajevo nel 1914 causò lo scoppio della prima guerra mondiale. Ora, è evidente che l’analogia con il caso di una scintilla che fa esplodere una polveriera, cioè con una genuina causazione di un evento da parte di un altro evento, spiegabile usando il modello della sussunzione a leggi, è davvero molto superficiale e, perciò, ingannevole. La struttura logica di una spiegazione accettabile può essere caratterizzata dicendo che una tale spiegazione consiste in una serie di sillogismi pratici tra loro concatenati, fondati sulle congetture che gli storici avanzano sia sullo sfondo motivazionale dei governanti dei paesi in gioco, sia sullo sfondo doxastico-cognitivo di quegli stessi governanti, in particolare circa la pertinente relazione mezzi/fini.
In uno scheletrico abbozzo, la spiegazione partirebbe da alcune congetture che ricostruiscono tanto le mire, gli scopi, le aspirazioni degli Asburgo nei Balcani, cioè lo sfondo motivazionale del governo austro-ungarico, quanto lo sfondo doxastico-cognitivo, su cui si va a inserire il fatto costituito dall’assassinio dell’arciduca; date quelle mire, un sillogismo pratico condurrebbe all’emissione dell’ultimatum alla Serbia da parte degli Austriaci, come atto ritenuto indispensabile per il raggiungimento dei loro obiettivi geo-politici. L’emissione dell’ultimatum alla Serbia si va a inserire, a sua volta, sullo sfondo doxastico-cognitivo dei governanti russi; date le mire geo-politiche dell’impero russo (lo sfondo motivazionale), sempre congetturalmente ricostruite dagli storici, un sillogismo pratico condurrebbe alla decisione dei Russi di ordinare la mobilitazione dell’esercito, giudicata il mezzo più adatto per raggiungere i loro scopi. La mobilitazione dell’esercito russo si va a inserire, a sua volta, sullo sfondo doxastico-cognitivo dei Serbi, che, dati i loro obiettivi, si sentono incoraggiati a rifiutare le condizioni poste dagli Austriaci con l’ultimatum; infine, un ulteriore sillogismo pratico porta gli Austriaci a dichiarare guerra alla Serbia. Come si vede da questi brevi cenni, la transizione dall’assassinio dell’arciduca allo scoppio della guerra si configura come una catena di azioni, ciascuna spiegabile in conformità al modello del sillogismo pratico. C’è un punto di portata generale che occorre mettere in risalto, prima di accennare brevemente ad alcuni dei problemi tuttora aperti. Una spiegazione storica conforme al modello del sillogismo pratico si configura certamente come una razionalizzazione a posteriori degli eventi; e, tuttavia, il razionalismo relativistico (razionalismo delle ragioni), che considera le azioni umane in rapporto agli scopi e agli orientamenti doxastico-cognitivi degli agenti, non va confuso con il razionalismo assoluto, che attribuisce un obiettivo, uno scopo, al processo storico nel suo complesso (razionalismo della Ragione).
- Osservazioni conclusive
In maniera molto sintetica, accennerò qui di seguito ad alcuni dei principali temi emersi nella discussione tra i sostenitori del monismo metodologico, che considerano le spiegazione mediante ragioni niente altro che una specie del genere più ampio delle spiegazioni causali, o nomologico-deduttive, e i sostenitori del dualismo metodologico, che concepiscono le razionalizzazioni come spiegazioni dotate di una struttura logica peculiare, non assimilabile a quella delle prime. La divisione tra i due campi può essere presentata, in prima approssimazione, nei termini seguenti: i causalisti, o monisti, ritengono che le intenzioni (volizioni, motivi, ragioni ecc.) funzionino come cause delle azioni; gli intenzionalisti, o dualisti, concepiscono la connessione tra intenzioni (volizioni, motivi, ragioni ecc.) e azioni come una connessione concettuale o logica. Le due posizioni possono essere chiarite, articolandole alla luce di quanto visto nei paragrafi precedenti: emergerà così che il perno attorno al quale ruota la controversia è costituito dal ruolo che le leggi generali svolgerebbero nella spiegazione dell’azione, individuale e collettiva (si riaffaccia, in forme nuove, l’opposizione, tracciata da Windelband, tra scienze nomotetiche, le scienze della natura, e scienze idiografiche, le scienze storiche). In base all’analisi delle imputazioni causali svolta nel paragrafo 2, sostenere che le intenzioni funzionino da cause dell’azione equivale a spiegare le azioni ricorrendo a leggi generali che colleghino le intenzioni di un certo tipo alle azioni di un certo tipo. Per dare concretezza alla nostra analisi, proviamo a riformulare in termini causali la spiegazione teleologica del comportamento di Gianni che corre verso la stazione. La spiegazione assumerebbe questa forma, conforme al modello nomologico-deduttivo:
(1) Gianni vuole prendere il treno delle 10 per Roma;
(2) Gianni crede che di non poter prendere il treno delle 10 per Roma, se non corre alla stazione;
(3) Tutti coloro che credono di non poter fare una certa cosa se non ne fanno un’altra, e vogliono fare la prima, fanno questa seconda cosa.
___________________________________________________________
(4) Gianni corre alla stazione.
Questo argomento deduttivo è conforme al modello della legge di copertura ed è valido, nel senso che la conclusione (4) segue logicamente dalle premesse (1)-(3). Perché la spiegazione sia una buona spiegazione, tuttavia, non basta che l’argomento sia valido, occorre anche che le sue premesse siano vere: il problema è che molto difficilmente la presunta legge universale (3) sarebbe considerata vera, se mai a qualcuno venisse in mente di formularla (cosa sarebbe? una legge della psicologia popolare non-scientifica?).
Una strategia riduzionistica più raffinata potrebbe essere la seguente[10]. L’argomento andrebbe esplicitato nel modo seguente:
(1) Gianni vuole prendere il treno delle 10 per Roma;
(2) Gianni crede che di non poter prendere il treno delle 10 per Roma, se non corre alla stazione;
(3) Gianni è un agente razionale;
(4) Tutti coloro che credono di non poter fare una certa cosa se non ne fanno un’altra, vogliono fare la prima e sono agenti razionali, fanno questa seconda cosa.
___________________________________________________________
(4) Gianni corre alla stazione.
Il punto è che, così, le difficoltà aumentano, non diminuiscono: infatti, a quale nozione di agente razionale stiamo facendo appello nella spiegazione? E che titoli di verità può vantare la presunta legge universale (4)?
Ancora più precario si rivela il tentativo di forzare una spiegazione storica nello schema nomologico-deduttivo. Di quale legge generale vera sarebbe un caso particolare il fatto che, per perseguire i propri obiettivi geo-politici dopo l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo nel 1914, l’Austria-Ungheria emise il suo ultimatum alla Serbia? Ci vorrebbe una legge del tipo: tutti gli stati che hanno mire geo-politiche simili a quelle dell’impero austro-ungarico nel 1914 e che si trovano in condizioni simili a quelle dell’impero dopo l’assassinio dell’erede al trono, emettono un ultimatum contro un paese che si trovi in condizioni simili a quelle della Serbia nel 1914. Ma su quale evidenza sarebbe fondata una legge generale di questo genere? Per saperlo, occorrerebbe formularla nei dettagli; così riformulata, però, essa finirebbe per applicarsi a un unico caso, proprio quello che, col suo aiuto, si vorrebbe spiegare: così riformulata, cioè, la presunta legge non farebbe altro che esprimere il contenuto delle premesse del sillogismo pratico.
Di fronte a queste critiche severe, il monista metodologico avrebbe una sola via d’uscita: tener ferma la tesi che le spiegazioni mediante ragioni siano anch’esse spiegazioni causali e, nello stesso tempo, purificare la nozione di spiegazione causale dell’azione dal ricorso a una legge universale, che colleghi direttamente gli eventi classificati come ragioni (per esempio, volizioni) agli eventi classificati come azioni. In questo quadro teorico, le leggi alla cui esistenza si farebbe genericamente appello in una spiegazione causale dell’azione, spesso senza poterle nemmeno specificare, non riguarderebbero i tipi di eventi concettualizzati come ragioni e come azioni, ma sarebbero, piuttosto, leggi neurologiche, chimiche o fisiche sottostanti. Com’è noto, questa è la strada seguita da Donald Davidson[11]. Noi, comunque, ci fermiamo qui, sulla linea di confine tra metodologia della spiegazione e filosofia della mente.
[1] Cfr. D. Davidson, Azioni ed eventi (1976), tr. it. Il Mulino, Bologna 1992, pp. 347-364.
[2] Cfr. L. Wittgenstein, Libro blu e libro marrone (1958), tr. it. Einaudi, Torino 1983.
[3] Ibid., p. 23 (corsivo mio).
[4] B. Russell, Misticismo e logica (1912), tr. it. Longanesi, Milano 1964.
[5] Il riferimento classico qui è alla Parte III del Libro I del Trattato sull’intelligenza umana (Laterza, Bari 1967) e alla sezione 4 delle Ricerche sull’intelletto umano (Laterza, Bari 1957).
[6] Cfr. C. G. Hempel, The Funcion of General Laws in History, in «Journal of Philosophy», 39, 1942.
[7] Aristotele è stato il primo a trattare il sillogismo pratico in Etica Nicomachea, 1147a-1147b, Laterza, Bari 1965, pp. 175-179. Nel seguito, mi baserò sulle interpretazioni proposte da G. E. M. Anscombe nel suo Intention, Blackwell, Oxford 1957, sezione 33, e da G. H. von Wright nel suo Spiegazione e comprensione (1971), tr. it. Il Mulino, Bologna 1977, capitolo 3.
[8] Vedi G. H. von Wright, Spiegazione e comprensione, cit., pp. 131-41.
[9] L’esempio è discusso in G. H. von Wright, Spiegazione e comprensione, cit., pp. 162-67.
[10] Vedi C. G. Hempel, Explanation in Science and in History, in Frontiers of Science and Philosophy, a cura di R. G. Colodny, Pittsburgh University Press, Pittsburgh 1963.
[11] Vedi soprattutto Actions, Reasons and Causes, in «Journal of Philosophy», 60, 1963, tr. it. in D. Davidson, Azioni ed eventi, cit., pp. 41-61.