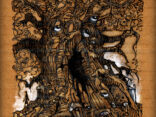Autore
Indice
- Premessa
- Sulla fecondazione omologa
- Sulla fecondazione eterologa
- Sull’eutanasia
- Conclusioni
S&F_n. 17_2017
Abstract
Bioethics from Commandment. Concerning Jewish Reflection on FIVET and Euthanasia
This paper focuses on the specific nature of the Jewish bioethical thought. My interest regards the peculiarity of the biblical Jewish approach to biomedical questions like FIVET and euthanasia. The paper points out the relationship between Jewish and Christian bioethical view about these questions and it shows the analogies and the differences typical of two creationist faiths.
-
Premessa
-
Il confronto con la fede cristiana ha sempre costituito un passaggio necessario per l’elaborazione condivisa della riflessione intorno ai temi e alle domande che delineano l’orizzonte della bioetica.
Il tempo e le dinamiche che hanno dato forma al dibattito bioetico consentono di guardare con sospetto alla sclerotizzazione del confronto tra la posizione cosiddetta “laica” e quella altrettanto retoricamente definita “religiosa”.
Quello che immediatamente appare chiaro è che, in genere, si tende a identificare il punto di vista “religioso” con quello espresso dal magistero della Chiesa Cattolica. A volte – come accade per la riflessione intorno alle questioni della fine della vita – il riferimento alle chiese protestanti è stato altrettanto fecondo.
Il punto che vorrei sottolineare da subito è che questo atteggiamento mostra il disinteresse di fondo nei confronti di tradizioni di fede “altre” rispetto a quella cristiana – e cattolica in particolare – disinteresse per cui quasi mai le posizioni di mondi religiosi e di tradizioni di fede non cristiane sono state coinvolte a pieno titolo nel dibattito bioetico. Questo ha significato perdere l’opportunità di ampliare non soltanto lo spazio della domanda, ma anche quello che tiene in sé nuove risposte, tracce di pensiero sepolte che meritano di essere seguite, in quel percorso difficile che è la bioetica.
La facilità dell’identificazione tra “religioso” e “cattolico” ha svilito la tensione creativa di quella che è la sostanza bioetica fondamentale, ossia il dialogo interumano. “Facile” è un atto del pensiero che rinuncia alla complessità e all’articolazione di quelle esperienze che, in quanto vissute, chiedono di essere conosciute e pensate. E quelle religiose sono proprio questo genere di esperienza: interpellante, da un lato, chiarificatrice, dall’altro.
Mi pare, dunque, che escludere questo specifico universo di vita significata, non corrisponda a quella importante dinamica del pensiero che si traduce nello sforzo di essere e di mantenersi libero, sforzo per cui definiamo il pensiero autenticamente “filosofico”. Questo processo di emancipazione include la comprensione dell’esperienza religiosa, alla quale, dunque, non può essere negato di valere come una voce tra le voci che pensano e parlano anche bioeticamente.
Per tornare all’osservazione di partenza: di certo non si può sottovalutare il fatto che la posizione dei cattolici esprime l’unità del magistero ecclesiale e che, per questa unità dottrinale, quella cattolica risulta essere posizione effettivamente “soggettiva”, posizione, cioè, che consente un’interlocuzione pressoché lineare e diretta. Né si può considerare un dato tra gli altri il fatto che la posizione cattolica rappresenta quella della maggior parte dei credenti, almeno nel contesto geografico europeo, e occidentale in genere. Il che, va da sé, implica che si debba sempre misurare il peso sociale, politico e culturale di questa posizione, ascoltarne le ragioni di fondo e comprenderle nello spazio del confronto etico e della sintesi giuridica.
Intendo ragionare sulle posizioni di una esperienza di fede che precede e dà ragione di quella cristiana: mi riferisco alla fede ebraica.
Mi interessa commentare il punto di vista bioetico che fa riferimento a questa tradizione di fede rispetto ad alcuni temi dell’inizio e della fine della vita.
La fede biblica ebraica, per la quale e nella quale trova radice la fede cristiana, ha costruito la propria ricchezza dottrinale per il tramite di mediazioni culturali altre rispetto a quelle che hanno consentito alla fede cristiana di ottenere per sé l’assetto magisteriale che la costituisce teologicamente e le permette di tradursi in quella soggettività che pensa e agisce come una soggettività.
Trovo, dunque, motivo di interesse ad analizzare questioni bioeticamente sensibili in quel quadro di riferimento che è l’ebraismo, fede biblica come biblica è la fede cristiana: questo rapporto di originaria fraternità racconta due storie teoretiche, il cui intreccio, nei tempi dell’analogia e della differenza, ha tra i suoi fili quelli che tessono anche la trama della ragione bioetica.
-
2. Sulla fecondazione omologa
-
Le questioni bioetiche che sono discusse in relazione agli sviluppi della ricerca biomedica applicata all’inizio della vita, sono questioni dalle quali emerge con evidenza lampante il legame originario e fondamentale tra l’ebraismo e il cristianesimo. Dio creatore giustifica questa inscindibile relazione. È come se proprio l’orizzonte che traccia la domanda bioetica possa costituire lo spazio entro cui è possibile vivere non tanto e non solo l’amicizia del dialogo ma, più ancora, e più veracemente, la fraternità costitutiva di queste due esperienze di fede. Verità effettuale, questa, che riconosciamo come verità culturale, ossia verità che assume la forma di criterio etico e politico per la vita del mondo e per la vita nel mondo; verità effettuale, cioè, che non riconosciamo da subito e prima di tutto come verità teologica. L’unità di questa verità è solida al punto da tenere in sé e risolvere anche la distinzione sottolineata precedentemente: la mancanza, per l’ebraismo, di un unica autorità dottrinale che favorisca un orientamento etico condiviso.
La solidarietà bioetica tra le due fedi bibliche dipende dalla comprensione del reale come mondo creato, che è comunicazione di sé di quella soggettività personale che pensa e vuole fino all’essere dell’altro da sé: Dio crea il mondo.
Cominciamo da un argomento specifico: se venisse meno il presidio creazionista, non sarebbe data la posizione ebraica in merito alla fecondazione in vitro. Che è così tanto prossima a quella cristiana, sistematizzata e tradotta dal magistero cattolico, da sembrarne la condizione teoretica e morale.
In realtà bisognerebbe precisare che l’ebraismo di cui si tratta è quello ortodosso, dato che diverse sono le tradizioni e le declinazioni della fede e della tradizione ebraica. Nell’ebraismo
ci sono tante autorità, ciascuna delle quali, rispetto allo stesso problema, può dare una risposta differente. Il rapporto con queste autorità delle persone è articolato: in mondi strettamente legati alla tradizione, la persona si rivolge all’autorità religiosa e a questa rimane assolutamente vincolata. In altri casi o non ci si rivolge affatto, o ci si va solamente per sentire un parere orientativo ma non vincolante[1].
Come per la maggior parte delle posizioni assunte nel contesto ebraico ortodosso, i riferimenti alla tradizione e alla sua autorità riguardano prima di tutto la Torah, la Mishnah e il Talmud e poi il codice di Maimonide e quello dello Shulchan ‘Arukh, per riferire le fonti più significative. Nonostante questi riferimenti comuni, non mancano punti di vista differenti da quelli dedotti interpretando questi testi: essi sono testimonianza di un’elaborazione dell’esperienza etica che non si è misurata con le specifiche tematiche bioetiche, per le quali questi testi vengono adottati come paradigma utile all’orientamento e alla scelta.
La fecondazione assistita omologa è quasi sempre considerata favorevolmente perché risponde alla vocazione genitoriale di una coppia e le permette di superare i problemi di sterilità che possono ostacolare la sua fecondità. Non è accettata la fecondazione assistita eterologa né quella finalizzata a una genitorialità omosessuale. Di conseguenza decisa è la posizione contraria alla gestazione surrogata.
Le ragioni che spiegano queste posizioni non dipendono dalla definizione dell’identità dell’embrione, del quale in genere non si intende fissare uno specifico statuto ontologico. La necessità di questa definizione è propria della cultura filosofica e teologica cattolica e dell’impostazione tomista che la contraddistingue. Questa ascendenza teoretica, che comporta la definizione dell’individuo procreato in vitro e la deduzione da essa delle conseguenze bioetiche che riguardano l’embrione e i soggetti coinvolti nell’atto della fecondazione, non interessa la posizione ebraica e non perché manchi il riferimento a questo modello speculativo e ai temi metafisici fondamentali che lo caratterizzano: lo stesso Maimonide è raffinatissimo pensatore neoaristotelico, la cui Guida dei perplessi ha rappresentato un’opera con la quale la filosofia e la teologia cristiane si sono confrontate per ragionare intorno alla mediazione biblica dell’ontologia di Aristotele.
Non ostacolare le tecniche di fecondazione nella formula omologa vale a praticare il precetto con il quale comincia la narrazione biblica e la relazione umano-divina. In prima battuta la creazione dell’umanità e il modo in cui essa accade: a immagine e somiglianza di Dio. Poi la parola che chiede di procreare e lo chiede articolando l’ammonimento nella forma della benedizione:
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra”.
Maschio e femmina sono interpellati da subito come soggetti responsabili affinché la terra non sia un deserto ma diventi luogo abitato. I versetti di Genesi riferiti ad Adamo ed Eva e quelli che riprendono il medesimo precetto rivolto a Noè e a sua moglie, generalmente vengono interpretati alla luce di quanto scrive Isaia:
Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l’ha resa stabile e l’ha creata non come orrida regione, ma l’ha plasmata perché fosse abitata[2].
Secondo alcune autorità rabbiniche la tecnica della fecondazione omologa può comportare la trasgressione al divieto di dispersione e di distruzione dello sperma e inficiare la validità della relazione sessuale matrimoniale che costituisce l’atto per il quale è prescritta la procreazione, atto senza compiere il quale la relazione perde il carattere precettistico che le compete. La maggior parte dei cosiddetti “decisori” ritiene che il caso della fecondazione omologa non costituisca la trasgressione di questo precetto, perché la fecondazione omologa è una tecnica finalizzata a preservare il comandamento che include in sé questo precetto, ossia il comandamento dello shelom bait per il quale la custodia del nucleo familiare dipende dalla presenza dei figli, il cui concepimento precede, dunque, l’obbedienza a qualunque altro precetto.
L’intero quadro argomentativo qui sintetizzato è ripreso dal magistero della Chiesa Cattolica sulla base delle medesime ragioni scritturistiche, ossia per la medesima fede nella soggettività creativa di Dio e per la conseguenza etica che tale fede implica per la storia degli uomini, tra loro e nel mondo. Una sintonia necessaria laddove le ragioni dell’insegnamento bioetico siano giustificate dalla parola della Rivelazione, più che mai nei passaggi per i quali essa poggia sull’evidenza del dettato biblico, come accade per una parte del racconto della creazione e per la codificazione delle relazioni sponsali e familiari[3].
Soltanto quando la riflessione bioetica emerge dalla testimonianza biblica, laddove questa non sia già divenuta oggetto di elaborazione teologica, appare immediata la consonanza tra le due fedi testamentarie. Già quando si comincia a ricorrere alla ragione essenzialista e definitoria, assumendo, per rispondere alle questioni bioetiche fondamentali, le dinamiche della speculazione sistematica e la logica più o meno rigidamente apodittica di tanta parte della tradizione del pensiero occidentale, questo accordo perde vigore e si svilisce. Come accade quando si tratta di dare conto della realtà dell’embrione: non mi occupo in queste pagine di evidenziare il significato e il valore di questo tema ma ugualmente sottolineo che esso rappresenta un’occasione di straordinaria utilità laddove si intenda favorire un’analisi comparativa delle fedi bibliche bioeticamente interpellate visto che, proprio a causa dell’argomentazione ermeneutica decisamente orientata a valere anche in forza della ragione sistematica aristotelico-tomista laddove si tratti di spiegare la realtà dell’embrione, esse si distinguono significativamente sul piano teoretico. Accade, poi, però, che rispetto ai comportamenti e alle pratiche mediche che riguardano l’embrione, la posizione ebraica e cristiana torna a raccontare quella prossimità originaria, i cui tratti ho descritto in termini di fraternità.
-
3. Sulla fecondazione eterologa
-
Quando si tratta di giustificare il punto di vista contrario alla fecondazione eterologa e alla maternità surrogata, qualunque sia il fine per il quale quest’ultima è praticata, fondamentale diventa la questione delle relazioni che si instaurano per preparare questa pratica medica e quelle che si determinano dopo che è stata effettuata. Al centro della riflessione sono collocati gli adulti che decidono questa pratica e il significato della loro scelta: è il significato attribuito a questa scelta, infatti, a consentire il riconoscimento al figlio nato di una specifica identità giuridica e sociale.
L’ipotesi di fecondazione eterologa, ovvero con il seme di un donatore esterno, per principio viene considerata una tecnica eticamente non ottimale. Ma questo non è sufficiente a far considerare la fecondazione con il seme di un altro uomo come un adulterio vero e proprio. Cosa è infatti ciò che definisce l’adulterio? Il rapporto sessuale o il seme che feconda l’ovulo? La creatura che nasce da una inseminazione eterologa sarà considerata con i rigori del mamzer (impropriamente tradotto come “bastardo”), oppure no? Abbiamo su questo argomento fonti molto particolari che citano casi di gravidanze realizzatesi senza rapporti sessuali (ad esempio il caso di Ben Sirà) che in generale orienterebbero a dire che ciò che definisce l’adulterio in termini rigorosi è il rapporto sessuale e non il semplice passaggio del liquido seminale nell’utero, anche se non appartiene a quello del marito. La maggioranza delle autorità rabbiniche non consente la fecondazione eterologa perché, anche se tecnicamente non si può configurare come un adulterio, in realtà è una procedura che interviene in maniera decisiva a spezzare in qualche modo l’unità psicologica, morale e spirituale della coppia, introducendo un elemento esterno. Anche tutte le problematiche psicologiche che ne possono derivare e che riguardano il donatore, la donatrice, i genitori e il prodotto di questa procedura sono importanti e vanno rispettate. Per questo motivo l’orientamento generale è di dire no. La complessità delle situazioni che possono nascere dalla procedura della fecondazione eterologa ne fanno praticamente un argomento considerato molto negativamente[4].
Il breve passaggio dell’intervista al rabbino Di Segni che ho riportato, chiarisce la posizione condivisa dall’ebraismo ortodosso in merito alla fecondazione eterologa: si tratta di una tecnica riproduttiva che risulta problematica prima di tutto perché mette in gioco la qualità e il valore delle relazioni tra gli adulti che decidono questa pratica medica. È una fecondazione per la quale si stabiliscono legami genitoriali tali da compromettere l’identità della coppia e di quella famiglia che, dopo questo tipo di fecondazione, prende forma. Il problema sembra essere di ordine psicologico e relazionale ma, a mio giudizio, è prima ancora, e ancora una volta, di tipo dottrinale.
Si mette in evidenza da subito, infatti, che questa tecnica può configurarsi come adulterina e che le premesse e le conseguenze di una scelta del genere contraddicono la parola del comandamento. Alcuni, per sottolineare la possibile apertura interpretativa rispetto a questa pratica, ricordano spesso il caso del concepimento di Ben Sira, nato dal profeta Geremia e da sua figlia, fecondata dal seme del padre disperso nell’acqua: si tratterebbe di un caso di fecondazione legittimo – eterologo diremmo, ma non solo, visto che si tratta di un incesto – e questo perché l’autorità rabbinica ritiene che possa dichiararsi la colpa di adulterio o di incesto soltanto se ha avuto luogo un’effettiva relazione sessuale tra i genitori del concepito.
Certo, tra una tecnica di fecondazione in vitro, come quella eterologa, e il caso commentato dal Talmud, caso che è obiettivamente, ossia scientificamente, inverosimile e che immagino abbia un valore unicamente simbolico, funzionale alla discussione e al dibattito su temi specifici di etica familiare, sussiste una differenza tale che il riferimento selezionato sembra svuotarsi immediatamente di significato, laddove si voglia utilizzarlo per lasciare aperto un varco a posizioni diverse rispetto a quella sostanzialmente e quasi unanimemente contraria alla fecondazione eterologa[5].
Tra i cosiddetti Responsa di rabbini a noi contemporanei che spiegano la posizione contraria alla fecondazione eterologa come posizione che non ammette eccezioni, meritano di essere ricordati quelli di Rav Joel Teintelbaum e il Rav Eliezher Waldenberg: essi spiegano che le fonti che esaminano il caso riportato, sono fonti inadeguate a valutare la moralità di questa tecnica. Quello tratto dalla tradizione talmudica e midrashica, infatti, è un esempio che riguarda comportamenti nient’affatto volontari e consapevoli. La fecondazione eterologa, al contrario, è un atto che si configura come atto e volontario e consapevole, per cui non può non definirsi come adulterio e mamzherut, espressione che indica la condizione di colui che nasce da una relazione adulterina. Il versetto del Levitico 18,20 secondo il quale «alla moglie del tuo prossimo non darai il tuo giacere per seme per renderti impuro con lei» chiarisce una volta di più che non può esservi donazione di seme che non sia espressione del rapporto coniugale, anche laddove lo scambio del seme non avvenisse con un rapporto sessuale effettivo.
La presunzione di paternità e la responsabilità degli alimenti sono due aspetti giuridici fondamentali per comprendere la declinazione psicologica e sociale del divieto di ricorrere alla tecnica di fecondazione eterologa.
Se il seme è del marito, egli pagherà̀ gli alimenti, se non lo è, ma egli ha acconsentito alla procedura della fecondazione assistita, le opinioni sono discordanti, mentre è certo che egli non ha il dovere di pagare gli alimenti, qualora il seme non sia il suo ed egli non abbia acconsentito all’inseminazione. Inoltre, altri possibili problemi si avrebbero in relazione al c.d. jochas, cioè per quanto attiene allo stato giuridico della persona in rapporto ai suoi genitori. Può̀ essere considerato ebreo il nascituro frutto di un concepimento in vitro? ovviamente sì, se la coppia di genitori ebrei è ricorsa alla fecondazione omologa. Posizioni discordanti si riscontrano, invece, se la coppia è ricorsa alla fecondazione eterologa[6].
Per l’ebraismo ortodosso, infatti, è meno problematica la donazione del gamete di un uomo non ebreo per avere la certezza dell’ebraicità del concepito, visto che questa dipende dall’ebraicità della madre.
È questa, però, una questione secondaria, che potrebbe non essere posta laddove si seguisse il divieto di ricorrere a questa pratica, divieto che costituisce la materia bioetica fondamentale. Se la fecondazione eterologa implica una maternità surrogata e una maternità surrogata a beneficio di una coppia omosessuale, il giudizio bioetico è ancora più intransigente. E lo è senz’altro per le questioni giuridiche che conseguono a una pratica del genere, ma il divieto non dipende da questo tipo di conseguenze: la fecondazione assistita di tipo eterologo è un atto contrario alla fede nel Dio creatore, fede per la quale, nascendo, non acquistiamo il diritto alla vita, e quindi la capacità di tradurre noi stessi in soggetti dai quali dipende il suo poter essere.
Non abbiamo il diritto alla vita ma il dovere di non uccidere. Siamo chiamati, cioè, a trattenerci in quella dimensione i cui confini sono definiti dalla originaria passività del ricevere e dalla logica del donare/accogliere che esprime l’asimmetria della relazione creaturale, una logica che non può essere compresa prima e vissuta poi, se non risulta da quell’esperienza conoscitiva che è l’esperienza di fede.
-
4. Sull’eutanasia
-
Ritengo che valga la pena dire da subito che la riflessione ebraica sull’eutanasia è semplice di quella semplicità che restituisce la pienezza del comandamento e l’obbedienza immediatamente coerente che le deve corrispondere: non ucciderai. Proprio per questo, a proposito dell’eutanasia, le posizioni rabbiche non si diversificano, come accade nel caso della fecondazione assistita. L’eutanasia è condannata in qualunque modo si eserciti, qualunque sia la distinzione che la connoti. È altrettanto solida la certezza che non si debba rallentare il processo del morire, laddove si possa tecnicamente trattenere in vita un malato in fase terminale.
Chiarisce efficacemente la visione del problema dal punto di vista ebraico una fonte giuridica autorevole come Shulchan ‘Arukh, in cui si dichiara che qualora il profeta venisse per avvertirci che una certa persona ha solamente un’ora o un momento di vita, la Torah non distingue tra colui che uccide una persona che potrebbe vivere molti anni e un vecchio con pochi attimi di vita: la vita non è oggetto del giudizio umano, del giudizio di colui che vive e che è in relazione ad altri viventi; la vita non può essere sottoposta alla gradualità e alla proporzionalità che presiede alla formulazione di un predicato valutativo. L’assolutezza che le compete – obiettiva se la vita è da Dio e la sua effettività, come la sua comprensione, dipendono unicamente dall’iniziativa divina – significa che, se si procede a sottrarre valore alla vita in relazione a specifiche condizioni come quelle di colui che patisce una sofferenza destinata a consumarlo fino alla morte, la vita per se stessa perde valore[7].
Ecco la solidità del comandamento, la chiarezza dell’interpretazione, l’univocità fiera della sua applicazione: non è lecito accelerare la morte di un uomo e nemmeno ostacolarne il processo per così dire “naturale”. A questa posizione, etica prima e bioetica poi, si aggiunga il dovere del medico di prodigarsi per favorire la guarigione del malato e per alleviare le sue sofferenze. Se anche la vita del malato dipendesse da terapie e strumenti di rianimazione, la pratica delle une e l’applicazione degli altri andrebbero sostenute fino a quando la morte non sopraggiunga da sé. Il che non contraddice il divieto di quell’accanimento che tenta di essere terapeutico, pur nella consapevolezza della inutilità di questo sforzo.
Nelle stesse situazioni di quella che ha riguardato Eluana Englaro, i grandi decisori ritengono che non vadano sospese l’idratazione e l’alimentazione, in quanto trattamenti ordinari e nient’affatto eccezionali.
Per riflettere sulla posizione ebraica anche in materia di eutanasia, non si può fa a meno di richiamare l’attenzione su un episodio biblico che sembrerebbe aprire alla discussione intorno alla legittimità dell’eutanasia stessa. Lo riporto così come lo racconta il rabbino Di Segni.
Un caso notevole è quello della morte del re Saul, narrata al cap. 31 di 1 Samuele, e al cap. 1 di 2 Samuele. Saul muore durante una battaglia contro i filistei; accerchiato dai nemici, vede profilarsi la sconfitta, e temendo di cadere prigioniero ed essere esposto a sofferenze intollerabili, chiede allo scudiero di togliergli la vita; lo scudiero si rifiuta, e allora Saul si trafigge da sé con la sua spada. Ma questo non basta a farlo morire, e allora il re in agonia si rivolge a un giovane amalecita, chiedendogli di finirlo. L’amalecita uccide Saul, e lo va a raccontare a David, rivale di Saul e futuro re; ma David, ascoltato il racconto, condanna l’amalecita[8].
Se non può tacersi il valore della sofferenza che spinge al suicidio, al punto che questa tentazione è sottratta alla punizione della legge, è altrettanto chiaro che il comportamento dell’amalacita contravviene al comandamento che vieta di uccidere: non è ammesso accelerare il processo del morire anche laddove non si possa alimentare più alcuna speranza di guarigione e laddove a chiedere di morire fosse lo stesso ammalato. Inoltre, e non in contraddizione con questa posizione, si ritiene che vada proibito ogni comportamento che prolunghi e ritardi artificialmente il decesso stesso.
Così come è proibito accelerare la morte di un individuo, parimenti può essere proibito ritardarla con mezzi artificiali. Le fonti medioevali abbondano di strane casistiche in questo senso: ad esempio il rumore ritmico di uno spaccalegna che entra in risonanza con il battito cardiaco di un agonizzante, o il rumore o il pianto nella stanza dove si trova il malato, se ne prolungano l’agonia, possono essere ridotti al silenzio. In altri termini, appare lecito rimuovere ciò che impedisce la morte, mentre è illecito mettere in atto ciò che direttamente la affretta[9].
Questo insegnamento, per certi versi ancora più drastico delle indicazioni contenute nel magistero cattolico, risponde compiutamente dell’indisponibilità della vita umana proprio perchè vita creata, proveniente e proveniente dal nulla della ragione e della libertà degli uomini, dall’essere date, cioè, dell’una e dell’altra. Nulla che è del venire dall’insondabile realtà di altri che è Dio.
Vita creata in quell’attimo che mostra da un lato l’immediata contemporaneità che è del dare e del ricevere, e dall’altro l’irrevocabile condizione che è del venire dopo, la certezza vissuta del non essere all’inizio del nostro cominciare a essere, la certezza vissuta del nostro essere all’inizio in quanto cominciati a essere Non ucciderai.
Ho definito più radicale e drastico il punto di vista ebraico rispetto a quello cattolico in merito alle questioni della fine di una vita ammalata e ammalata irreversibilmente. Questa definizione trova adeguata spiegazione soprattutto in relazione alla discussione intorno ai criteri di accertamento della morte e all’utilità di questi, se si intenda procedere all’espianto e al trapianto di organi.
Salvare la vita di un uomo è la legge che si impone su ogni altra legge: il limite che le è imposto è la difesa di un’altra vita. Limite assai evidente nel caso del trapianto di organi, più specificamente del trapianto cardiaco, visto che si tratta di espiantare un organo pienamente funzionante. Le autorità religiose hanno discusso soprattutto intorno ai criteri in relazione ai quali è possibile dichiarare il decesso di un individuo e procedere, se fosse possibile, all’espianto del suo cuore.
Per la tradizione talmudica, la vita cessa con la cessazione del battito cardiaco. I criteri ufficiali di accertamento della morte sono, invece, criteri cerebrali, grazie ai quali, se anche l’attività neurologica fosse compromessa, sarebbe possibile espiantare un cuore ancora “vivo” e pulsante e quindi utile per un trapianto.
In un primo tempo le autorità rabbiniche considerarono l’espianto di quest’organo un vero e proprio omicidio e si espressero decisamente contro la pratica dei trapianti. Il fatto che questa pratica portasse tanti benefici ha costretto a rivedere questa posizione fino a riabilitare l’insegnamento di quella tradizione interpretativa, a lungo trascurata, che considera la cessazione dell’attività respiratoria, e non di quella cardiaca, il criterio di accertamento della morte. Che si smetta di respirare significa che l’attività cerebrale è compromessa, di conseguenza si accolgono i criteri stabiliti dall’università di Harvard come criteri validi per definire lo stato di morte di un individuo. È questa la linea assunta dal rabbinato israeliano nel 1986, secondo cui, una volta accolto il criterio di accertamento cerebrale della morte, in conformità con quella tradizione talmudica che considera la cessazione della respirazione la causa irreversibile della morte, è possibile l’espianto e il trapianto del cuore come di ogni altro organo. Ma è un’interpretazione che non rappresenta la totalità delle posizioni rabbiniche[10].
In estrema sintesi si può dire che l’accordo riguarda il divieto dell’eutanasia cosiddetta “attiva”, di quella “passiva” se si configura come pratica di accelerazione del processo di morte, l’accettazione delle cure palliative per scongiurare la tentazione dell’accanimento terapeutico, l’obbligo di idratazione e di alimentazione del malato terminale. È un quadro del tutto simile a quello che emerge dal magistero della Chiesa cattolica in materia di eutanasia. Distinguo significativi riguardano, invece, l’ammissibilità e il valore della donazione degli organi, del loro espianto e del loro trapianto[11].
-
5. Conclusioni
-
Ritengo che il dibattito bioetico debba includere la riflessione sulle ragioni di prassi specifiche, quelle la cui applicazione dipende dall’esperienza di fede, la cui capacità performativa consente, ai soggetti coinvolti in questa esperienza, di conoscere la realtà del mondo, e l’inquietudine che la contrassegna, nel modo che è precluso a esperienze altre da questa e alle loro rispettive traduzioni conoscitive del reale.
Si definirebbe un approccio inclusivo quello descritto, capace semplicemente di riconoscere la ricchezza del talento riflessivo e valutativo che è possibile esercitare in contesti diversamente umanizzanti. Ma non è soltanto l’evidenza e la vaghezza di quella ricchezza cosiddetta “multiculturale” a costituire la finalità di un dibattito bioetico adulto e all’altezza delle sfide della scienza al pensiero e all’agire umano.
Alla bioetica, che espone i suoi confini all’attraversamento di esperienze come quella biblica della vita e della morte, è dato di pensare diversamente dall’imperativo dell’autonomia intellettuale, è dato di procedere più in là della coerenza della logica che poggia sull’evidenza effettuale e articola la propria argomentazione, trattenendo il fatto bioeticamente significativo, nell’ordine della ragione causale, quella che, cioè, anche riflettendo bioeticamente, cerca soltanto conferme alla certezza della propria legislazione teoretica e morale.
Slabbrare i termini del discorso per disporre la ragione e il giudizio all’inattualità di esperienze come è l’esperienza di fede, esperienza a cui è possibile smentire la pienezza della ragione autoreferenziale, potrebbe valere la conquista di percorsi valutativi nuovi autenticamente e, in qualche modo, in tanti casi, inaspettatamente salvifici.
Il confronto con la riflessione bioetica ebraica, per il fatto che essa si fida di una tradizione più marcatamente disinibita nei confronti di modelli epistemologici strutturati nella forma del pensiero occidentale, può costituire un’occasione per attendere di pensare e di discutere la complessità della materia bioetica come non è ancora mai accaduto. Un’occasione per non proporre sempre ancora i medesimi paradigmi concettuali, secondo quella dinamica dicotomica che contraddistingue il dibattito bioetico, soprattutto in Italia. Attendere di pensare per pensare nuovamente: il confronto con una tradizione di pensiero non immediatamente inclusa nel contesto per così dire “classico” del dialogo bioetico, può consentire l’esercizio di questa attesa.
Ho evidenziato, poi, come il tratto specifico delle argomentazioni della bioetica ebraica sia segnato dalla premessa creazionista e come tale premessa finisca con il costituire lo specchio della complessa e strettissima relazione della fede ebraica con quella cristiana, nonostante che quest’ultima sia cresciuta teologicamente grazie anche e, per certi versi, soprattutto, alla risorsa filosofica classica, fino a strutturarsi in quella modalità teologica che è estranea alla cultura religiosa ebraica.
È questo un esempio quanto mai efficace del fatto che la pratica della discussione bioetica può costituire uno strumento per sospendere la rigidità delle contrapposizioni: il tempo di una discussione bioetica di questo tipo è il tempo in cui si scopre quella prossimità tra gli uomini che non solo ragionano, spiegano e motivano, quella prossimità, cioè, che non è puramente analogica, ma è prossimità tra gli uomini che ascoltano, si fanno carico e rispondono della vita di ogni altro uomo.
-
[1] R. Di Segni, Intervista di F. Bolino in «Il Riformista», 15 febbraio 2009. Ricordo che Riccardo Di Segni è medico e Rabbino capo della comunità ebraica di Roma.
[2] Va sottolineato come il precetto della procreazione riguardi unicamente il maschio visto che è proibito obbligare qualcuno a compiere azioni dolorose e pericolose per la propria vita. La maternità, dunque, si configura come quel diritto cui corrisponde il dovere della paternità. Si veda R. Di Segni, Fecondazione artificiale e bioetica ebraica, in «La Rassegna Mensile d’Israel», LX, 1-2, 1993, pp. 187-194.
[3] Un testo davvero utile per un’interpretazione sinottica delle posizioni bioetiche ebraiche e cristiane è S. Spinsanti (a cura di), Bioetica e grandi religioni, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1987. Si veda anche il manuale di J. Massué, G. Gerin, Diritti umani e bioetica, Seps, Roma 2000, nel quale si trova un’utile rassegna delle posizioni religiose sui casi bioeticamente sensibili.
[4] Id., L’embrione – uomo, in «Moked», 31 luglio 2008.
[5] Il carattere esemplificatorio di questo episodio come di altri, tratti dalla tradizione ebraica scritturista e talmudica, appare chiaro dalla riflessione attuale in materia di matrimonio e divorzio nel diritto ebraico. Un utile riferimento bibliografico su questi temi è senz’altro A. M. Rabello, Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica, Giappichelli, Torino 2000.
[6] M.F. Maternini, L. Scopel, Bioetica e confessioni religiose, Edizioni Università di Trieste 2014, pp. 27-28.
[7] È questa la posizione difesa e argomentata dal rabbino Jacobovitz, che è uno dei primi “sistematori” del pensiero ebraico in materia di bioetica: I. Jacobovitz, Jewish medical ethics. A comparative and historical study of the Jewish religious attitude to medicine and its practice, (in ebr.), Mossad Harav Kook, Jerusalem 1966. Sull’argomento si vedano tra gli altri: E. N. Dorff (ed. by), Matters of Life and Death: A Jewish Approach to Modern Medical Ethics, Jewish Publication Society, Philadelphia, 1998; D.M. Feldman, Where There’s Life, There’s Life, Yashar Books, Brooklyn 2006.
[8] R. Di Segni, Eutanasia e bioetica degli stadi terminali. La bioetica dei trapianti, www.nostreradici.it.
[9] Ibid. Cfr. L. Caro, Eutanasia e Ebraismo, in M. Gensabella Furnari (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, Vol. 2, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2003.
[10] Sul carattere inquietante del criterio cerebrale di accertamento della morte valga, in questa sede, unicamente la testimonianza di un pensatore come Hans Jonas, figlio anche della cultura religiosa ebraica e critico raffinato delle motivazioni proposte dal Comitato di Harvard, comitato che fissò, nel 1968, i criteri di accertamento cerebrale della morte. Il quadro della discussione è più ampio e articolato di quello che l’opera di Jonas profila. Nel contesto di questo contributo ci limitiamo a ricordare soltanto due riferimenti bibliografici del filosofo e bioeticista tedesco, utili a inquadrare il tema, visto che è senz’altro per l’autorevolezza della sua proposta critica che la questione dell’accertamento cerebrale della morte ha continuato a essere questione discussa: H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997; Id., Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici, Il Mulino, Bologna 2001; Id., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 2002.
[11] Meriterebbe una precisazione il punto di vista della Chiesa protestante valdese che si è espressa proponendo una riflessione di altro segno sulla questione dell’eutanasia. Rimando a Tavola Valdese, Gruppo di lavoro sui problemi posti dalla scienza, L’eutanasia e il suicidio assistito, in «Bioetica», 1, 1999.