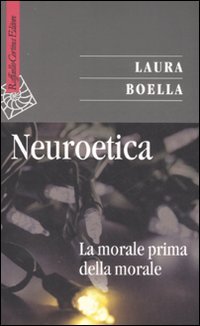“Sono io o il mio cervello?” è la domanda che risuona spesso quando si affrontano i problemi etici connessi allo sviluppo delle neuroscienze, mentre sembrano già profilarsi in ambito giuridico enunciati di questo tipo: “non sono stato Io, ma i miei neuroni”. Questa sorta di nuova forma di duplicità schizofrenica dell’umano, da un lato l’Io spirituale e dall’altro l’Io neuronale, sorge quando non si affronta in maniera bilanciata la grande mole di questioni suscitate dalle importanti costruzioni neuroscientifiche sviluppatesi negli ultimi due decenni. In poche parole si rischia di dover fare i conti con una nuova versione aggiornata della frenologia, una sorta di «frenologia high-tech» (p. 31), e di dover stare qui ad attendere un nuovo vitalismo spiritualistico à la Bergson.
In questo difficile campo si posiziona il testo della Boella che risulta essere uno strumento utile perché da un lato permette di rintracciare i passaggi fondamentali di questo percorso e dall’altro, soprattutto per i ripetuti inviti alla prudenza quando ci si trova di fronte ai risultati di determinati esperimenti, ci introduce alla complessità di quest’ambito.
I risultati che provengono dalle tecniche di neuroimaging (soprattutto PET e fMRI) non vanno presi come oro colato ma vanno analizzati in maniera critica: in primo luogo vi è il problema del «passaggio dalla struttura alla funzione, in quanto la visualizzazione cerebrale si riferisce ad attivazioni legate a compiti svolti in condizioni estremamente costrittive» (p. 29), in poche parole vi sono una serie di variabili che perturbano l’esperimento e che non ne permettono una lettura assolutamente limpida; in secondo luogo vi è il “classico” problema della «costruzione dell’esperimento» (p. 30) che implica una sorta di circolo vizioso in quanto per poter costruire un esperimento in maniera ottimale bisognerebbe già conoscere la base neuronale del comportamento oggetto dell’esperimento stesso, dunque l’esperimento come costruzione dell’esperienza; infine il problema dell’«elaborazione statistica» (ibid.), anch’essa questione “classica”, che presuppone determinati parametri di funzionamento normale/anormale che vengono essi stessi prodotti proprio a partire dai risultati ricavati dagli esperimenti.
Proprio a partire da questo esercizio di prudenza sui dati e sui risultati si può affermare che l’esigenza di una neuroetica si ha a partire da due ordini di questioni.
In primo luogo la neuroetica in quanto “etica delle neuroscienze” riattiva e amplifica tutte le questioni etiche che sorgono nella relazione tra pratica scientifica e politiche sociali; la questione non è di poco conto dal momento che una sorta di neuromitologia sembra promettere che «conoscere il funzionamento del cervello porti direttamente a conoscere la personalità di un individuo e quindi a prevedere i suoi comportamenti» (p. 35), il che equivale a dire una vera e propria rivoluzione nell’ambito della sicurezza pubblica con le conseguenti amplissime possibilità di controllo (direttamente farmacologico) preventivo. La domanda che attraversa il sistema penale almeno a partire dal XIX secolo e che chiede: “quest’individuo è pericoloso?”, sulla quale si fonda la criminologia, sembra poter in questo modo trovare una risposta neurobiologica. La pericolosità sociale ha una radice “naturale” e può avere terapie mediche adeguate. Il testo della Boella è una risposta anche a interpretazioni di questo tipo.
In secondo luogo la neuroetica si configura come la possibilità di un’analisi che, a partire da una valutazione equilibrata dei risultati sperimentali, interroga e riattiva i più classici e dibattuti problemi etici come la responsabilità e la libertà. È come se la neuroetica aprisse nuove strade e nuovi percorsi all’analisi del sé a partire dallo studio delle precondizioni neurobiologiche del fatto morale. Con le tecniche del neuroimaging sembra potersi profilare la possibilità di una stretta correlazione tra gli stati psichici e l’attivazione di determinate aree del cervello in maniera tale da definire questa relazione come “causale”. E qui ci troveremmo nuovamente dinanzi alle domande da cui siamo partiti: una qualsiasi deliberazione nascerebbe da una determinata relazione neuronale per cui ci troveremmo di fronte al più classico dei riduzionismi mediante il quale il fatto morale sarebbe del tutto determinato dal funzionamento oggettivo del cervello. Anche in questo senso il testo della Boella rappresenta una maniera per andare oltre questa forma di riduzionismo.
Questo lavoro si concentra e analizza soprattutto questo secondo aspetto perché «la neuroetica è interessata alla morale prima della morale, ossia all’ambito di una sensibilità morale che inizia a manifestarsi nella vita organica, risponde a esigenze specifiche dell’organismo nel rapporto con l’ambiente, ma non assumerebbe il suo significato propriamente umano se non la guardassimo alla luce della ricchezza complessiva della vita morale quale la sperimentiamo o vanamente la inseguiamo giorno per giorno» (p. 42).
La morale prima della morale, così come la intende la Boella, è una morale incarnata nel vissuto ed è proprio questo aspetto fenomenologico a interessare. Per questo il vero e proprio punto centrale dello studio consiste nella rivalutazione dell’aspetto emotivo all’interno del fatto morale. Non si tratta della riproposizione della (ormai superata) dicotomia ragione/sentimento ma una rivalutazione dell’emozione all’interno della dimensione morale; tutto questo è reso possibile anche grazie alle evidenze del neuroimaging: «lo studio del cervello rende ormai evidente che nell’attività di ponderazione delle scelte, di previsione del futuro, di discernimento e valutazione delle opportunità di agire, fondamentale è il ruolo delle emozioni rispetto alle funzioni cognitive» (pp. 44-45). Si fa riferimento, in questi passaggi, agli importanti lavori di Damasio che, a partire dallo studio del classico caso di Phineas Gage e di altri casi da lui direttamente analizzati, ha posto le basi per un nuovo approccio alle questioni riguardanti il comportamento umano. In primo luogo Damasio parla di “marcatore somatico”, ovvero una serie di reazioni corporee emotive che si trovano a fondamento dell’agire morale perché orientano verso la decisione. In secondo luogo sostiene che il cervello ha la capacità di imparare dalle risposte corporee e di comportarsi come un simulatore mediante il meccanismo del “come se”. Ma le “emozioni” di cui si discute non hanno nulla a che vedere con la dimensione dell’irrazionalità: «le emozioni non hanno bisogno di essere “razionali” nel senso di essere coscienti […] esse sono razionali in un altro senso, quello di una razionalità pratica e valutativa […] sono forme di intelligenza consapevole, hanno la stessa capacità di darci informazioni e conoscenze sul mondo esterno di altre forme di percezione e servono perciò da “guida interna” riguardo al rapporto fra il soggetto e le circostanze» (p. 58). Ciò che il neuroimaging permette di comprendere è che nel momento in cui è necessario sviluppare una scelta o un comportamento morale concorrono a questa scelta sia sistemi neurali emotivi sia sistemi neurali cognitivi; questi ultimi hanno una dimensione “utilitaristica” nella valutazione della relazione costi/benefici di un’azione mentre la dimensione emotiva è ciò che apre all’Altro, alla relazione, alla reciproca dipendenza degli esseri umani. Il concorrere di entrambi alla valutazione morale permette di comprendere la ricchezza delle risposte di carattere morale che l’uomo può dare a una medesima “situazione”.
Se in questa maniera si mette in luce l’importanza della “dimensione emotiva”, ciò non toglie che, trovandoci al livello di un certo funzionamento di un organo, il cervello, queste scoperte potrebbero destabilizzare se non addirittura rivoluzionare il nostro modo di intendere la libertà di giudizio e la responsabilità. Si tratta del noto esperimento di Benjamin Libet, secondo il quale l’attivazione cerebrale connessa all’atto di “prendere una decisione” anticipa di alcune frazioni di secondo la consapevolezza dell’agire; in questo modo sembra essere definitivamente rinchiusa in un museo di antiche e superstiziose credenze, ogni riflessione che si richiama alla libertà del volere e alla responsabilità. Ma è proprio la dimensione emotiva ad aprire l’uomo al mondo e all’Altro, alle interazioni di carattere economico, sociale e culturale. Se «i dati sperimentali permettono di indagare alcuni aspetti del processo decisionale e […] portano, è vero, a ridimensionare il ruolo della volontà e del controllo cosciente nell’agire» (p. 80), è sicuramente da sottolineare che «siamo […] responsabili fino al punto in cui arriva la nostra capacità di attrarre nella sfera della nostra esperienza, di chi noi siamo, l’insieme di desideri, progetti, significati, vincoli biologici e legami intersoggettivi su cui costruiamo la nostra storia di vita» (p. 86). In questo senso la neuroscienza non rivoluziona realmente l’etica così come siamo stati abituati a pensarla, in quanto non fa altro che aggiungere un nuovo elemento all’interno dell’intricata matassa dell’esperienza umana. Non bisogna né cedere a un’eccessiva naturalizzazione dell’umano in maniera tale da renderlo una macchina (riduzionismo della res extensa) né arroccarsi in una prospettiva assolutamente spirituale dell’umano, che conduce a un riduzionismo uguale e contrario, e che lo sottrae alla sua dimensione naturale (riduzionismo della res cogitans). L’“errore di Cartesio” è ciò che Damasio afferma di dover superare; una non equilibrata analisi delle questioni etiche connesse alle neuroscienze rischia di riproporlo a un altro livello. Ben più pervasivo.
Ed è in questa direzione che assume senso l’ultima parte dello studio della Boella che, a partire dalla scoperta dei “neuroni specchio”, si concentra sulla possibilità di pensare l’empatia come elemento fondamentale costituente l’umano: «l’empatia è un modello di esperienza complesso che nasce da una relazionalità e da un’interdipendenza originarie e inconsapevoli, sulle quali si fonda, e che matura attraverso attività che coinvolgono la percezione, la memoria, l’affettività e le operazioni cognitive» (p. 103).
Per concludere le neuroscienze non riescono a condurre a un riduzionismo del fatto morale al funzionamento oggettivo del cervello, non riproducono il meccanismo della frenologia del XIX secolo, bensì permettono di incamminarsi nella direzione di una «morale consapevole della fragilità dei meccanismi vitali, attenta alla mutevolezza e fallibilità delle scelte e soprattutto all’importanza della relazione con gli altri» (p. 110).
La posizione della Boella è precisa e netta, volta a restituire una complessità ancora maggiore dell’umano; resta comunque il fatto che la partita è ancora assolutamente aperta e che a decidere all’interno di questo “indecidibile” concorrono (e a volte sono determinanti) considerazioni di carattere economico e politico.
Delio Salottolo
S&F_n. 5_2011