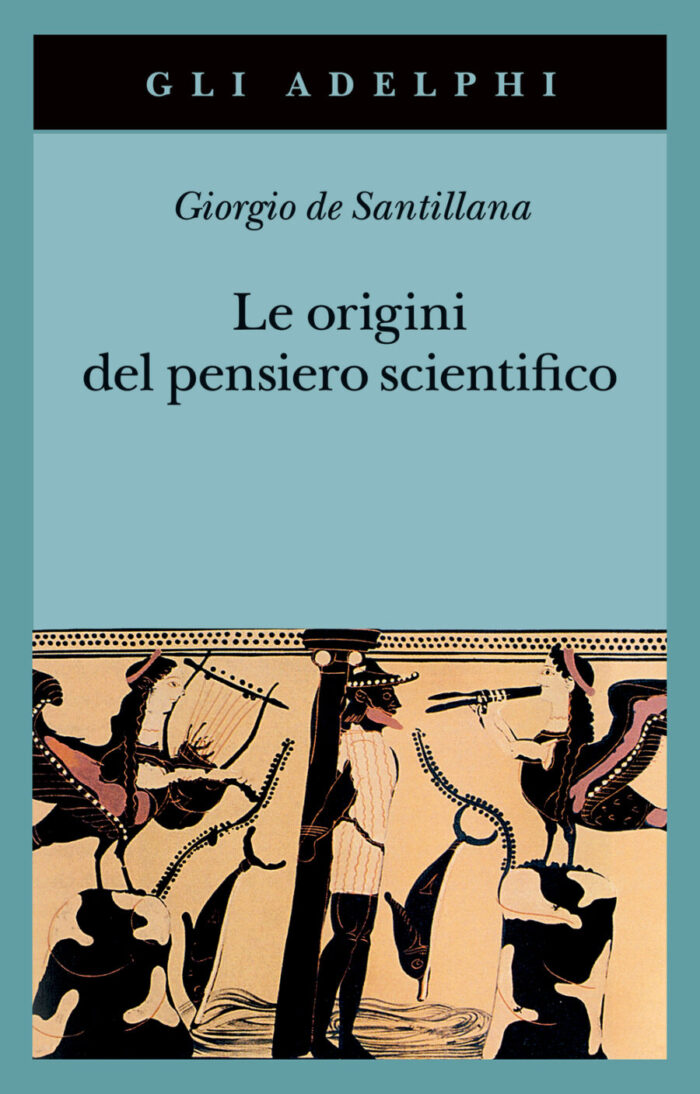Pubblicata per la prima volta nel 1961 con il titolo The Origins of Scientifical Thought. From Anaximander to Proclus. 600 B.C. – 500 A.D., Adelphi ripropone quest’opera dello storico della scienza e della filosofia Giorgio de Santillana. Nel libro – tradotto in italiano da Giulio De Angelis e curato da Mauro Sellitto – l’autore si pone due obiettivi: il primo è dimostrare che il pensiero degli antichi intellettuali costituisca la base della scienza moderna; il secondo è chiarire come la classica dicotomia tra sapere scientifico e umanistico sia – a partire già dall’antichità – un paradigma fuorviante e infondato.
Per fare ciò, de Santillana ripercorre le tappe fondamentali della storia culturale dell’Occidente, a partire dal pensiero mitico arcaico (tema trattato da de Santillana stesso ne Il mulino di Amleto) fino alle correnti delle filosofie neoplatoniche. Iniziare dal mito è fondamentale, infatti de Santillana – riferendosi agli studi antropologici di Sir James Frazer – afferma come «l’antichissima diffusione mondiale di credenze, operazioni magiche e riti di fertilità […] siano la profonda infrastruttura universale delle nostre culture storiche, ancor vivi ed operanti ai giorni nostri» (p. 17). L’indagine filosofica sul principio primo di tutte le cose ha la propria base in queste credenze; lo scarto sta nella concezione del principio stesso, infatti «se il pensiero ionico seguì la strada della “fisica” ciò è dovuto al fatto che la causa delle cose non venne più concepita come dramma o mito, ma come un certo tipo di sostanza primordiale e stabile» (p. 35). Per intellettuali come Talete e Anassimandro diventa fondamentale il lemma greco physis; tuttavia – come nota l’autore –, non dobbiamo considerare questa parola nella sua traduzione latina, natura rerum, bensì accoglierla nel suo significato originario: «il verbo da cui deriva, phynai, come le parole latine nasci, natura, significa “crescere” o “svilupparsi”, quindi potremmo tradurre physis con l’espressione “ciò da cui le cose nascono o si sviluppano”» (p. 39). Interrogarsi sull’origine materiale della realtà sensibile significa anche interessarsi alle attività umane legate a tale realtà; non a caso, accanto alle prime speculazioni filosofiche, troviamo le riforme politiche di Solone, le opere ingegneristiche di Eupalino e Mandrocle, le invenzioni di Teodoro e la creazione delle prime carte geografiche ad opera di Ecateo e Anassimandro.
La ricerca filosofica del principio primo apre la strada alle prime teorie scientifiche: i capitoli centrali sono dedicati ai cosiddetti filosofi presocratici, coloro che hanno gettato le basi della scienza moderna. Personalità come Talete, lo stesso Anassimandro, Eraclito e i pitagorici elaborano – con diverse prospettive – teorie naturalistiche che verranno riprese (in alcuni aspetti) dai posteri. Di questi capitoli, due risultano particolarmente interessanti: il sesto, intitolato L’universo del rigore, incentrato su Parmenide e la scuola eleatica, e il nono, dedicato a Leucippo e Democrito, intitolato Gli atomi e il vuoto. Nel sesto capitolo de Santillana mira a liberare Parmenide dalle interpretazioni che lo etichettano come il primo dei metafisici; egli nota: «Se interpretiamo il termine “Essere” non come una misteriosa potenza verbale, ma come una parola tecnica che designa qualcosa che il pensatore aveva in mente ma non poteva ancora definire, e sostituiamo a esso una x nel contesto dell’argomentazione di Parmenide, ci sarà facile vedere che vi è un altro concetto, e solo uno, che può essere messo al posto di x senza dar luogo a contraddizioni in qualsiasi punto del testo; quel concetto è il puro spazio geometrico […]» (pp. 130-131). Parmenide – riprendendo le dottrine pitagoriche ed emendandone i caratteri mistico-religiosi – elabora una teoria matematico-geometrica in cui l’isomorfismo spaziale è la base della realtà in cui viviamo. de Santillana ci presenta il capostipite della scuola di Elea da una prospettiva inusuale: Parmenide non è il pensatore oscuro che parla dell’essere e del non essere ma un intellettuale rigoroso intenzionato a proporre un’argomentazione logica (elemento poi formalizzato dal suo discepolo Zenone). Per quanto riguarda Democrito, de Santillana sottolinea il passo avanti compiuto dall’abderita rispetto ai suoi predecessori: se gli altri pensatori si interrogarono su ciò che la materia è, Democrito si chiede ciò che la materia fa. La conoscenza non è legata alla definizione di una determinata sostanza (come dirà in seguito anche Aristotele), ma alle modificazioni che la materia causa nel soggetto conoscente attraverso le sue varie configurazioni. Democrito spiega questa teoria attraverso l’analogia con l’alfabeto, infatti «la parola stoicheia significava tanto lettere dell’alfabeto quanto elementi in generale. Le sillabe, naturalmente, ci indicano per analogia le molecole; e come una parola è qualcosa di più della somma delle sue lettere, così l’associazione degli atomi può dare qualcosa di più delle loro combinazioni geometriche di base, cioè le qualità» (p. 203).
La figura di Socrate segna un punto di svolta: con il filosofo ateniese la natura non è più il centro della riflessione; ciò risulta evidente alla fine del Fedone, in cui «Socrate torna a ragionare della terra, che egli dichiara essere sferica “come è stato rilevato”, dall’aria e dalle acque sotterranee. […] Il brano inizia come una cosmologia, quasi nello stile dei fisici, ma ben presto si rivela come un’allegoria, un paesaggio esistenziale dell’anima, esattamente nel senso in cui lo scenario fisico dei tre regni danteschi è anch’esso un paesaggio esistenziale» (pp. 261-262). Tuttavia, non è con Socrate, bensì con i sofisti, che troviamo un elemento essenziale per la storia della scienza: se la riflessione filosofico-antropologica del primo è legata alla cura dell’anima in vista della vita ultraterrena, «I sofisti furono abbastanza intelligenti da capire che se questo è un mondo [quello terreno] che l’uomo crea per se stesso, allora la tecnologia assume una particolare importanza; essi furono i primi a parlare apertamente di Progresso, magica parola, e a mettere l’accento sulla funzione dei mestieri» (p. 237). La nozione di “progresso” – fondamentale per scienziati e filosofi come Bacone e Comte – è uno dei capisaldi del pensiero scientifico moderno: esso rappresenta la convinzione che l’uomo, grazie alle proprie conoscenze e abilità, possa migliorare la propria condizione. I sofisti hanno esattamente questa convinzione: fondamentali per loro sono i concetti di arete e techne, entrambi legati alla dimensione umana della polis.
Nel libro trovano spazio anche analisi in merito alla matematica, l’astronomia, la geografia e l’ingegneria. Queste discipline conoscono un notevole sviluppo in età ellenistica; in questo periodo operano infatti intellettuali come il geografo Tolomeo, il matematico Eudosso di Cnido, Erone di Alessandria e Plutarco. La loro importanza storica – spiegata ottimamente da Lucio Russo ne La rivoluzione dimenticata – viene riconosciuta da vari autori successivi come Leibniz, Emerson e Dedekind. Tale splendore culturale va incontro a un declino dopo il 200 a.C., «linea divisoria stabilita non solo dalla morte di Archimede ma dal consolidarsi del predominio romano sugli imperi ellenistici. Dal punto di vista intellettuale quelli che erano stati decenni divengono secoli» (p. 371). Le cause di questo tracollo culturale (per riprendere il titolo di un altro libro di Lucio Russo) sono tre: la vita in un contesto sociale e culturale eterogeneo, una fase di crisi economica e una mentalità reazionaria insita in molti intellettuali. Tutti questi eventi concomitanti creano una situazione in cui la curiosità scientifica viene limitata da un potere accentratore, per nulla incline a uscire dagli schemi tradizionali. Ma – malgrado questo declino che si protrarrà per secoli – un fatto rimane innegabile: «Le conquiste della scienza greca, nonostante tutto, costituirono il punto di partenza della nostra rinascita scientifica nel Seicento» (p. 379).
Al termine della lettura si può osservare come de Santillana centri pienamente gli obiettivi posti all’inizio dell’opera. L’autore delinea con chiarezza le connessioni che intercorrono tra i filosofi antichi e gli scienziati moderni, evidenziando i punti di continuità e le differenze in base al mutare del contesto storico. Anche l’apparente scissione tra sapere scientifico e sapere umanistico viene ben spiegata da de Santillana: in tutti i capitoli si sottolineano i contributi che i vari autori hanno portato in diverse discipline. Un buon esempio è Parmenide, di cui sappiamo «che dette contributi importanti alla geometria e all’astronomia; classificò le figure geometriche; insegnò a riconoscere nella Stella del Mattino e nella Stella della Sera (Lucifero e Vespro) un unico pianeta; delimitò sul globo terraqueo le cinque zone in cui è suddiviso dai tropici e dai circoli artici […]» (p. 123). Altro intellettuale che dimostra l’inadeguatezza di questa dicotomia è Plutarco: lo storico greco è autore – oltre che delle Vite parallele – di una serie di scritti di carattere astronomico come, ad esempio, il dialogo Del volto nel cerchio della luna (scritto che, tra gli altri, ispirerà Copernico e Newton).
Un ultimo punto di forza del testo di de Santillana da evidenziare è l’inserimento di numerosi frammenti e passaggi testuali degli autori presi in esame; in questo modo il lettore ha l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli scritti originali dopo l’analisi critica dello storico. Un libro consigliato sia a chi vuole studiare aspetti teoretici del pensiero antico, sia a chi è interessato a questioni più tecniche sulla storia della scienza.
Efrem Trevisan