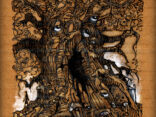Autore
Indice
Abstract
The promethean discourse on the Anthropocene and its limits
In this text, I intend to analyze the Promethean discourse on the Anthropocene, at least with regard to its anthropological presupposition. After a section on the method of reading the texts and this part of the Anthropocene debate, I demonstrate through textual examples in what sense this Promethean discourse has a negativist anthropology at its core. In a final section, I analyze the limitations that make this discourse unserviceable for a real understanding of our ecological-political condition.
1. Sul metodo
Il concetto di Antropocene subisce oggi un impiego talmente vasto che pare impossibile ricondurlo a un significato univoco e certo. L’impressione è quella di stare di fronte a un concetto vuoto o, al massimo, a una parola utilizzata semplicemente per nominare il presente nella sua interezza[1]. Di fronte a un simile stato di incertezza riguardo al significato di un concetto, sono due le strade che si aprono dinanzi a chi voglia chiarificare la situazione. In primo luogo, si può cercare l’autentico significato del lemma in oggetto. Si può cioè cercare di mostrare come “Antropocene” significhi in realtà qualcosa che la confusione del dibattito non farebbe che oscurare. Si tratterebbe, cioè, di ritrovare, al di sotto del clamore di una discussione che avviene sulla superficie, il nocciolo duro di un significato che trascende quella stessa discussione, formandola a priori. Questo significato viene ritenuto essere o legato all’etimo della parola o al suo impiego: nell’ultimo caso, tuttavia, quello che si fa è prendere un sottoinsieme degli impieghi di questo termine e elevarlo a senso generale del concetto[2]. Al di qua dell’uso, dunque, vi sarebbe un significato che lo studioso avrebbe il compito di rinvenire al fine di smascherare gli impieghi ideologici che tentassero di oscurare questo nucleo di senso. In generale, tale approccio è adottato da chi si propone di criticare il concetto di Antropocene come intrinsecamente colonialista, etnocentrico, antropocentrico.
Vi è tuttavia un’altra strada che è possibile seguire al fine di comprendere meglio questo dibattito. Essa consiste nell’identificare una serie di presupposti e di domande che, di volta in volta, costituiscono una posizione e un uso specifico del concetto in oggetto. Non si tratta dunque di sostenere che il significato di ogni concetto si risolva interamente nel suo uso immediato: in questo caso, infatti, sarebbe impossibile dare una lettura complessiva di un qualsiasi dibattito e si ricadrebbe così in un empirismo assoluto, in cui ogni singolo uso dovrebbe essere elevato a posizione autonoma e degna di attenzione. Se l’approccio visto precedentemente colloca il significato in uno spazio trascendente rispetto all’uso, uno di questo tipo lo pone in rapporto assolutamente immanente ad esso: il significato di un concetto sarebbe, semplicemente, l’insieme degli usi che se ne fanno. Un simile modo di ragionare bloccherebbe la strada a ogni analisi del dibattito in quanto troppo vasto per essere riprodotto interamente. Ragionare sul dibattito intorno all’Antropocene a partire dai presupposti delle posizioni di volta in volta in gioco significa invece ritenere che i significati degni di attenzione sono quelli più diffusi all’interno del dibattito e che, al contempo, essi siano cartografabili nella misura in cui riconducibili a una serie di presupposti identificabili a partire dai discorsi. Non vi è un nucleo assoluto e trascendente che forma a priori i significati che di volta in volta “Antropocene” assume: il trascendentale è piuttosto storico, cioè, più semplicemente, consiste nei presupposti e nelle domande che di volta in volta chi tratta di Antropocene assume, naturalmente a partire da una definizione minima di tale epoca come l’attuale intervallo di tempo geologico, in cui molti dei processi che costituiscono il Sistema Terra sono profondamente influenzati dall’attività umana. Non avrebbe dunque senso analizzare ogni singola posizione sull’Antropocene: si tratta piuttosto di rivolgersi a questi elementi trascendentali e fare, a partire da essi, una cartografia del dibattito. A partire da questa metodologia diviene così comprensibile perché tale nozione è declinata in modi contradditori l’uno con l’altro e perché non si tratta di accettare o rifiutare in toto la nozione di Antropocene, bensì di cercare di capire in quale parte di questo «campo di battaglia»[3] che è il concetto di Antropocene posizionarsi. Sono dunque i presupposti che vanno prima di tutto indagati al fine di comprendere le differenze esistenti tra i vari discorsi sull’Antropocene. Un presupposto è la condizione di possibilità di qualcosa. Presupposto di una nozione è un’idea senza la quale tale nozione non avrebbe senso. Chi si oppone all’impiego della nozione di Antropocene, in realtà, si sta sempre ponendo contro una sua specifica declinazione, che è comprensibile solo a partire dai presupposti effettivi che il discorso in oggetto possiede di volta in volta.
Quanto si vuole svolgere in questa sede è l’indagine di uno specifico presupposto di tutta una serie di discorsi sull’Antropocene, che per brevità definiremo prometeici. Esso è essenzialmente antropologico: consiste nell’idea per cui l’essere umano, responsabile dell’Antropocene, è un essere negativo, la cui principale caratteristica trans-storica è quella di negare costitutivamente l’ambiente in cui si pone.
2. Umanità e negazione
Il concetto di Antropocene, nel contesto del discorso prometeico, si struttura intorno alla responsabilità dell’umanità in generale, pensata come un tutto indistinto, nell’aver generato questa svolta geologico-storica. Ecco perché tutti i testi riconducibili a tale discorso che si pongano l’obbiettivo di affrontare lo statuto dell’Antropocene come epoca debbono necessariamente dedicarsi allo studio dell’essere umano nella sua assoluta differenza in rapporto agli altri esseri viventi. Il rappresentante più noto di questo discorso è forse Yuval Noah Harari che nella sua coppia di best seller ha delineato una visione dell’Antropocene come epoca del dominio incontrastato dell’uomo sul pianeta Terra[4], epoca le cui condizioni di possibilità sono da rinvenire precisamente su un piano strettamente antropologico e non storico-economico. Ciò che vi è di più proprio nell’umanità è per Harari la sua capacità di fare astrazione dal mondo naturale e di negarne le determinazioni che di volta in volta si danno. L’essere umano, infatti, è secondo Harari un vero e proprio «serial killer ecologico»[5]. Questa sorta di lato oscuro si manifesterebbe fin dalla Preistoria. Egli avrebbe estinto la megafauna pleistocenica[6] e l’Homo Neanderthalensis, mostrando da subito la sua essenza distruttiva nei confronti del mondo naturale. Questa capacità di negazione, secondo Harari, è talmente caratteristica dell’Homo sapiens che tutte le specificità di questo strano animale sono radicate nella costitutiva capacità di mettersi a distanza dal mondo quale emerge nel corso della sua storia. La differenza tra l’essere umano e l’animale, sostiene Harari, sta nel fatto che mentre il secondo deve accettare il mondo che lo circonda nella sua solidità e fondare su di esso le proprie relazioni “sociali”, il primo può risignificarlo, ricostruirlo e finanche distruggerlo, proprio in virtù di questa «scintilla umana»[7], la quale, lungi dal consistere solo nella capacità di cooperare in modo complesso, ha la sua radice nel vuoto che l’umano già da sempre è, in questa sua capacità negativa che fonda anche la dimensione della cooperazione. In virtù di questo negare continuamente la natura l’Homo sapiens ha dapprima dato un senso al mondo, per perderne poi il controllo[8] generando l’epoca contemporanea a cui si dà il nome di Antropocene. Per Harari, tuttavia, questo momento non è che un breve passaggio: presto l’essere umano, grazie alle meraviglie della tecnica, potrà padroneggiare l’interezza del Globo, superando la povertà, la morte, le malattie[9] e divenendo grazie a questa sua capacità di negazione del mondo dato un dio in Terra, Homo deus.
Anche Mark Lynas ha sostenuto che l’ascesa dell’uomo come specie è da ricondurre precisamente al suo essere un organismo ribelle[10], destinato a divenire al contempo il creatore e il distruttore della vita stessa. Nella sua ricostruzione gioca un ruolo decisivo il rapporto tra l’Homo Sapiens e il fuoco: è in quanto Homo pyrophilus[11] che, incendiando gli ambienti del mondo, l’essere umano ha donato a essi una forma nuova. In forza di questa sua distruttività l’umano ha potuto traghettare il pianeta verso un’epoca geologica interamente nuova. Recentemente Erle Ellis, uno degli scienziati che più si è speso sul piano della ricerca e anche su quello della divulgazione del concetto di Antropocene, ha esplicitamente sostenuto che «l’uomo costituisce una vera e propria forza distruttiva in grado di cambiare la Terra in peggio e in modo irreversibile»[12]. Da questa constatazione deriva la simpatia che Ellis e Harari provano per l’ipotesi di William Ruddiman secondo cui l’Antropocene sarebbe cominciato molte migliaia di anni fa, nella misura in cui già allora sarebbe stata apprezzabile un’alterazione significativa dei gas serra presenti nell’atmosfera dovuta alla rivoluzione Neolitica[13]. Tale ipotesi, se confermata, certificherebbe la potenza distruttiva-trasformatrice dell’essere umano. Già nel 2007, William Steffen, John McNeill e Paul Crutzen, pur distaccandosi dall’ipotesi di Ruddiman, sostenevano in effetti che la distruzione su scala globale degli ambienti naturali non è, in fondo, che il medesimo gesto che già l’Homo erectus faceva nelle foreste del Paleolitico su una scala più ampia[14]. È in ogni caso certo, per questi studiosi, che il concetto stesso di Antropocene (e quindi la distruzione degli ecosistemi su scala globale) sia in qualche modo legato all’essenza stessa dell’uomo: essi non hanno alcun problema a sostenere che tutte le società umane mostrano qualche segno di un futuro avvento dell’Antropocene stesso[15]. È in forza di questa antropologia che il discorso prometeico sull’Antropocene assume a tratti caratteri prettamente teologici, non solo nel senso di una presa di potenza divina dell’umano, ma anche in quello dell’identificazione di una colpa essenziale, inseparabile dall’Homo Sapiens come specie. Guido Chelazzi, nel tentativo di fare una storia naturale della colpa ecologica, scrive che «i delitti» di cui l’Homo sapiens in quanto specie è accusato «non sono qualcosa di occasionale o preterintenzionale, ma derivano dalla natura intima del soggetto, che fin da molto giovane ha dato mostra di una profonda inclinazione a delinquere»[16].
Per il discorso prometeico sull’Antropocene, dunque, la crisi ecologica contemporanea si prospetta come un destino. Dato l’Homo sapiens e la sua essenza distruttiva, interna al mondo solo nella misura in cui lo annulla continuamente, non può che darsi come sua conseguenza assolutamente necessaria l’Antropocene e la distruzione degli ecosistemi terrestri. Tuttavia, l’orizzonte teorico che compone tale discorso non è fatto solo da questa parte genealogica: la questione non è solo quella di spiegare perché c’è l’Antropocene. Questo discorso si confronta anche, com’è ovvio, con il problema del come vivere nell’Antropocene e in un eco-sistema globale ove si manifesta una profonda frattura tra il livello di sviluppo e di consumo umano (è questo il linguaggio con cui tale discorso pone la questione) e tutta una serie di limiti bio-geo-logici propri del pianeta Terra. La risposta, autenticamente trasversale alle varie posizioni, è quella della geo-ingegneria, cioè dell’utilizzo di un insieme di tecniche mastodontiche volte a compensare i danni prodotti dall’umanità al pianeta[17]. Si tratta di una prospettiva che prende sempre più piede all’interno del dibattito pubblico e delle proposte di policy nei confronti della crisi ecologica. Il fatto che l’uomo sia l’essere che per natura distrugge il suo ambiente di vita non porta semplicemente all’annichilimento del mondo naturale che ha resistito fino a quando questo vuoto non è apparso sulla faccia della Terra, bensì ad una ri-costruzione tecnica del Globo che non lascia margini ad alcuna agency naturale o non umana. Questo negativo nell’uomo, in un certo senso, si muove: da dentro l’uomo a fuori di lui, dall’uomo come vuoto nell’essere all’uomo come annullatore di quanto è presente. Si spiegano così i sogni prometeici di gestione tecnica e manageriale del pianeta proposti da Harari, Ellis, Lynas nonché da Paul Crutzen, l’inventore del termine Antropocene[18]. Non deve stupire che un Globo ricostruito tecnicamente sia visto dal discorso prometeico come l’unica via di uscita dalla crisi ecologica. Questo non avviene, infatti, per accidente o perché di volta in volta gli autori abbiano ritenuto che questa scelta pratica fosse l’unica percorribile. Si tratta piuttosto di un esito necessario, dato il presupposto antropologico sopra delineato. Se l’uomo, per essenza, non fa altro che distruggere quanto di naturale lo circonda per portarlo continuamente oltre sé stesso, cioè per annullare la realtà nella sua autonomia e nella sua resistenza, se l’uomo cioè è l’essere negativo per definizione, non si vede come si potrebbe pensare una via di uscita diversa dalla crisi ecologica che la presa in carico fino in fondo di questa stessa essenza nichilistica. Il «pianeta scelto»[19] di cui parla Oliver Morton, uno dei principali propugnatori della soluzione geo-ingegneristica e del discorso prometeico sull’Antropocene, non sarebbe così che la concretizzazione ultima di quella medesima essenza umana che già da sempre lo ha destinato all’Antropocene. A problema tecnico non può esserci che soluzione tecnica: come recita il titolo di un noto articolo, l’unica soluzione all’Antropocene consiste in un passaggio dal cambiamento climatico a una gestione integralmente tecnica del Globo terrestre[20].
3. Limiti
Apparentemente, il discorso prometeico sull’Antropocene risulta convincente. Esso è capace di spiegare la genesi della nostra epoca e offre un modo per servirsi della sua problematicità come spinta verso un futuro quasi paradisiaco. Tale discorso, riconducibile all’ecomodernismo di Ted Nordhaus e Michael Schellenberger[21], vi aggiunge una prospettiva antropologico/negativa. Tuttavia, a uno sguardo più approfondito, questo tipo di ragionamento manifesta due autentici blocchi teorico/pratici con cui sarebbe assurdo non confrontarsi. Il primo consiste nell’impossibilità che tale discorso manifesta nel pensare la condizione di passività intrinseca alla vita umana sul pianeta Terra. Al discorso prometeico è cioè impossibile concepire l’esposizione dell’umano a tutto ciò che è naturale, cioè, in generale, a tutto ciò la cui agency precede l’umano ed è dotato di una certa autonomia rispetto a esso. Basti pensare alle pagine iniziali di Homo Deus, dove Harari chiosa soddisfatto che l’umanità ha ormai assunto un grado di potere tale sul mondo naturale da rendere praticamente impossibile l’avvento di una pandemia che possa creare un qualche danno reale al pianeta nuovo, forgiato dall’uomo[22]. Non si tratta di un mero abbaglio, bensì di qualcosa che manifesta un problema strutturale di questo approccio al problema ecologico e più in particolare all’Antropocene: l’incapacità pressoché totale di pensare quanto nel mondo resiste all’azione dell’umano e quanto, in quello stesso mondo, gli è necessario per la sua stessa esistenza. Il discorso prometeico, a un primo sguardo realista fino al cinismo, non pare in grado di confrontarsi con quanto di più scontato e più reale vi è: il fatto che gli esseri umani hanno un corpo con cui vivono in un mondo che oppone una certa resistenza a qualsivoglia azione, che ha un certo grado di attività irriducibile all’essere umano stesso.
Esso, inoltre, incontra il suo limite in un secondo blocco che necessariamente gli si pone davanti: l’incapacità di pensare il nuovo sul piano politico, etico e persino tecnico. Non solo il discorso prometeico esprime un’autentica mitologia della tecnica come unica speranza di salvezza per il genere umano, che allo sviluppo illimitato di essa appare condannato: esso non è nemmeno in grado di apprezzare le differenze tra le varie forme storiche, contingenti, di tecnica e dunque i diversi rapporti socio-naturali che si sono storicamente instaurati. Esso, infatti, fonda la rottura dell’Antropocene in una lettura destinale della storia umana, lettura fondata a sua volta su un modo specifico di concepire l’uomo come negativo del mondo naturale, come vuoto al suo interno. In questo modo ci si preclude la possibilità di pensare la contingenza. Non si riesce, cioè, a vedere quanto la rottura che si è verificata con l’avvento di forme sociali integralmente storiche, come ad esempio quella legata al modo di produzione capitalistico[23], non sia affatto necessaria. Tale discorso non può dunque immaginare rapporti diversi tra l’essere umano e il mondo naturale, così come forme diverse, non prometeiche, di tecnica.
Il discorso prometeico sull’Antropocene, dunque, come pensa l’intero percorso storico-umano sotto la forma di un destino più o meno già inscritto nell’essenza stessa dell’umano, così legge anche il futuro come un indefinito approfondimento delle dinamiche che animano già il nostro presente. Non è un caso che questo discorso debba necessariamente rimuovere dal suo sviluppo argomentativo l’intera antropologia culturale, che anche in anni recenti ha dimostrato la profonda differenza del rapporto instaurato da altre società storiche con il mondo naturale, rispetto a quello capitalistico-occidentale[24]. Il nucleo di questo discorso, come si è detto, è lo stesso che gli rende impossibile pensare sia la passività che la novità: esso risiede nel presupposto antropologico che lo anima. Solo il superamento di tale fondo concettuale può aprire a un diverso modo di intendere l’Antropocene. Lungi dal superare tale concetto, una simile prospettiva renderebbe possibile concepire diversamente il rapporto tra la storia umana e quella geo-bio-logica e allontanarsi così, in via definitiva dal prometeismo: sembrano andare precisamente in questa direzione le prospettive di Dipesh Chakrabarty, insieme a quelle di molti altri[25].
[1] Y. Malhi, The concept of Anthropocene, in «Annual Review of Environment and Resources», 42, p. 85.
[2] D. Hartley, Anthropocene, Capitalocene, and the problem of Culture, in Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, a cura di J. Moore, PM Press, Oakland 2016, pp. 155-157.
[3] S. Baranzoni, P. Vignola, Antropocene: un campo di battaglia. Limiti, responsabilità e il dovere di fuga, in «Azimuth», 9, 2017, numero speciale.
[4] Y.N. Harari, Homo Deus. Breve storia del future (2016), tr.it. Bompiani, Milano 2017, pp. 115-156.
[5] Id., Sapiens. Da animali a dei: breve storia dell’umanità (2012), Bompiani, Milano 2014, p. 90.
[6] Ibid., pp. 85-99.
[7] Id., Homo Deus, cit., p. 159.
[8] Ibid., p. 426.
[9] Ibid., pp. 7-111.
[10] M. Lynas, The God Species. How the planet can survive the age of humans, FourthEstate, Notting Hill 2011, p. 18.
[11] Ibid., p.29.
[12] E. Ellis, Antropocene. Esiste un futuro per la Terra dell’uomo? (2018), tr. it. Giunti, Milano 2020, p. 20.
[13] W.F. Ruddiman, The Anthropogenic Greenhouse Era began Thousands of Years Ago, in «Climatic Change», 61, 2003, pp. 261-293.
[14] W. Steffen, J. McNeill, P. Crutzen, The Anthropocene: are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, in «Ambio», 36, 8, 2007, p. 614.
[15] W. Steffen et al., The Anthropocene: conceptual and historical perspectives, in «Philosophical Transactions of the Royal Society», 369, 2011, pp. 842–867.
[16] G. Chelazzi, L’impronta originale. Storia naturale della colpa ecologica, Einaudi, Torino 2013, p. 3.
[17] C. Hamilton, Earthmasters. The Dawn of the Age of Climate Engineering, Yale University Press, New York 2013.
[18] P. Crutzen, Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era (2005), tr. it. Mondadori, Milano 2005.
[19] O. Morton, Il pianeta nuovo. Come la tecnologia trasformerà il mondo (2015), tr. it. Il Saggiatore, Milano 2017, p. 317.
[20] W. Steffen, A. Persson, L. Deutsch et al., The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship, in «Ambio», 40, 8, 2011, pp. 739-761.
[21] T. Nordhaus, M. Schellenberger, Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility, Unabridged edition, 2007.
[22] Y.N. Harari, Homo Deus, cit., pp. 15-38.
[23] J. Moore, Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nella crisi planetaria, Ombrecorte, Verona 2017.
[24] R. Brigati, V. Gamberi (a cura di), Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Quodlibet, Macerata 2019.
[25] Su questo P. Missiroli, Teoria critica dell’Antropocene. Vivere dopo la Terra, vivere nella Terra, Mimesis, Milano 2022 (forthcoming).