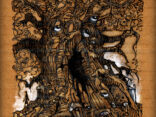Autore
Indice
- Pensare il dolore e il suo doppio
- Il “miraggio spartano”
- La “filigrana” del dolore
- La simbolica del dolore
- Conclusioni
↓ download pdf
S&F_n. 25_2021
Abstract
Pain in consciousness, between Stoicism and Analytic Philosophy
My essay will discuss how the so-called “Spartan mirage” has influenced the philosophical tradition about “pain”. Stoicism and later Christian moral thought have focused on the primacy of conscience among human mind’s faculties. The general approach will be analytical, because I am going to argue that the concept of pain is introduced into the ancient philosophical debate together with what I would call a “sparring partner”. Within this linguistic game, the constant confrontation of “pain” with a “double”, namely conscience, has produced a drift, a prejudice with evident social consequences. The mode of introduction and its longstanding effects on ethics are examined and compared to the contemporary debate on pain’s neurophysiology.
Non potrebbe la gloria delle macchine consistere nel loro essere senza questo stesso tanto glorificato dono del linguaggio? «Il silenzio – è stato detto da uno scrittore – è una virtù che ci rende graditi alle creature nostre simili»
Samuel Butler, Erewhon
- Pensare il dolore e il suo doppio
Pensare il dolore induce alla riverenza che spetta alle questioni tanto delicate quanto l’epidermide, che si screpola e a volte si fende, per l’ingiuria del tempo o della sorte. È allora dovuta la sosta, l’esitazione, il rispetto, perché parlarne impegna all’intensità del suo concetto, avvertiti d’una possibile profanazione. Pensarlo è meno che viverlo e ritagliarsi la tranquillità per riflettere sul dolore ispira lo stesso disagio che si ha nel passeggiare alla Certosa, da turisti, alla ricerca di tombe monumentali, quando l’unico affanno che punge viene dalle zanzare. Affiora l’angoscia che un terribile convitato di pietra possa animarsi e pronunciare contro di noi gelide parole di condanna. Nel Don Giovanni di Mozart, la statua del Commendatore prende vita per avere vendetta e l’impenitente seduttore, che lo ha ucciso, ora ne subisce la persecuzione, dannato all’inferno.
Si parla del dolore con scaramanzia, misurando i passi intorno al recinto murato dove Don Giovanni nella notte imprudente si spinge, inseguito dalle sue colpe. Mai pago d’importunar ragazze, sfugge all’ennesimo guaio saltando oltre il muro, dove l’attendono le parole della statua: «Di rider finirai pria dell’aurora»[1]. Con la solita spavalderia, costringe il servo Leporello a invitare la statua a cena (II, 12): «O statua gentilissima / del gran Commendatore...»[2], invito che sarà raccolto a suo mortale danno, inghiottito dal diavolo tra fuoco e fiamme.
Come dirà Kierkegaard, nel suo commento all’opera di Mozart: «il Commendatore è coscienza»[3], mentre Don Giovanni rappresenta l’immediatezza dei sensi, che cercano furiosamente il loro appagamento e non amano star troppo vicini alla coscienza: la passione, la musicalità dell’eros in fermento ne sarebbe compromessa[4].
Don Giovanni è la spumeggiante forza del desiderio, l’onda che s’ingolfa nei varchi della costa e poi si riprende inesausta. Il suo ritmo è lo stesso della vita e a volerlo seguire se ne esce storditi, privi di quel supplemento d’anima che il Commendatore torna a reclamare. Quando la statua risponde all’invito di Don Giovanni e si presenta a cena, gli prende la mano e chiede conversione, ma invano. Il seduttore, stretto da quella gelida morsa, resiste a tutto, finché un «tremore insolito» lo prende (II, 16)[5]:
Chi l’anima mi lacera?
chi m’agita le viscere!
che strazio, ohimè, che smania!
che inferno! che terror!
Leporello, quando prova a raccontare la scomparsa del padrone tra le fiamme dell’inferno, non trova di meglio che dire: «Venne un colosso...»[6]. Si tratta della statua del Commendatore, che per una sola volta è così chiamata. La parola deriva dal greco kolossos, che significa “doppio” e indicava in antico le immagini sostitutive delle persone in carne e ossa, usate per scopi propiziatori: si seppelliva il kolossos per evitare di essere perseguitati dalle anime di defunti morti lontano, un funerale «in contumacia»[7].
Sulla scena del Don Giovanni di Mozart incombe il padre ucciso che vuol vendetta e il pentimento del dissoluto; il colosso non si accontenta di essere un doppio, un rimorso facilmente sopito. Irrompe sul palco e lo devasta, toglie la terra sotto i piedi a chi vuol godersi la vita. Porta con sé un corteo di dolori e lo spettro d’indicibili sofferenze, in pratica l’inferno. La statua, la fissità, il gelo s’impadroniscono della vita del seduttore e la consegnano all’aguzzino, da quel momento in poi non importa che un essere umano soffra, è solo il perverso che merita d’essere punito, con la severità che si conviene agli impenitenti.
Anche sulla scena del dolore c’è un doppio, un supplemento d’anima, un colosso che reclama il proprio posto e pretende un corpo, per far valere i diritti violati.
Dopo l’esaltazione della carne e della sua frenesia, si lascia parlare lo spirito in tutta la sua saggezza. Ripete che un corpo senz’anima non ha diritto d’esistere, non s’illudano i gaudenti, non c’è trippa per gatti! È però strano che il raggiungimento della coscienza si paghi con il silenzio del corpo, costretto alla museruola come un cucciolo di cane, troppo smanioso per correre libero. In fondo, la parola è culla dello spirito.
Guido Ceronetti ha dato voce al corpo silente e al suo dolore in un bellissimo libro, dal titolo Il silenzio del corpo[8], dove parla dei gemiti e dei miasmi che il nostro compagno inascoltato si lascia pur sfuggire, nonostante secoli di rigida disciplina. La ricerca ormai classica di Paul Veyne[9], sulla morale familiare nell’antica Roma, e i lavori di Michel Foucault[10] sull’etica sessuale hanno messo in evidenza che il «rifiuto del piacere»[11], di cui parla Le Goff a proposito del Cristianesimo, ha un antecedente importante nel periodo che va dall’epoca di Cicerone a quella degli Antonini (I sec. a. C. - II sec. d. C.). Veyne parla di un “puritanesimo della virilità”, di derivazione stoica, a cui s’andrà a sovrapporre l’ascetismo cristiano, col suo caratteristico contempus mundi. Anche se le pratiche ascetiche sono antiche quanto l’umanità[12], è necessario riprendere dal problematico rapporto tra la religione cristiana e il corpo, che spinse San Francesco a trattare con durezza colui che pur chiamava “frate”[13]. Il “giullare di Dio” si immerse nella gelida neve, quando «sentì divampare dentro di sé una grave tentazione sensuale, alimentata dal soffio di quel tale che ha un fiato ardente come brace»[14].
Si deve scegliere a chi dare la parola, quando due soggetti troppo volitivi parlano contemporaneamente, soprattutto se nel corpo abita una forza che sconvolge la coscienza, dai connotati sovrumani. «Quel tale che ha un fiato ardente come brace», il demonio, minaccia di sconvolgere il corpo, tanto quanto il dolore che avrebbe spinto un giovane a gettarsi dalla finestra, per mettere a tacere un terribile mal di denti, se non avesse temuto di finire dannato. Ne parla Ambroise Paré, un noto medico del ‘500, che dice del mal di denti: «È il più grande e il più crudele che ci sia tra tutti i dolori, eccetto la morte: e per la prova, la lascio a coloro che ne sono stati tormentati»[15]. Vale per il dolore, come per il piacere, un certo “ordine del discorso”[16], possono parlare solo con riserva, come s’addice a folli e bambini. Plutarco diceva nel suo Consolazione alla moglie[17]: «un desiderio insaziabile di lamenti, che finisce in gemiti e in percosse, è non meno vergognoso dell’intemperanza nei piaceri». Una censura a cui s’oppone con forza Montaigne:
Del resto, io ho sempre adottato questa regola di cerimonia, la quale comanda così rigorosamente e precisamente di conservare una buona cera e un contegno sdegnoso e disposto alla tolleranza dei mali. Perché la filosofia, che non riguarda se non il vivo e il reale, va appresso a queste manifestazioni esteriori? Lasci questa cura ai commedianti e ai maestri di Retorica, che fanno tanto conto dei nostri gesti. Perdoni coraggiosamente al male quella fiacchezza della voce, se essa non è né di cuore, né di stomaco; e conceda quelle lamentele volontarie al genere dei sospiri, dei singhiozzi, delle palpitazioni, degli impallidimenti che Natura ha messo fuori del nostro potere. Purché il cuore sia senza spavento, le parole senza disperazione, essa si contenti! […] Se il corpo si sente sollevato col lamentarsi, lo faccia; se gli piace l’agitazione, si rivoltoli e si agiti a sua voglia; se gli sembra che in qualche modo il male evapori (come alcuni medici dicono che ciò aiuta a liberare le donne incinte) col mandar fuori la voce con maggiore violenza, o se ne viene alleviata la sua sofferenza, gridi pure. Non comandiamo a quella voce di andare, ma permettiamoglielo[18].
Anche Shakespeare aveva compreso che c’è un’oscura volontà di morte nel mettere un bavaglio al dolore e lo dice nel Macbeth: «Non calatevi il cappello sugli occhi, date parole al dolore. Il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso l’ordine di spezzarsi»[19].
- Il “miraggio spartano”
Si profila all’orizzonte l’antico “miraggio spartano”[20], vagheggiato da molti filosofi[21], cioè l’idea che fosse l’educazione militare a fare il buon cittadino e quindi la tempra di un carattere resistente al dolore. Seneca diceva: «Vivere … militare est»,“la vita è una milizia”[22]. Si rivolgeva al suo discepolo Lucilio, al suo lamento per le tribolazioni della vita.
Gli ricordava che «per un uomo l’unico motivo di infelicità» sta proprio nel «credere che nella natura sia insito qualcosa che egli ritiene possa renderlo infelice». Seneca parlava da saggio stoico: «Non sopporterò più me stesso il giorno in cui non potrò sopportare qualcosa» e rigettava il «modo di parlare così effeminato» del suo discepolo: «Ma volevo vivere, tuttavia senza tanti disagi». Si tratta per il maestro di una secca alternativa tra «vivere in un mercato o in un accampamento militare».
Quel miraggio ha preteso di far coincidere la virtù con la disciplina militare, in cui laconicità[23], cioè brevità, concisione sono un ideale che, a sentire Platone, affascinò i sette sapienti, «entusiasti e innamorati e seguaci della cultura spartana»[24].
La sapienza, dai suoi primordi, va predicando la dura legge della pazienza, «rimedio per ogni dolore»[25], e comanda il silenzio o il pudore a chi soffre, perché dominata dalla visione del guerriero, incitato da madri e mogli a essere impietosamente insensibile: chi geme e si lamenta mina il suo coraggio, gli apre il cuore alla sofferenza, perché stimola l’empatia, la compassione, un investimento emotivo quanto mai costoso, anche se del tutto naturale. Darwin, nel suo studio sulle espressioni naturali dell’uomo, ne fu diretto testimone nel comportamento del figlio:
Pochi giorni dopo che aveva compiuto sei mesi, la sua bambinaia fece finta di piangere, e io vidi che immediatamente la sua faccia prese un’espressione triste, con gli angoli della bocca fortemente abbassati; ora era difficile che questo bambino avesse visto frequentemente un altro piccino piangere, e certamente non aveva mai visto piangere un adulto; d’altra parte ho molti dubbi che a una così tenera età potesse aver ragionato su questo argomento. Perciò tendo a pensare che debba essere stato un sentimento innato a fargli capire che il pianto simulato della sua bambinaia esprimeva afflizione; e ciò gli procurava dispiacere per un istintivo sentimento di simpatia e partecipazione[26].
Se è così spontaneo e immediato “soffrire con chi soffre”, è meglio sopprimere quel turbamento, magari insegnando il pudore verso il proprio dolore o addirittura allenare a resistervi muti e pazienti. Come diceva Seneca, non siamo al mercato, ma nell’accampamento della vita. Se il dolore fosse sempre stato nel mercato, nell’interazione sociale, forse si sarebbe arrivati ben prima ad avere l’esigenza di misurarlo. Sembra strano che generazioni di medici, sin da Ippocrate[27], abbiano tardato tanto a sentire questa esigenza. In fondo, il dolore è rimasto sì sulla piazza, ma come una merce su cui conviene non mettere il prezzo, lasciandola all’arbitrio e alla speculazione[28]. Fino a quando non s’è deciso ch’era meglio non mostrarla affatto. Questa sarebbe la fine toccata a varie emozioni in quel “processo di civilizzazione” che ha riguardato principalmente il Medioevo e il Rinascimento, secondo il sociologo Norbert Elias[29].
Si potrebbe dire che al dolore si applichi per converso quel che chiamerei la “tragedia dei mali comuni”, in analogia con quanto in economia è detto “tragedia dei beni comuni”, che appartengono alla collettività e di cui ognuno può godere, pertanto «esposti al degrado e alla distruzione in seguito a processi di usura senza risarcimento da parte di attori egoistici»[30]. Beni materiali come l’aria, l’acqua, ma anche immateriali, come la sicurezza, la legalità, rischiano di finire preda di un bieco sfruttamento, solo perché sono di tutti e senza un prezzo definito.
Il dolore, a prescindere dalla sua funzione fisiologica di allerta, non è certo un bene dal punto di vista psico-sociale, ma ha pur sempre un valore in quella che ErvingGoffman chiamava La vita umana come rappresentazione, dal titolo del suo capolavoro[31]. Le attuali aberrazioni mediatiche, classificate come “spettacolarizzazione del dolore”[32] – sfruttamento della sofferenza a fini di varia convenienza: aumentare l’audience ed eventualmente le donazioni – si fondano sulle dinamiche esistenziali in cui il dolore è usato come leva o strumento di pressione. Ben noto è il potere di chi si trasforma in salice piangente, solo per estorcere qualche concessione[33]. Il dolore è un male comune e quindi si presta a essere scambiato, usato come merce, arma di ricatto, deterrente, mezzo di ritorsione, persuasione, blandimento.
Il dolore è merce corrente e preziosa, basti osservare con che frequenza e facilità s’insinua la minaccia di una violenza, di una tortura, per ottenere o evitare. Adam Smith direbbe alto il suo valore d’uso e peraltro vago il suo valore di scambio, destinato a rimanere incerto. In altre parole, il dolore è scambiato nei rapporti umani e se ne riconosce il peso, ma poi si finisce per trattarlo come una massa invisibile, pronta a dileguarsi non appena la si volesse quantificare. Gli tocca la sorte delle emozioni, confinate nella gabbia dorata dell’intensità[34]: si dice d’aver tanto patito, ma nessuno farebbe cambio a cuor leggero tra il proprio e l’altrui dolore. Meglio allora mascherarlo, addirittura nasconderlo, perché è contagioso, fa appello alla naturale reazione di vicini e lontani e se i primi sono chiamati alla responsabilità, a farsi carico del dolore, i secondi ne possono approfittare, vedendovi un segno di debolezza. Da qui il pudore di chi non vuole “obbligare” i vicini alla compassione e il timore d’essere sorpresi deboli dai lontani. Non essendo poi misurabile, quand’anche si volesse rispondere al suo richiamo, si cadrebbe nell’imbarazzo, meglio allora circondarlo con una cortina di pudore. Se poi nei funerali – in cui il lutto, il dolore è d’obbligo esibirli – allora conviene affidarsi al mestiere delle prefiche[35], perché dal loro numero, dall’efficacia della loro recita, come oggi dalla ricchezza di decorazioni floreali, si possa fare una stima del dolore versato.
In una situazione di semi-clandestinità, il dolore non può assumere un valore di scambio, se non in situazioni-limite, come le iniziazioni, dove con sofferenze rituali e graduali s’accede a un beneficio stabile e definito, oppure nella faida, in cui il meccanismo della vendetta regola la distribuzione dei dolori, secondo il principio “occhio per occhio, dente per dente”. Il titolo della commedia di Shakespeare, Misura per misura, esprime la legge del taglione, cioè il fatto che si restituisca una pena equivalente a quella causata, infatti lextalionis deriva da talis. La punizione deve arrecare un dolore talequale lo si è subito.
Per il resto vale per il dolore il cosiddetto dilemma del coccodrillo, di cui parla scherzosamente Luciano, nel suo dialogo I filosofi all’asta, dopo aver domandato al presuntuoso saggio stoico se abbia un figlio[36]:
Ammettiamo che un coccodrillo lo trovi mentre va a zonzo lungo il fiume e te lo rapisca e poi ti prometta di restituirtelo solo nel caso in cui indovinassi che cosa ha deciso riguardo alla restituzione del bambino. Che cosa dirai che ha deciso?
Il paradosso è in realtà una presa in giro, perché il filosofo, per quanto saggio, non ha modo di accertare che cosa abbia veramente deciso il coccodrillo, avendo solo la sua testimonianza. Anche il dolore, oltre le proverbiali lacrime di coccodrillo rimane, sfibrato da tanta incertezza, come carta moneta senza filigrana.
- La “filigrana” del dolore
Il mio approccio al tema del dolore sembra danzare sul filo sottile dell’antropologia filosofica fino a cadere nella sociologia, ma in realtà la prospettiva fondamentale resta filosofica, perché intende esplorare le relazioni interne che tengono insieme le tavole di questo ponte volante che è il nostro concetto di dolore. Non importa quanto elevato, è pur sempre una passerella sull’abisso della vita dolente, costruita per risolvere problemi d’ordine pratico, come gestire in modo conveniente un lutto o consolare il bambino che s’è fatto male, o al limite convincere noi stessi che la ferita non duole poi tanto.
I nostri concetti si formano a partire dall’uso in situazioni inizialmente semplici, nell’emergenza della ferita, appena dopo il grido di dolore e rimangono legati al modo della loro introduzione nello scambio linguistico. Una sorta d’imprinting che li accompagna. Per questo il convincersi o il convincere della leggerezza di un dolore o il dubitare del dolore stesso vengono sempre dopo l’abituale soccorso. A noi tutti è comune un contesto familiare, in cui i nostri genitori, o chi per loro, hanno consolato e curato il nostro dolore. Non riusciamo a trattenere un moto di stizza quando qualcuno – oggi che siamo adulti – osa mettere in dubbio la nostra pena. Rivendichiamo un’interiorità sofferente che non tollera dubbi, anche se non possiamo esibire una prova: «Ma non vedi?». Tuttavia, il gioco sottile della “coscienza” mia e altrui del dolore non ci sfiora, perché una frase come “SO di aver mal di denti” verrebbe solo come risposta a chi provoca con la sua sfiducia.
Zeno, nel romanzo di Italo Svevo, sente parlare un amico della «malattia che non dava dolore ma toglieva la forza»[37], avverte la sua pena di essere creduto «malato immaginario», lo ascolta protestare che l’ipocondriaco è «un malato reale, ma più intimamente di questi e anche più radicalmente».
Nella Coscienza di Zeno, si parla dei nervi di un malato immaginario, così malridotti «da accusare una malattia quando non c’era, mentre la loro funzione sarebbe consistita nell’allarmare col dolore e indurre a correre al riparo»[38]. Paradossalmente, la malattia può consistere nel non avere più una misura attendibile del dolore, rendendo così difficile verificarlo. Ma questo sarebbe stiracchiare il concetto, fino a renderlo praticamente inutilizzabile, perché «si crede che il dolore sia un fenomeno del tutto soggettivo e che quindi, almeno in tanti casi, sia difficile o addirittura impossibile obiettivarlo»[39]. Se il dolore è inquadrato a partire dalle sue cause e ragioni, si deve ammettere che riposi non tanto nelle remote profondità dell’io individuale, ma sui bordi aperti della ferita sanguinante.
Conviene perciò adottare una prospettiva metodologica mutuata da Wittgenstein, attenta ai contesti in cui si usa la parola dolore, i giochi linguistici, le occasioni fatte d’azioni e discorsi che mettono alla prova le nostre reti concettuali, per vedere se sono in grado di trasmettere un sapere condiviso.
Occorre quindi diffidare di certe estensioni dei nostri concetti, protesi che ci strappano dalle nostre consuetudini col mondo. Al riguardo, Wittgenstein avvertiva: «La sensazione che il fenomeno ci sfugga via, il costante fluire delle apparenze, non li avvertiamo mai nella vita comune, ma solo quando ci mettiamo a filosofare»[40]. Meglio rimanere legati all’uso ordinario della parolae invece provare a snidare «un pensiero suggerito da una falsa applicazione del nostro linguaggio»[41].
Opponiamo alla reticenza e al dubbio sul dolore l’esclamazione del grande Talleyrand, ormai ottuagenario, che disse al suo chirurgo, dopo aver sopportato con pazienza i tormenti di un’operazione: «Sapete che m’avete fatto davvero male?». Prima d’operare, il medico dovette far uscire il cane del suo paziente, che gli ringhiava contro. Neanche per l’animale il dolore era un mistero, forse annusava nell’aria l’odore degli eventi a venire. Il dolore non è il punto in cui lo spazio s’incurva, come una cisti purulenta, verso l’interiorità sofferente, tutto il contrario! Non è il passaggio dal mondo dell’estensione al mondo dell’intensità, come se con l’ago che buca la pelle si perdesse il contatto con lo spazio, per entrare in un mondo d’impercettibili qualità. Tutt’altro, il nostro concetto di dolore è uno spazio comune, nell’ambito del “diritto pubblico”, in cui non può valere l’opinione di Italo Mancini, che afferma in un suo saggio sulla filosofia del dolore: «il contributo definitivo sta nel disimpegno della filosofia», perché «non è un problema di definizione essenziale. Né nella definizione di Dio, né in quella di cosmo, né in quella di uomo entra il dolore. Esso è un fatto che fa irruzione nella storia dell’uomo, nella sua esistenza. […] La filosofia non può fare altro, dopo aver fatto tutto, che additarlo. La teologia del dolore è l’ultima parola della filosofia del dolore»[42].
La filosofia, sempre riprendendo la lezione di Wittgenstein, non si pone tanto il problema di definire, quanto di ricordare a noi stessi cosa saremmo normalmente disposti a dire riguardo a fenomeni generalmente noti. Si resta nell’ambito della descrizione, che non disdegna la storia, dove anche le irruzioni devono pur segnare un percorso, un concetto all’interno di una civiltà. Sarebbe “cattiva filosofia”, che non rende giustizia alla storia, allo sforzo secolare d’allentare le umane catene, indicare troppo frettolosamente un disimpegno – a favore della teologia – sul tema del dolore o indulgere nel “dolorismo”[43], alla stregua di Buytendijk[44]:
Per quanto grande possa essere, e giustificata, la gloria che la medicina, con pieno diritto, riceve per l’aumento del suo potere sul dolore fisico; per quanto possa andar fiera di questo successo che risparmia il dolore a innumerevoli esseri, ridona il benessere soggettivo, aumenta la capacità di lavoro, rende sopportabile la malattia, diminuisce il terrore della morte, tuttavia queste possibilità della medicina hanno spostato la problematica del dolore, la domanda che intelletto e cuore pongono sul suo significato, dalla sfera metafisica, morale e religiosa, a un campo del tutto materiale. Oggi chi soffre dolori intensi e continui pensa a imperfezione di tecnica, a scarsa prudenza, a trascuratezza, o a soccorso medico troppo tardivo.
Invitare chi soffre a spostare l’attenzione sulla «sfera metafisica, morale e religiosa» sarebbe una scorciatoia troppo comoda, a fronte della secolare inadeguatezza dei mezzi umani nella lotta contro il dolore. Il pensiero che «la teologia del dolore è l’ultima parola della filosofia del dolore» potrebbe far inclinare a facili rassegnazioni e rallentare la ricerca di una soluzione tecnicamente umana.
Il discorso sul dolore e quindi la sua filosofia dovrebbero restare tenacemente aggrappati alla dimensione propria del fenomeno, che è neurobiologica e quindi medica. Si viola il principio d’identità, se trattando del dolore si evade un problema e si pone quello del “senso del dolore” per ogni sofferente. «Il dolore è dolore», come ricordava Cicerone[45], non un’altra cosa, come avrebbe aggiunto Wittgenstein, che amava il detto di Joseph Butler: «Ogni cosa è ciò che è, e non un’altra cosa». Dire che il patire è un fenomeno umano, solo dal momento in cui si pone per la coscienza, fa sì che la dimensione fisica del dolore si carichi del suo doppio metafisico, un peso così enorme da esserne sopraffatta. Così avvenne tra Don Giovanni e il Gran Commendatore. Il seduttore doveva essere non solo vizioso, ma anche assassino: una condanna netta e plausibile, per metterlo definitivamente a tacere. Tuttavia, Mozart seppe dosare con sapienza le apparizioni del colosso, il tempo “serioso” della morale avrebbe turbato la musicalità del Don Giovanni e la leggerezza dell’estetico. Lo aveva ben notato Kierkegaard nel suo commento all’opera.
Il dolore e la sua filigrana appartengono all’ambito neurobiologico, rifuggendo dalla tentazione che il senso sia da cercare nel doppio, nella coscienza del dolore. Sono qui in disaccordo con quanto Natoli dice nel suo libro già citato: «La neurofisiologia del dolore è quindi una delle modalità con cui si decide di far apparire il dolore»[46]. Se così fosse e non fosse invece la prima modalità, Natoli dovrebbe spiegare che cosa intende con “familiarità col dolore”, quando dice che «la familiarità col dolore precede ogni tipo di spiegazione che si può fornire su di esso». Credo che tale familiarità non possa andare oltre il limite dell’evidenza, che è di tipo neuro-fisiologico e qui sto parafrasando Wittgenstein, quando dice che «col linguaggio non si può andare oltre la possibilità dell’evidenza»[47]. Del resto, Natoli ha detto in precedenza che «la grecità guadagna per induzione il principio» che nessun uomo va esente dal dolore e ribadisce che la familiarità viene dalla ricorrente esperienza che si fa abito e poi «comune ragione»[48]. Se per Natoli non si tratta di una «cifra statistica», la familiarità di cui parla può solo essere l’evidenza empirica depositata nei discorsi che da sempre facciamo sul dolore.
Allo stesso equivoco si presta E. Severino, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 15/7/1991, dal titolo Il dolore dipende dai pensieri umani, in cui scrive: «Il nostro dolore è coscienza del dolore, unione di patimento e di coscienza, e quindi il modo in cui esso si configura – non solo quello dell’anima, ma anche quello del corpo – dipende dal modo in cui ne siamo coscienti, lo valutiamo, lo vediamo in rapporto alla nostra esistenza. Dunque dipende da ciò che il sofferente crede di essere»[49].
Allargare lo sguardo sul “fenomeno” del dolore, accogliendo il “noumeno” che insiste su di esso, cioè l’insieme delle credenze che a esso si accompagnano, sembra necessario – che cosa è una qualsiasi cosa prima che abbia senso per la coscienza? – e per certi versi un progresso. In altreparole, considerare l’aspetto cosciente della nostra umanità dolente – la riflessione sul dolore – sembra la mossa decisiva per catturarne l’essenza[50]. Dire poi che la scienza ben conosce l’effetto placebo e l’influenza che l’intenzionalità del vissuto può avere sulla percezione del dolore non aiuta a distinguere inter et inter, come direbbe Kierkegaard. Il fatto che la fede possa aiutare a sopportare il dolore, o addirittura ne attenui la percezione, non autorizza a occultare o trascurare l’aspetto più primitivo dell’umano patire.
Per questo accolgo le opportune distinzioni fatte a proposito del dolore da Antonio Damasio, nel suo libro Emozione e coscienza[51]:
Quali sono le cose che si possono considerare emozioni? Il dolore? Il riflesso di trasalimento? Nessuno dei due, in effetti, ma perché? […] Il dolore è la conseguenza di uno stato di disfunzione locale in un tessuto vivo, la conseguenza di uno stimolo – un danno ai tessuti, imminente o effettivo – che causa la sensazione di dolore, ma provoca anche risposte regolatrici quali i riflessi e può indurre emozioni per conto suo. In altre parole, le emozioni possono essere causate dallo stesso stimolo che causa il dolore, ma sono un diverso risultato di quella stessa causa. Dopo, possiamo arrivare a sapere che abbiamo dolore e che stiamo avendo un’emozione associata al dolore, a patto che la coscienza sia presente.
Damasio distingue tra le «configurazioni neurali di tessuto danneggiato» e il nostro «sapere di avere un dolore». Perché si possa parlare di conoscenza del dolore occorre «qualcos’altro che avviene dopo che le configurazioni neurali che corrispondono al substrato del dolore – i segnali nocicettivi – sono comparse nelle aree appropriate del tronco encefalico, del talamo e della corteccia cerebrale, generando un’immagine di dolore, una sensazione di dolore»[52]. Questo “dopo” si riferisce, secondo l’autore, a un processo biofisico che ha luogo nel cervello e che collega le configurazioni neurali del tessuto danneggiato con quelle che si riferiscono a noi stessi, in modo tale che ne emerga una terza, relativa a noi che conosciamo il nostro stato, in altre parole la coscienza.
Damasio fa notare che già l’organismo e non il soggetto cosciente è in grado di gestire una serie di risposte utili al danno che produce dolore, riflessi che si possono osservare anche in pazienti comatosi, dalla coscienza sospesa[53]. Si può quindi parlare di una reale distinzione tra «il dolore in quanto tale» e l’«emozione causata dal dolore»[54], in modo tale che la medicina può attualmente intervenire a ridurre la seconda, pur rimanendo la percezione del danno ai tessuti, col risultato di sopprimere la sofferenza connessa a quest’ultima[55].
L’autore, sullo spunto di un suo collaboratore, Pierre Rainville, parla dello scopo adattivo del dolore attraverso una metafora: «È come una guardia del corpo piazzata davanti a una casa mentre si ripara una finestra rotta»[56].
Per questo «il dolore è in linea con la punizione ed è associato a comportamenti quali l’allontanamento e l’irrigidimento» ed è noto che «la punizione fa sì che gli organismi si chiudano in se stessi, irrigidendosi e allontanandosi».
Come osserva Buytendijk[57], la parola pena, derivante dal latino poena, che ha un riflesso in varie lingue, significa originariamente “punizione, tormento”. A voler dire che la metafora della guardia del corpo rimanda facilmente a chi l’avrebbe comandata e la finestra rotta al responsabile di quel vandalismo. Violenza e sadismo nel secondo caso, cura e protezione nel primo, segno dell’invincibile tendenza a introdurre finalismi di ogni genere nella nostra ermeneutica esistenziale, che fa dire sempre a Buytendijk[58]:
Il dolore non è allora l’abbaiante cane da guardia della nostra salute, ma il grido di indignazione per un oltraggio all’ordine, perché non si può offendere una legge di natura, ma una norma e una legge che viene rispettata come norma, sì. Così l’analisi del dolore ci insegna, che il vitale va inteso come il particolare modo di apparire di un ordine morale piuttosto che all’inverso la morale vivente come una specializzazione del vitale nella sua legalità.
L’autore compie in tal modo una metábasiseisállogénos, rovesciando il “regno della natura” in un “regno dei fini”, per usare una terminologia kantiana[59]. Il “fenomeno” del dolore non è più la reazione primitiva a certi stimoli, ma la reazione emotiva a un’ingiustizia che la persona sofferente avverte come pena per una colpa. Una mossa tanto azzardata quanto il buttarsi in acqua prima di avere imparato a nuotare, cioè trascurando i fondamentali, per dare a vedere il proprio coraggio. Il fatto che ci siano persone capaci di sprezzo del pericolo e del dolore non cambia la sostanza del discorso e affermare, come fa Mancini, che il dolore non rientri nella definizione di uomo, perché retaggio dell’irruzione del peccato nella storia, vuol dire andarsi a ficcare, come certi impavidi uccelli in Egitto, direttamente tra le fauci del coccodrillo, confidando nelle imperscrutabili “norme” del cervello rettile. Il dilemma del coccodrillo dimostrava non solo l’imprudenza di confidare nelle intenzioni, ma anche l’inaffidabilità di ogni discorso basato sulle mere credenze[60], che rischiano di essere confuse con regole del gioco.
- La simbolica del dolore
Non è a caso che per indicare il parossismo del dolore si dica “soffrire come un cane”, ma anche “soffrire le pene dell’inferno” (cfr. souffrircomme un damné in francese). Dando credito a Otto Weininger e alla sua “simbolica universale”, il cane è il paradigma del delinquente, cioè dell’uomo «che continua a commettere il peccato originale e lo fa “persistere”, senza sforzarsi di vincerlo e liberarsene. Il benessere terreno conta per lui più di ogni altra cosa»[61], perché è privo di una «“volontà di valore”», «vive l’intera vita senza un’autentica “unità della coscienza”, senza un io stabile e unitario che sappia tutto quello che fa e se ne assuma la responsabilità; il delinquente “si sgretola” (i delitti che compie sono gli espedienti estremi per “tenersi unito”)». A leggere le sue pagine di “psicologia animale”, si trova che Weininger, tratteggiando la figura del delinquente, aveva in mente proprio Don Giovanni: «L’assassinio è l’ultima cosa che il delinquente possa fare, il suo mezzo estremo di affermarsi in quanto delinquente ... Un surrogato dell’assassinio è il coito, e solo un confine ristretto separa Don Giovanni dall’assassino»[62]. C’è da chiedersi se tutta la negatività del seduttore come dissoluto non abbia una radice ben più remota. Questo cane così cocciuto e amaramente bastonato altro non è che la figura del corpo, che ama trastullarsi nella sua incoscienza, nella sua “disintegrazione” e non teme affatto di “sgretolarsi”, come direbbe Weininger. «Don Giovanni deve avere donne in continuazione, per non prendere coscienza di sé ... D’altronde il delinquente è del tutto privo di “vita” interiore, è come “morto”; prima di uccidere gli altri, si comincia con l’uccidere se stessi. Per questo egli non conosce veramente né il “piacere” né il “dolore”»[63].
Ma alla fine, di quale assassinio si è macchiato il corpo? Forse la sua unica colpa è quella di abitare il paese delle “piccole percezioni” incoscienti, di cui parlava Leibniz, di abbandonarvisi totalmente in certi momenti, come nel coito, a detta d’Aristotele[64]: «Inoltre, i piaceri sono un ostacolo alla riflessione morale, e tanto più quanto più intenso è il godimento, come nel piacere sessuale: nessuno, infatti, potrebbe pensare alcunché mentre lo prova».
Anche un terribile mal di denti può strapparci a noi stessi, può “rubarci l’anima” e consegnarla alla marea di piccole percezioni fattasi insopportabilmente pungente. Per non essere travolto da quell’onda, il saggio stoico predispone un “equipaggiamento” (paraskeue)[65], un’armatura che lo protegga dagli eventi. C’è tuttavia un prezzo da pagare a questa raggiunta apatia, insieme alle torbide passioni se ne va pure la compassione, la misericordia, che segue il destino di tutti “i moti d’animo”[66].
Diceva Montaigne – e lo ribadirà Pascal – che «la nostra vita non è se non movimento»[67] e perciò Leibniz[68] concluderà che ci sono «in noi a ogni momento un’infinità di percezioni, senza appercezione però, e senza riflessione»[69], sono «il legame che ciascun essere ha con tutto il resto dell’universo»[70], perciò non si può imputare al nostro corpo di non avvertire il rumore d’ogni onda, quando sulla spiaggia si sente il mare frangersi sulla battigia[71]. Attiviamo la nostra riflessione solo quando qualcosa attira l’attenzione, ma le infinite e continue piccole percezioni causano in noi uno stato d’agitazione permanente[72], un’inquietudine che «differisce dal dolore se non come il piccolo dal grande»[73].
Diciamo che il dolore veste i panni del soldato romano, che Archimede invitò a non distruggere i suoi cerchi[74]. In realtà sono anche i nostri – la coscienza è la nostra persona, «superiore a ogniprezzo, e non ammette nulla di equivalente, ha una dignità», secondo Kant[75] – ma siamo comunque esposti alle piccole percezioni, che agiscono su di noi come tante sollecitazioni, lievi impedimenti da cui ci liberiamo senza rendercene conto, mentre il dolore è l’ostacolo che richiede attenzione e sveglia la coscienza[76].
Antonio e Hanna Damasio hanno indagato come avvenga che noi “prestiamo attenzione” al nostro corpo[77], facendo notare che «spendiamo una buona parte delle nostre vite badando alle visioni e ai suoni del mondo esterno, dimentichi del fatto che noi (come menti) esistiamo nei nostri corpi, e che i nostri corpi esistono nelle nostre menti». Tale dimenticanza è dal loro punto di vista «sia buona che cattiva: buona quando ci permette di ignorare la nostra sofferenza fisica, cattiva quando ci separa dalle radici biologiche delle nostre coscienze». È vero, a volte è opportuno non dare troppo peso a qualche dolorino, la vita deve andare avanti, pur sapendo che disattendere certi sintomi potrebbe esserci fatale, ma il punto è che l’ideologia è sempre in agguato, con esiti sorprendenti. “Frate asino” – così chiamava San Francesco il suo corpo[78] – dev’esser pronto a portare la soma in silenzio e il peso della sua ignoranza, acutamente delineata da Bergson[79]:
Ogni dolore deve dunque consistere in uno sforzo, e in uno sforzo impotente. Ogni dolore è uno sforzo locale ed è questo isolamento stesso dello sforzo che è causa della sua impotenza, perché l’organismo, in ragione della solidarietà delle sue parti, è adatto soltanto agli effetti d’insieme. È anche perché lo sforzo è locale, che il dolore è assolutamente sproporzionato al pericolo corso dall’essere vivente: il pericolo può essere mortale e il dolore leggero; il dolore può essere insopportabile (come quello di un mal di denti) e il pericolo insignificante.
Il problema non è tanto che il dolore sia un segnale a volte sproporzionato, ma l’insidia del “doppio”, che mira a screditarne l’importanza o addirittura a ridurlo, come fecero gli stoici, a qualcosa di “indifferente”[80]. Il “miraggio spartano” fa sentire la sua voce di tuono e vorrebbe trattare il corpo alla stregua dello schiavo ilota, perché “lo sforzo impotente”, ha solo il torto d’essere umano, troppo umano. Gli schiavi di Sparta dovevano portare un copricapo di pelle di cane per distinguersi dai liberi[81] e il dolore è il cane che abbaia, smentendo, almeno in parte, la sentenza d’Esiodo sui mali scaturiti dal vaso di Pandora: «Le malattie, a loro piacere, si aggirano in silenzio di notte e di giorno fra gli uomini, portando dolore ai mortali; e questo perché l’accorto Zeus tolse loro la voce»[82].
Esiodo dava la colpa a Zeus, ma in realtà il dolore non fu eloquente perché gli mancò la libertà di parola, vittima di ciò che Michel Foucault chiama “bio-potere”, cioè un dispositivo, la coscienza, ideato per ottenere la subordinazione del corpo[83]. Secondo Balibar[84], quest’invenzione tipicamente europea risalirebbe a Locke piuttosto che a Cartesio e al suo “cogito”. Infatti, la coscienza lockiana è buona amministratrice di conoscenze e passioni, invece che sostanza pensante. Perciò trova un buon precedente nell’hegemonikon degli stoici[85], tradotto dai latini con principatus animi: quella parte razionale di noi che è “capace di comandare”, una sorta di «polpo che estende i suoi otto tentacoli dal centro alla periferia dell’individuo»[86].
L’implacabile sovrintendente degli stoici teme di farsi condizionare da un cane che s’agita alla sua porta e non vorrebbe chiamarlo “male”, anche se la sofferenza che esprime «è pur sempre aspra, contro natura, difficile a sopportarsi, triste, aspra»[87]. Non vuole noie nel suo locale, sarebbecompromessa la possibilità di una saggezza e virtù intesa come “perfezione della ragione”. Il dolore fisico può divenire male solo nell’opinione errata di chi smette di considerarlo “indifferente”.
Gli stoici hanno così rigettato l’accorato appello degli epicurei a non buttare il bambino con l’acqua sporca: il piacere, per questi ultimi, va amorevolmente svezzato e condotto alla necessaria maturità, mentre il dolore deve essere meglio compreso: «Un dolore moderato è trascurabile, mentre uno grave non è duraturo»[88]. Il dolore è sempre un male, ma non tutti i dolori sono da evitare: «Il saggio, dice Epicuro, deve mettere tutto sulla bilancia, in modo da evitare il piacere se questo deve portargli un dolore più grande, e da sottomettersi al dolore nel caso che esso produca più considerevole piacere»[89]. Si tratta di un’aritmetica più sofisticata della banale eliminazione del dolore, un fine che Lattanzio pensava degno di «filosofi costretti a rimanere a letto», che già «un medico sarebbe in grado di procurare»[90].
- Conclusione
Come s’è visto, la cultura occidentale del dolore è stata profondamente influenzata dal principio di ragione stoico, l’egemonico, che si oppone a quanto le nuoce. Il dolore può divenire un pericolo quando ottiene l’adesione della volontà e diviene passione dominante, che prende il controllo al posto della ragione[91].
Tuttavia, anche gli stoici hanno ammesso che, prima di giungere alla dimensione dell’assenso e divenire passione, eccesso e quindi turbamento dannoso, il dolore è perturbazione involontaria dei sensi, ciò che chiamano “pre-passione” (propatheia)[92]. Di questa commozione corporea non siamo responsabili, perché non tocca ancora il livello in cui si forma razionalmente la falsa opinione, con cui ci lasciamo andare a quel moto dell’anima.
Per meglio comprendere che cosa intendessero, basta seguire l’esperienza vissuta da Seneca nella cryptaNeapoletana. Il filosofo descrive «una scossa e un cambiamento non angoscioso, ma provocato dalla novità e dall’orrore di una situazione insolita»[93]. Nella grotta tufacea scavata nella collina di Posillipo, che paragona a una lugubre prigione, il buio e la polvere hanno messo a dura prova la sua sensibilità, ricordandogli che «vi sono emozioni […] che nessun tipo di coraggio riesce a sfuggire», perché si tratta di «una reazione naturale, non dominabile dalla ragione».
Questa propassio – alla latina– sembra essere la vera “massa mancante” nei complicati rapporti tra coscienza e dolore, perché ci lega come il sorriso di un neonato, a cui è spontaneo rispondere con un altro sorriso. Oppure come il finto pianto della bambinaia di Darwin, che suscitò commozione nel figlioletto. Sembrano masse invisibili e misteriose quelle che ci spingono continuamente e a volte ci legano, perché non si muovono sempre attraverso la coscienza, ma a volte la pungono e la svegliano solo tardi, quando ormai il danno è fatto.
La coscienza è giustamente preoccupata di affermarsi come “fine in sé”, di rivendicare il proprio valore intrinseco, la sua dignità, «superiore a ogni prezzo», come diceva Kant. D’altro lato, «ciò che concerne le inclinazioni e i bisogni generali degli uomini ha un prezzo di mercato»[94] e il dolore rientra in questo capitolo di spesa, il debito che paghiamo alla nostra sensibilità. Si può paragonare questa esposizione al dolore a una “clausola di forza maggiore”, che nel commercio internazionale permette a una parte di esimersi dal proprio obbligo contrattuale, qualora intervengano impedimenti straordinari, tra i quali rientrano i cosiddetti “atti di Dio”.
La coscienza, dall’alto della sua dignità, ha spesso fatto valere la suddetta clausola. Non amando sentirsi esposta nel dolore, ha chiesto l’esonero dal contratto che la lega al corpo, attribuendo i suoi malanni, il dolore che ne consegue a forze indipendenti dal suo potere. Ciò che può essere vero in parte è stato elevato a filosofia di vita, come nello stoicismo, dove tutto è ricondotto al Fato. Gli stoici lasciarono indeterminato il prezzo di mercato del dolore, dichiarandolo “non-preferibile” (apoproegmenon)[95], una diagnosi che emerge chiaramente da questa osservazione di Plutarco su Zenone: «Alcuni autori antichi hanno detto che a Zenone è capitata la stessa cosa che capita a un uomo che possiede un cattivo vinello, che non può esser spacciato né come aceto, né come vino; infatti il suo “preferibile” non trova compratori, né come bene, né come cosa indifferente»[96].
Se il dolore non è male, perché conta anzitutto la dignità della coscienza, con la sua facoltà dell’esonero, allora si può anche trascurarlo, più facilmente negli altri che in sé stessi. Termino con una citazione da Latour, di cui sono debitore, anche per l’esergo butleriano[97]:
Stamattina presto ero di cattivo umore e ho deciso di infrangere la legge e avviare la mia auto senza allacciarmi la cintura di sicurezza. La mia auto di solito non vuole partire prima che io allacci la cintura. Dapprima fa lampeggiare una luce rossa «ALLACCIATE LE CINTURE!», quindi emette un segnale acustico; è un suono così elevato, implacabile, ripetitivo, che non posso sopportarlo. Dopo dieci secondi, impreco e allaccio la cintura. Questa volta ho sopportato il suono per venti secondi e quindi mi sono arreso. Il mio umore era alquanto peggiorato, ma ero in pace con la legge, perlomeno con quella legge. Ho desiderato infrangerla ma non ci sono riuscito. Dov’è la moralità?
La storia dei travagliati rapporti tra la coscienza e il dolore è anche la storia di un eroe misconosciuto, la cui meccanica moralità è stata oscurata dall’insopportabile pignoleria.
[1]G. Gronda e P. Fabbri (a cura di), Libretti d’opera italiani, dal Seicento al Novecento, Mondadori, Milano 1997, p. 830.
[2]Ibid., p. 831.
[3] S. Kierkegaard, Enten-Eller, Adelphi, Milano 1987, t. I, p. 201.
[4]Ibid., p. 199.
[5] G. Gronda e P. Fabbri (a cura di), op. cit., p. 840.
[6]Ibid., p. 841.
[7] J.P. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi, Torino 1978, pp. 343-358; M. Niola, Il purgatorio a Napoli, Meltemi, Roma 2003, pp. 13-84 e p. 87 n. 29.
[8] G. Ceronetti, Il silenzio del corpo, Adelphi, Milano 1987.
[9] P. Veyne, La famille et l’amour sous le Haut-Empire romain, in«Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 1978, 33, 1, pp. 35-63,p. 55.
[10] È merito di Michel Foucault (si veda L’uso dei piaceri, Feltrinelli 1984 e La cura di sé, Feltrinelli, Milano 1985) avere attirato l’attenzione sulla sostanziale continuità tra quella che lo storico Jacques le Goff chiama “la grande rinuncia”, la repressione delle ragioni del corpo nel Medioevo e la dottrina stoica, si veda J. Le Goff, Il corpo nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 14-15, 22 sgg.. Sul tema anche V. Fumagalli, Solitudocarnis. Vicende del corpo nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1990; G. Mura e R. Cipriani (a cura di), Corpo e religione, Città Nuova, Roma 2009.
[11] J. Le Goff, Un lungo Medioevo, Dedalo, Bari 2006, pp. 103-117.
[12] Max Scheler ha parlato dell’uomo come “asceta della vita” in La posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di G. Cusinato, Franco Angeli, Milano 2000 e Arnold Gehlen ha teorizzato la funzione dell’”esonero” rispetto alle pulsioni istintive, in L’uomo, Feltrinelli, Milano 1990.
[13] «Francesco non ha cercato sistematicamente di umiliare il corpo», J. Le Goff, San Francesco d’Assisi, Laterza, Bari 2000, p. 32.
[14]Fonti Francescane, Messaggero, Padova 1980, Leggenda maggiore di san Bonaventura da Bagnoregio, V, 4, p. 873.
[15]Oeuvres complètes d’Ambroise Paré, J.-B. Baillière, Paris, 1840, vol. II, Operations de Chirurgie, XXVI, p. 443.
[16] M. Foucault, L’ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino 2001, pp. 13-14.
[17] Plutarco, Consolazione alla moglie, a cura di Manfredini M., M. D’Auria Editore, Napoli 1991, p. 59.
[18] M. Montaigne, Saggi, a cura di V. Enrico, Mondadori, Milano 1997, vol. II, XXXVII, p. 806.
[19] W. Shakespeare, Teatro, trad. e note di C. Vico Ludovici, Einaudi, Torino 1960, vol. IV, atto IV, scena III, p. 619.
[20] F. Ollier, Le mirage spartiate, Arno Press, New York 19733.
[21] P. Hadot, La cittadella interiore: introduzione ai “Pensieri” di Marco Aurelio, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 15.
[22] Seneca, Lettere morali a Lucilio, a cura di F. Solinas, Mondadori, Milano 2007, XVI, 96, 5, p. 753; R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Rizzoli, Milano 1991, § 1633, p. 730.
[23] Cfr. R. Tosi, op. cit., § 40, p. 20. Cfr. M. Isnardi Parente (a cura di), Gli Stoici. Opere e Testimonianze, Utet, Torino 1989, p. 28 n. 47 e p. 138; G. Moretti, Acutumdicendigenus: brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli Stoici, Bologna, Patron 1995.
[24]Protagora (343 a-c), trad. di E. Turolla, I Dialoghi, Rizzoli, Milano 1964, vol. 1, p. 441.
[25] Cfr. R. Tosi, op. cit., §1671, p. 745.
[26] C. Darwin, L’espressione delle emozioni, Bollati Boringhieri, Torino 1999, c. XIV, p. 384.
[27] «Bisogna scavare negli anditi più riposti di quella vasta biblioteca che è il Corpus hippocraticum per trovare delle indicazioni sulla sofferenza del malato durante le operazioni», J. Jouanna, Ippocrate, SEI, Torino 1994, p. 128. Segno che forse è meglio lasciare la misura del dolore nell’indeterminatezza, per evitare di farsene carico?
[28] Sul dolore esibito nel Medioevo, le penetranti osservazioni di J. Huizinga, L’autunno del Medio Evo, Sansoni, Firenze 1944, pp. 61ss.
[29] N. Elias, Il processo di civilizzazione, Il Mulino, Bologna 1988.
[30] C. Donolo, L’intelligenza delle istituzioni, Feltrinelli, Milano 1997, p. 22.
[31] E. Goffman, La vita umana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969.
[32] S. Natoli, L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 374 e 382; L. Boltanski, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000.
[33] R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino 1979, pp. 159-161.
[34] In questa gabbia pare confinarla Bergson nel suo Saggio sui dati immediati della coscienza, Boringhieri, Torino 1964.
[35] Si veda l’adagio di Erasmo: praeficarum more, 4055 (V, I, 55).
[36] Luciano, I filosofi all’asta. Il pescatore. La morte di Peregrino, a cura di C. Ghirga, R. Romussi, Rizzoli, Milano 2004, p. 73.
[37] I. Svevo, La coscienza di Zeno, Giunti, Firenze 1994, p. 165.
[38]Ibid., p. 166.
[39] G. Giusti, Trattato di medicina legale e scienze affini, WoltersKluwer Italia 2009, vol. II, pp. 369 sgg.
[40] L. Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, Einaudi, Torino 1976, § 52, p. 38.
[41]Ibid., § 52, p. 8.
[42] G. B. Guzzetti, I. Mancini, C. Colombo, Il dolore nella morale nella filosofia nella teologia, Editrice Studium, Roma 1961, p. 45.
[43] V. Jankélévitch, L’austérité et la vie morale, Flammarion, Paris 1956, pp. 103 sgg.
[44] F. J. J. Buytendijk, Il dolore, Morcelliana, Brescia 1957, p. 7.
[45] Cicerone, Le Tusculane, a cura di A. Di Virginio, Mondadori, Milano 2010, II, 14, p. 161.
[46] S. Natoli, op. cit., p. 377.
[47] L. Wittgenstein, op. cit., § 7, p. 8.
[48] S. Natoli, op. cit., p. 73.
[49] Cfr. E. Severino, Sortite. Piccoli scritti sui rimedi (e la gioia), Rizzoli, Milano 1994, pp. 12-13.
[50] Lo spostamento dal dolore alla “coscienza del dolore” è una caratteristica dello stoicismo e in particolare di Crisippo, secondo cui il dolore sarebbe una «“una opinione attuale circa la presenza di un male”», M. Isnardi Parente (a cura di), op. cit., p. 456; cfr. p. 63 sulle passioni considerate “giudizi errati”, “false opinioni”.
[51] A. R. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000, pp. 93-94.
[52]Ibid., p. 95.
[53]Ibid., p. 96.
[54]Ibid., p. 97.
[55]Ibid., 99.
[56]Ibid., p. 101.
[57] F.J.J. Buytendijk, op. cit., p. 10 n. 6.
[58]Ibid., p. 133.
[59] I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 1990, sez. II, p. 66.
[60] Conviene qui ricordare la distinzione lockiana tra idee semplici e idee complesse, J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, a cura di M. e N. Abbagnano, Utet, Torino 1971, cap. VII, pp. 161 ss.
[61] O. Weininger, Delle cose ultime, Studio Tesi, Pordenone 1985, pp. 174-175.
[62]Ibid., pp. 181-182.
[63]Ibid., pp. 182-183.
[64] Aristotele, Etica Nicomachea, Milano, Bompiani 2000, VII, 11, p. 289.
[65] Si veda la riflessione di M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982), Feltrinelli, Milano 2003, pp. 209-10, 283-87.
[66] «I sapienti […] non sono compassionevoli né concedono perdono ad alcuno né rimettono le punizioni stabilite dalla legge (perché l’indulgenza, la compassione e la stessa condiscendenza sono il segno di un’anima debole che mostra una bontà affettata di fronte alle punizioni), né le credono troppo severe», Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Laterza, Roma-Bari 2003, vol. I, VII, 123, p. 285.
[67] M. Montaigne, op. cit., III, XIII; «La nostra natura è nel movimento; il riposo assoluto è la morte»; B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Mondadori, Milano 1973, 5, § 350, p. 205.
[68] G.W. Leibniz, Scritti filosofici, a cura di M. Mugnai ed E. Pasini, UTET, Torino 2000, vol. II, pp. 26-27, 165.
[69] G.W. Leibniz, op. cit., vol. II, p. 27.
[70]Ibid., p. 28.
[71]Ibid., p. 27.
[72] L. Basso, Inquietudine e politica in Leibniz, in «Isonomia», 2006; E. Naert, Uneasiness et inquiétude, «Les Etudes philosophiques», 1, 1971, pp. 67-76; J. Deprun, La philosophie de l’inquiétude en France au XVIIIe siècle, Librairie Philosophique, Vrin 2000.
[73] G.W. Leibniz, op. cit., vol. II, p. 29.
[74] R. Tosi, op. cit., §1203, p. 544.
[75] I. Kant, op. cit., p. 68.
[76] G.W. Leibniz, op. cit., vol. II, p. 165.
[77] A. Damasio, H. Damasio, Minding the body, in «Daedalus», 135, 3, 2006, pp. 15-22.
[78]Fonti Francescane, op. cit., V, 6, p. 875.
[79] H. Bergson, Materia e memoria, Città Armoniosa, Reggio Emilia 1983, p. 73.
[80] F. Prost, Les théories hellénistiques de la douleur, Peeters, Louvain 2004. p. 228. Cfr. G. Reale, Storia della filosofia greca e romana, Bompiani, Milano 2004, vol. 5, pp. 431-433.
[81] J.P. Vernant, Mortals and immortals. Collected essays, edited by F. I. Zeitlin, Princeton University Press, Princeton 1991, pp. 232ss.
[82] Esiodo, Le opere e i giorni, Rizzoli, Milano 1998, vv. 102-104, p. 99.
[83] M. Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 124 sgg.
[84] E. Balibar, L’invention européenne de la Conscience, in F. Eustache, B. Lechevalier, F. Viader, La Conscience et ses troubles. Séminaire Signoret, De Boeck Université, Paris-Bruxelles 1998, pp. 169-192.
[85] R. Brandt, John Lockes Konzept der persönlichen Identität. Ein Resümee, in «Aufklärung», 18, 2006, pp. 37-54: p. 38.
[86] R. Bodei, Geometria delle passioni, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 203-204.
[87] M. Isnardi Parente,op. cit., p. 189. Sono le parole con cui Cicerone, nelle sue Tusculane (II, 12, 29), descrive l’idea del dolore di Zenone, il caposcuola degli stoici.
[88] I. Ramelli (a cura di), Epicurea, Bompiani, Milano 2002, fr. 446, p. 627.
[89] Cicerone, Le Tusculane, op. cit., V, 33, 95, p. 455.
[90] I. Ramelli, op. cit., fr. 419, p. 609.
[91] F. Prost, op. cit., pp. 250, 252.
[92] F. Prost, op. cit., p. 230; M. Graver, Cicero on the emotions. Tusculan disputations 3 and 4, The University of Chicago Press, Chicago 2002, pp. 125-126.
[93] Seneca, Lettere morali a Lucilio, a cura di F. Solinas, Mondadori, Milano 2007, VI, 57, 3, p. 281.
[94] I. Kant, op. cit., p. 68.
[95] M. Isnardi Parente, op. cit., pp. 23-24; 192 e n. 205.
[96] D. Babut, Plutarco e lo stoicismo, Vita e Pensiero, Milano 2003, p. 373.
[97] B. Latour, Dove sono le masse mancanti? Sociologia di alcuni oggetti di uso comune, in «Intersezioni», 13, 2, 1993, pp. 221-255.